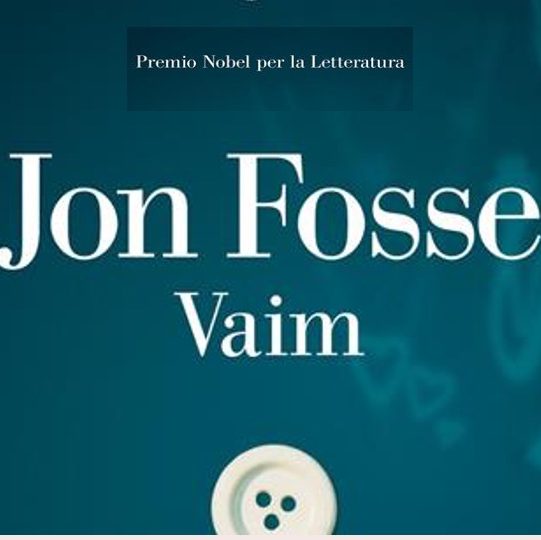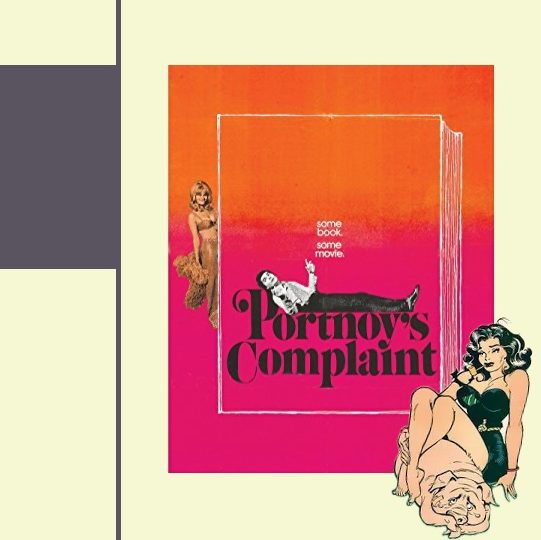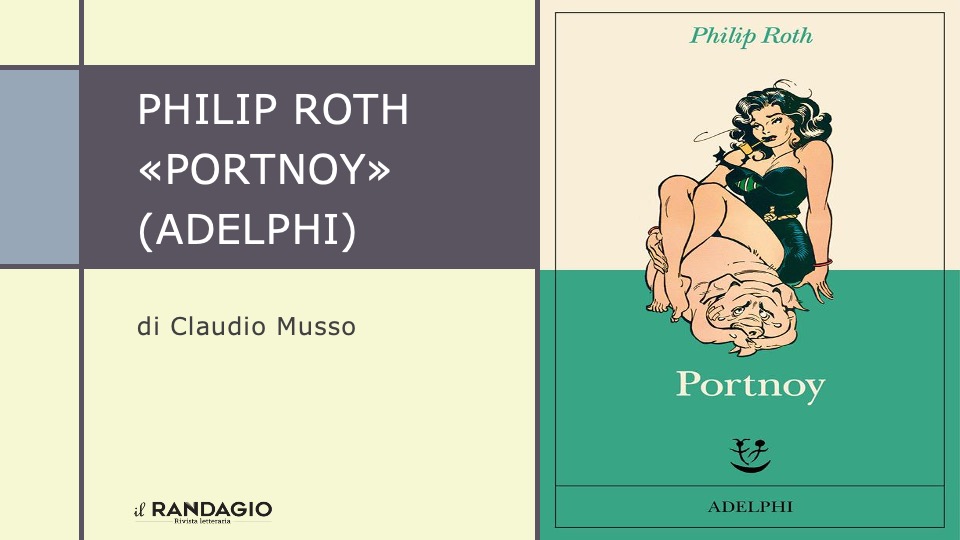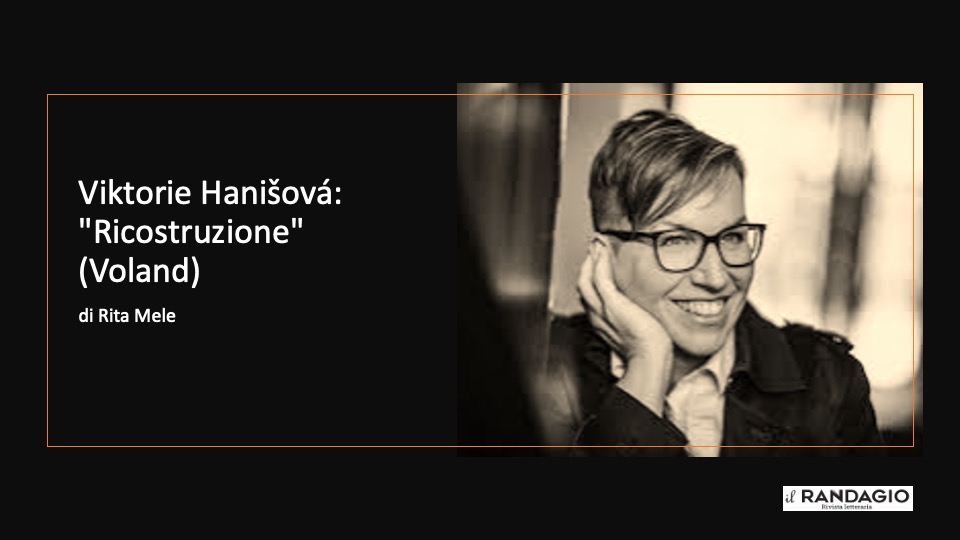Jon Fosse e la poetica del silenzio
Ci sono lettori che, finché non incontrano le pagine di un determinato autore, avvertono come una mancanza sottile ma insistente. Nonostante il Nobel del 2023, ero tra quelli che non avevano avuto il coraggio di affrontare il norvegese Jon Fosse, intimorito dalla sua fama di scrittore metafisico, “sacrale”, criptico e dalla mole piuttosto impegnativa del suo capolavoro, “Settologia”, articolato in sette parti e uscito in tre volumi. Negli ultimi tempi sto recuperando il ritardo e l’esperienza diretta della pagina mi conferma quanto sia elettrizzante la letteratura quando non ha neanche più bisogno delle parole e arriva alla sua essenza silenziosa. Così sono approdato a “Vaim”. Pubblicato ad ottobre scorso in Italia da La nave di Teseo e concepito per essere la prima tessera di una trilogia ambientata in un paese immaginario della Norvegia, “Vaim” è un romanzo breve, perfetto per un primo approccio alla poetica fossiana.

Come scrive Fosse? Proviamo a farcene un’idea dall’incipit:
“E così, ho detto, eccoci qua, ho detto accarezzandomi la barba, questa barba ormai ingrigita, giovane non lo ero più da un pezzo ma neppure anziano, in là con gli anni si sarebbe potuto dire, sì, un uomo in là con gli anni, né più né meno, e tra non molto sarebbero finiti anche questi viaggetti a far baldoria a Bjørgvin, tanto che senso aveva andarci, restare ormeggiati alla banchina del Molo di Bjørgvin, passare il tempo seduto nei bar e nei caffè, sì, soprattutto al Pennuto, come chiamavano il locale, ma anche al Mercato Coperto e all’Ultima Barca, e alla Caffetteria – senza mai fare nient’altro se non bazzicare posti come quelli o restarmene chiuso nella cabina della barca, […]”
Inizia così il primo di tre monologhi interiori, che si dilatano su poco più di cento pagine prive della macchia di un punto. Sono tre modulazioni diverse di un solo brano di musica iterativa che si diffonde rarefatto ipnotizzando l’ascoltatore. Le ripetizioni, le pause, i silenzi, ereditati dal Fosse drammaturgo e poeta, sono l’anima del testo, hanno uno spazio narrativo immenso e più efficacia delle parole stesse. Il lettore si abbandona al fluire della frase come i protagonisti si consegnano al destino delle loro coscienze flebili. Se in Settologia c’è un’unica voce narrante, qui i narratori sono tre, uno per ciascuna delle parti di cui si compone il romanzo; tre esistenze alterate, ferite e scosse dal passaggio di una donna, Eline, imprevedibile e determinata, vero fulcro dei loro racconti.
Nella prima parte parla Jatgeir, un pescatore solitario che da quand’era ragazzo non ha mai smesso di amare Eline senza mai trovare il coraggio di dichiararsi. Ha chiamato “Eline” anche la barca dove passa gran parte della sua vita. Lo seguiamo mentre attracca nel porto della città di Bjørgvin (Bergen) per comprare, a un prezzo che si rivelerà esorbitante, un ago e una spoletta di filo nero. Decide quindi di spostarsi verso il porticciolo di Sund, dove, dopo essere stato fregato una seconda volta, pensa di passare la notte a bordo. E, mentre sta per addormentarsi, nel buio, si sente chiamare dalla banchina proprio da Eline, l’amore mai dimenticato della sua vita che non vede da anni. Ha con sé una valigia e vuole andarsene subito via con lui per allontanarsi definitivamente dal marito. I due salpano la sera stessa e andranno a vivere insieme a Vaim. Potrebbe sembrare una storia d’amore a lieto fine e invece l’uomo è confuso da mille dubbi…

Il secondo capitolo tocca a Elias, l’unico amico di Jatgeir. È passato molto tempo dall’arrivo di Eline a Vaim e, dall’inizio della convivenza con il pescatore, i due amici non riescono più a incontrarsi. Elias può solo limitarsi ad osservare da lontano i cambiamenti nella vita di Jatgeir a causa della presenza della donna. Un giorno Elias sente bussare alla porta. Apre, gli sembra che non ci sia nessuno, finché ad un tratto gli appare Jatgeir, cosa che in seguito si rivelerà impossibile perché l’uomo è stato trovato annegato ben prima della sua apparizione. C’è un che di spettrale e di inquietante come in un racconto di Poe, un’eco delle storie di fantasmi – M. R. James o Edith Wharton – che sarebbe piaciuta a Borges…
Elias saluta l’amico morto:
“e alzo il braccio e lo saluto con un cenno della mano e lui alza a sua volta il braccio e ricambia il saluto e quasi con gioia mi dice che adesso sta bene e io, mentre cammino lungo la strada di Vaim, alzo la mano e faccio un saluto rivolto al cielo, verso il punto dove sento che si trova Jatgeir, e tutto mi sembra così giusto, chissà cosa penserà chi mi vede compiere quel gesto, ma tanto non c’è nessuno che sta guardando, be’, sì, a parte Jatgeir
Allora addio, Jatgeir, dico
E grazie per tutti i momenti che abbiamo trascorso insieme, dico
e vedo Jatgeir, vedo la sua mano e il suo braccio dissolversi nel cielo scuro”
Nella terza e ultima parte è Olav, il marito abbandonato nel primo capitolo, che ricorda l’incontro anni prima in una taverna con Eline (che in realtà si chiama Josefine e che comincerà a chiamarlo Frank… tutti i nomi in Fosse sono incerti come riflesso di personalità labili). Quell’incontro gli ha cambiato la vita perché la donna prima lo ha convinto a sposarla, poi lo ha lasciato per andare a vivere a Vaim con Jatgeir, salvo ritornare infine a casa da lui alla morte dell’uomo con cui era fuggita. Nel repertorio dei ricordi di Olav/Frank, l’immagine del peschereccio che si stacca dolcemente dalla terraferma e comincia a navigare nel mare calmo – “come se una pace si posasse su tutto” – è pura poesia. Prima di morire Josefine/Eline gli ha lasciato l’impegno di seppellirla accanto a Jatgeir ed Elias…
Fosse maneggia la realtà – la realtà che “galleggia su un mare di sogni” – con una delicatezza singolare. Non la aggredisce, non la seziona, non si arma di forchetta e coltello per nutrirsene. È un ascoltatore discreto che si fa da parte per liberarsi dei suoi personaggi, indietreggia e aspetta che emergano attraverso la scrittura. Scrittura che è come l’amore raccontato in queste pagine: funziona meglio con la distanza (una forma dell’impersonalità teorizzata da T. S. Eliot?). Siamo agli antipodi dell’autofiction, tendenza imperante della narrativa contemporanea e terreno di coltura di un’altra colonna della letteratura norvegese, quel Karl Ove Knausgård dall’io invadente, che peraltro è stato suo allievo.
Sono piccole storie evanescenti, intrise di quotidianità e di solitudine, scritte in una lingua, il nynorsk, parlato da poco più di mezzo milione di norvegesi. Racconti ambientati in microcosmi sperduti nella natura, come in una sorta di wilderness norvegese alla Faulkner: “Quel suono, quel ritmo della natura lo incarno in qualche modo in tutto ciò che scrivo. La musica della mia prosa e delle mie poesie è collegata a quel paesaggio”, ha detto in un’intervista. Narrazioni abitate da uomini sfocati e silenziosi, vittime impotenti del destino; personaggi avvolti nelle brume di un fiordo dove sotto la superficie di un mare apparentemente calmo si agitano correnti insidiose e imprevedibili. Storie narrate con una prosa bisbigliata, minimalista, decisamente beckettiana, con un timbro da dormiveglia, capace di incantare e travolgere il lettore con la sua vena misteriosa e melanconica. Se “assurdo” è l’attributo dell’opera di Beckett, nell’universo di Fosse la parola ricorrente è “strano”: “tutto era strano, sì, e sulla mia lapide, se dovessi riassumere la mia vita, potrebbe essere inciso proprio questo, sì, tutto era strano”. Tutto pare insolito anche al lettore al termine di “Vaim”; quella “strana” bellezza dà un brivido alla schiena, ti resta sul groppone ed è solo uno degli aspetti della rara grandezza di Fosse.
Gigi Agnano

Napoletano, classe ’60, è l’ideatore e uno dei fondatori de “Il Randagio – Rivista letteraria“, nato il 15 ottobre 2023, anniversario della nascita di Italo Calvino.