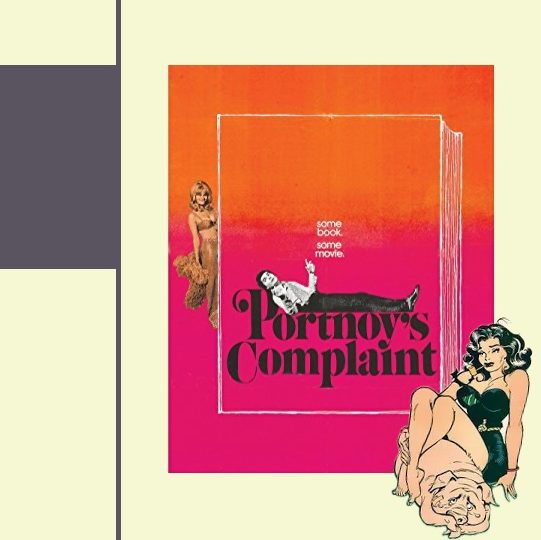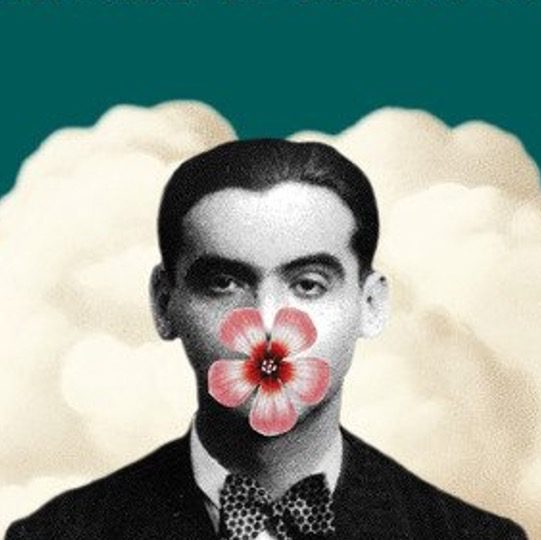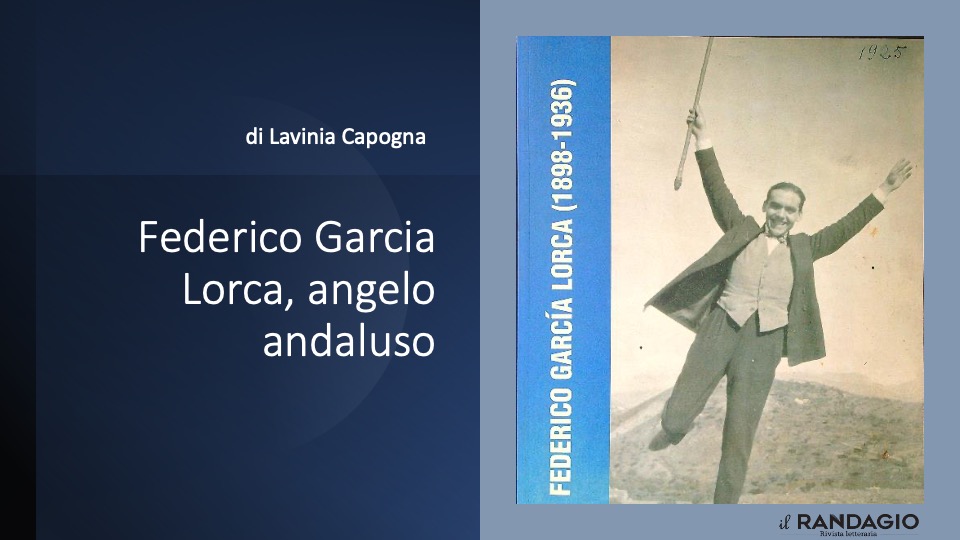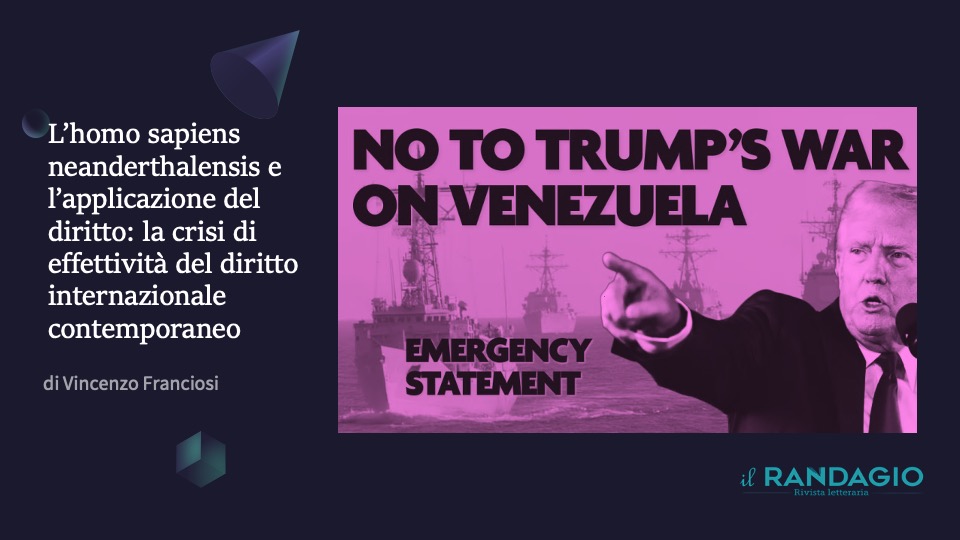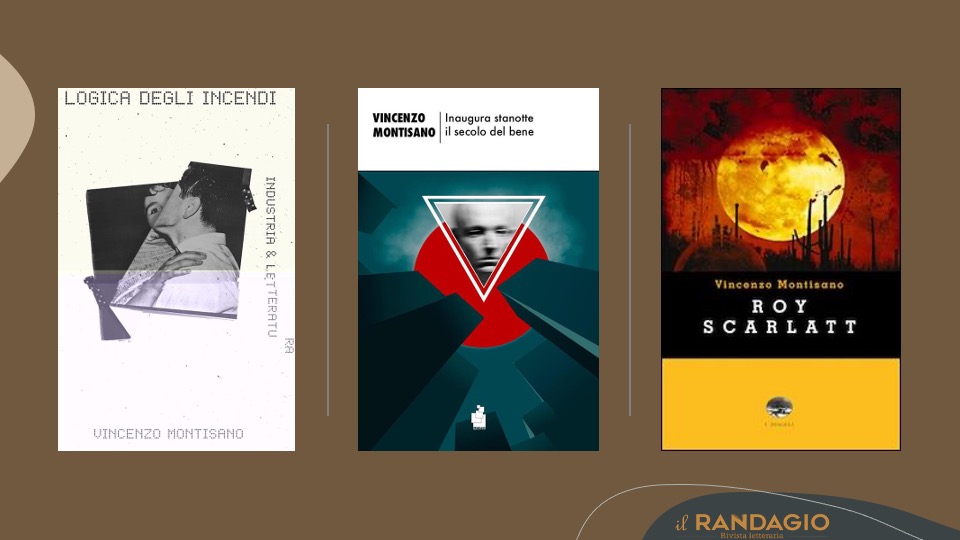(Il lamento di) Portnoy
«Uh, se attacco con le rimostranze non la smetto più. C’è una quantità di cose che odio da sempre senza neanche rendermene conto. Stiamo facendo qualche passo avanti, dottore, o siamo ancora al, come si chiama, “materiale”? Non faccio che lamentarmi, mi ripugna praticamente tutto, e comincio a chiedermi se non possa bastare così. Non vorrei indulgere in quella specie di piagnisteo rituale cui i pazienti psicoanalitici debbono la cattiva stampa che li accompagna.»
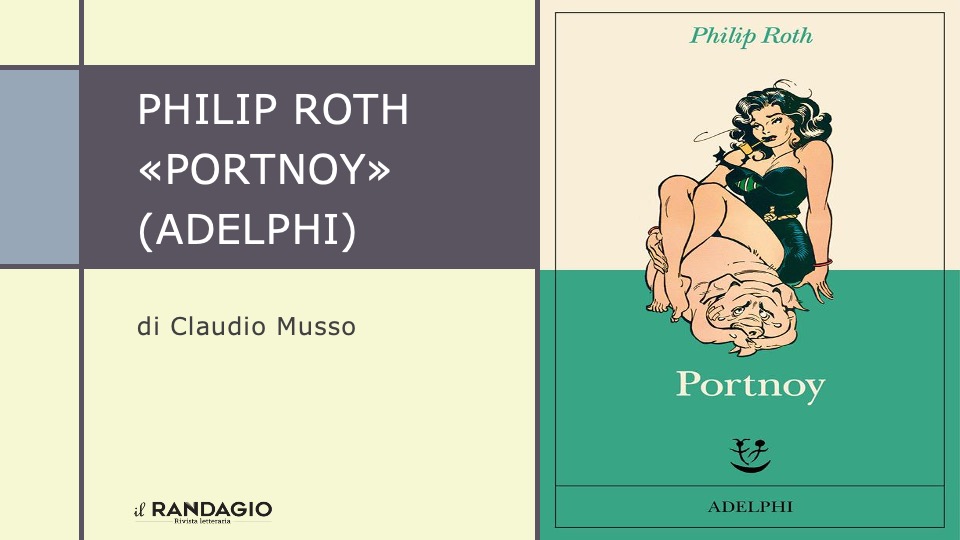
Basterebbero queste righe per archiviare Portnoy. O per farsene travolgere. C’è già tutto: la logorrea irta, l’autosorveglianza, la diffidenza verso il proprio stesso “lamento” mentre lo si produce senza risparmio. Alex Portnoy parla e, parlando, si osserva; si analizza e si sabota; promette di fermarsi ma ricomincia subito dopo. La domanda che rivolge al suo analista, siamo ancora al “materiale” o stiamo arrivando a qualcosa?, non è un vezzo metanarrativo ma il motore stesso del romanzo. Per Portnoy la verità non esiste senza lagna, non c’è un punto fermo, solo un flusso verbale che gira su sé stesso come una trottola nevrotica.
Non a caso Portnoy ama immaginarsi come un esterno di difesa nel baseball: posizione laterale ma strategica da cui controllare il campo e gridare “mia!” come atto di sovranità. È così che si pensa: lucido, dominante, in controllo. È così che non è. In realtà è immerso fino al collo nel proprio caos, convinto tuttavia di osservarlo dall’alto. Il suo monologo non è flusso di coscienza, definizione parca, ma di esistenza. Portnoy non racconta sic et simpliciter la propria vita: la mette in scena, la interrompe, la corregge, la commenta mentre accade. Il lettino diventa un palco e la parola, eccessiva e teatrale, è insieme sintomo e identità. Questo testo non offre pause, anche per chi sta scrivendo: il lettore viene risucchiato in una mente che non smette mai di pensare, giudicare, desiderare, ridere di sé. Talvolta tutto nello stesso periodo.
In questo tuffarsi e riemergere continuo, come uno svasso, Portnoy non risparmia nessuno. Ma non è un iconoclasta per hobby. Non distrugge per gusto ma perché non riesce a fingere che il castello di carte regga quando ne vede tutte le instabilità. La sua corrosività non è solo adolescenziale (anche), è epistemologica. Da qui la sua posizione anomala nella galleria dei personaggi dell’inquietudine. Il confronto con Törless o con un Amleto ancora acerbo aiuta a orientarsi ma senza nostalgia del modello: Portnoy non analizza come Musil, non sublima come Shakespeare. La sua intelligenza opera in uno spazio più instabile, più esposto, quello di un’adolescenza che non finisce mai e non diventa tragedia ma usura. Non ordina l’esperienza, la moltiplica. Non la trasfigura, la esaspera. Il quotidiano diventa un dramma permanente, affrontato con una dedizione febbrile. Senza consolazioni di cori greci.

Da qui nasce l’ironia che attraversa tutto il romanzo: non decorativa, semmai difensiva. Portnoy dice qualcosa e subito la smussa, la corregge, la ridicolizza, come se due voci litigassero per il microfono pur di avere l’ultima parola. Dice tutto ma non coincide mai del tutto con ciò che dice. È un’arte della smentita preventiva, una strategia di sopravvivenza linguistica che impedisce al dramma di irrigidirsi e alla coscienza di diventare monumento.
È anche per questo che la nuova traduzione Adelphi, firmata da Matteo Codignola, non è solo legittima ma necessaria. Un personaggio come Portnoy non può parlare una lingua ben educata: serve un italiano nervoso, irregolare, attuale, capace di scivolare dal colto allo scurrile senza chiedere permesso. In fondo, Portnoy cerca un lessico che gli somigli: scucito, tagliente, a volte volutamente indecoroso. Espressioni come «Raskol’nikov delle seghe» non sono ammiccamenti provocatori ma tentativi estremi di dire una verità che, detta in modo civile, non basterebbe. Portnoy prende lo studente di Dostoevskij, lo strizza fino all’ossessione morale e poi lo butta su un divano psicoanalitico con il desiderio che gli scappa di… mano. La sua sessualità ossessiva, farsesca e colpevole, vestale e, al contempo, Erinni della sua vita, non tollera una lingua neutra: ha bisogno di eccessi, di inciampi, di una sintassi fallica e appuntita che sembri pronta a chiedere scusa e, regolarmente, non lo faccia mai.
Questa voce nasce però da un ambiente molto concreto, soprattutto familiare. Roth lo cristallizza in due immagini create al cesello dell’istantanea: la madre ubiqua e il padre stitico. Da un lato un amore che diventa controllo, ansia, paranoia igienica; dall’altro una figura bloccata nel corpo e nella carriera. Tra una madre ventosa e un padre biglia, Alex cresce sovraesposto, adultizzato prima del tempo, coinvolto nelle paure dei grandi e caricato di consapevolezze non richieste. Chi non si è trovato, almeno una volta, in dinamiche simili?
La sua precocità intellettuale è, a ben guardare, il rovescio di una fragilità emotiva senza protezioni. E tuttavia Portnoy vive nel corpo, nel nervo, nel desiderio, pensiero e carne senza interruttore. Il linguaggio scurrile diventa così difesa ed esorcismo, modo per rompere tabù, pungolare la comunità ebraica di cui, sulla carta, fa parte, smontare il conformismo borghese e restituire un’America già surriscaldata tra Vietnam e post-Kennedy. Ma sotto l’irriverenza non c’è cinismo. Portnoy sa che il padre fatica, intuisce che la madre «si toglierebbe il pane di bocca per lui» e oscilla continuamente tra accusa e tenerezza. Lancia la pietra poi controlla se ha colpito davvero.
La stessa ambivalenza attraversa la sua sessualità – protagonista come abbiamo visto delle sue parole – che diventa un vero campo di battaglia tra desiderio e colpa. Portnoy legge il mondo come un continuo sistema di rapporti di forza: ogni incontro, ogni gesto, ogni parola diventa una piccola partita da vincere o da sopravvivere, non per provocare gli altri, ma per evitare qualsiasi lettura consolatoria della realtà. Ed è proprio in questo gioco ossessivo di dominio e impotenza che nasce il comico: la sua esasperazione, la nevrosi messa in scena, il senso di colpa trasformato in spettacolo strappano più di un sorriso. La sua è una comicità nervosa, liberatoria, perché Portnoy è il primo a ridere di sé, e a farci ridere con lui, mentre mette sotto processo il mondo intero. E molti, in fondo, non vogliamo altro che entrare da quella porte noire, dall’ingresso che i prudenti, o chi aspira a esserlo, evitano con circospezione.
La cornice psicoanalitica rende possibile tutto questo. In seduta, o meglio: nel generoso preambolo alla seduta, l’Es parla, il Super-io accusa, l’Io annaspa come un Sisifo alle prese con il masso dei propri irrisolti. Il silenzio del dottor Spielvogel non è un vuoto narrativo ma la prova che Portnoy non lascia spazio a nessun’altra voce: le inghiotte tutte con una logorrea perfettamente motivata e mai stancante.
Arrivati qui, la domanda non è se Portnoy sia “attuale”, parola che serve più a tranquillizzare che a capire, ma quanto siamo disposti oggi a tollerare una voce così senza addomesticarla. In questo senso la nuova traduzione Adelphi non è un mero lifting linguistico ma un gesto critico: invita a non ascoltare soltanto il lamento bensì a guardare il luogo da cui esso nasce, spostando l’attenzione dal sintomo all’identità. Le polemiche e i pruriti che ne hanno accompagnato l’uscita (titolo contratto, copertina scosciata, lessico “spigoloso”) non sono incidenti di percorso ma segnali di vitalità. Il libro continua a fare attrito, a comportarsi male, a disturbare. Se questa è strategia editoriale, ha almeno il merito di rimettere il romanzo al centro del ring, costringendolo a fare ciò che fa dal 1969: disturbare.
Per chi ha letto la traduzione precedente questo non è un ritorno nostalgico: è un tuffo senza salvagente. La lingua non protegge più, espone; ciò che prima faceva sorridere ora può anche mordere, ciò che brillava diventa acido che non si può ignorare. Ed è lì, proprio lì, che Portnoy funziona. Non chiede indulgenza, né pacificazione, né redenzione: pretende di essere riascoltato. La sua voce reclama un risarcimento danni. Con tanto di interessi.
Riaprirlo oggi significa accettare di entrare in quel porto senza aspettarsi che il mare si calmi, e smettere di intimargli di non “lamentarsi”. Anche perché complaint, in inglese, non è solo piagnisteo: è denuncia, accusa, rivendicazione formale. Portnoy’s Complaint non è un dunque solo lamento, è un esposto contro il mondo, il corpo, la famiglia, l’identità. La vera domanda non è se Portnoy si lamenti ma se abbiamo ancora stomaco per reggere l’accusa.
E se tutto questo sembra eccessivo, beh… benvenuti al club dei lettori di Portnoy, dove, come diceva Nabokov parlando di sé stesso: «Lo scrittore non è un educatore; è un piccolo tiranno del cuore altrui». Prepariamoci, allora, a farci dettare le regole della verità da un tiranno illuminato, spesso con le mutande calate, che ride mentre ci mette sotto processo.
Claudio Musso

Claudio Musso: vive e respira Torino, condividendo qualche gene con la dea Partenope. Di formazione umanistica, è grande appassionato di germanistica, di storia e di identità, oltre che di opera lirica, teatro ed esperienze enogastronomiche italiane, intese come narrazioni culturali prima ancora che sensoriali. Di giorno si occupa di risorse umane, la sera di quelle librose. Convinto che non siamo noi a leggere i libri, ma che siano i libri a leggere noi – intercettando urgenze e possibilità del momento –, randagia da queste parti con impressioni ed espressioni di lettura che non vede l’ora di condividere. Onnivoro per natura, ma intollerante al glutine e alle mode del momento, vive di nicchie e di riserbo e collabora con riviste letterarie e le loro anime belle. Papà di Nadir, il suo gatto, non riesce a prendersi sul serio per più di cinque minuti, invitando chi legge a guardarsi sempre con occhi nuovi.