“Gotico salentino” è un romanzo che unisce la tradizione del gotico con l’attualità di tematiche come il transfemminismo, l’intersezionalità e il queer, raccontando la storia di Filomena, una “medium di provincia” che eredita una casa infestata nel Salento.
Marina Pierri, laureata in semiotica, studiosa di narratologia e cofondatrice del Festival delle Serie Tv, utilizza in questo suo primo romanzo una struttura epistolare e una scrittura che mescola l’italiano al dialetto di un Salento, aspro e cupo, dove gli spettri sono parte della vita quotidiana. Nell’intervista del nostro Gabriele Torchetti, la Pierri parla anche d’altro, dei suoi lavori precedenti, della Lila della Ferrante, della Serao e della Ortese, di Poe e delle sue autrici preferite del genere gotico e horror: Mary Shelley e Shirley Jackson. Su tutto questo la Puglia e la memoria di palazzi e campi assolati del Salento.

Ciao Marina e benvenuta a il Randagio, prima di tuffarci nel gotico salentino facciamo un passo indietro e torniamo a Lila (Giulio Perrone Editore), hai scritto “questo libro è il mio esorcismo”. Perché hai scelto di scrivere un saggio su una delle due protagoniste della tetralogia de L’amica geniale di Elena Ferrante? Il sottotitolo del libro è Attraverso lo specchio, qual è il riflesso finale che hai voluto lasciare ai tuoi lettori?
Potrà sembrare paradossale considerato il genere e la fama de L’amica geniale, ma io credo sia stata proprio Lila a condurmi per mano verso il mio primo romanzo. Lila è gotica: è lo spettro – erede del decadente e del misterioso di Matilde Serao, nonché del fantastico di Anna Maria Ortese – che si aggira su Napoli all’inizio e alla fine della tetralogia che, assecondando il movimento tipico della epopee, disegna e segue una spirale. Come la dea Ecate, dopo la sparizione di Tina Lila riceve doni oscuri dalla comunità del paese, al limite del sacrificio, e come fosse una medium ascolta le fondamenta della città, il passato impenetrabile e inconoscibile che tuttavia è in grado di interrogare tramite l’inquietudine che fa parte del suo corredo archetipico di personaggio. Del resto, ho maturato l’idea che vi sia un significato metanarrativo negli episodi di smarginatura di Lila: nel mio breve saggio la descrivo come glitch, come improvvisa percezione di precarietà del sistema-Rione che è in sé un teatro, una scenografia. Ho voluto scrivere di tutto questo perché sono laureata in semiotica, e pochi romanzi mi sono apparsi semioticamente più densi de L’amica geniale.
Sei studiosa di narratologia, cofondatrice di FeST – Il Festival delle Serie TV che ora «rinasce» nel Milano Film Fest, insomma sei una vera e proprio esperta del linguaggio seriale e della sua continua evoluzione, a questo proposito mi vengono in mente le tue pubblicazioni per Tlon. EROINE – come le protagoniste delle serie TV possono aiutarci a fiorire, è un titolo eloquente che non richiede molte spiegazioni, la domanda è: come si sono evoluti i personaggi femminili seriali negli anni? E hanno contribuito in qualche modo alla causa femminista?
Certo, hanno contribuito enormemente, ma non c’è unidirezionalità: i movimenti femministi hanno informato e informano la scrittura di molte serie ed eroine, così come i movimenti femministi sono informati dalle serie e dalle loro eroine. Le storie per qualsiasi mezzo (romanzi, serie, film, videogiochi) non fanno altro che mostrare la strada verso la trasformazione e il cambiamento, ed è per questo che non solo le amiamo, ma ne abbiamo bisogno. La trasformazione è un lavoro sporco, non sempre ci accorgiamo di quanto leggere, guardare o giocare ci dia una mano a mettere in atto delle strategie utili a diventare chi desideriamo essere. In questo momento specifico, tuttavia, credo che il cinema e i videogiochi abbiano potenzialmente una marcia in più rispetto alle serie, che vivono un momento complicato dettato da una costellazione di fattori, primo tra tutti il test dei modelli di business dei vari broadcaster (mi riferisco a Netflix, Prime Video, AppleTv+, eccetera). Eroine, del resto, è un saggio di cinque anni fa, e credo oggi sarebbe possibile scriverlo, ma il vento di freschezza che lo ha ispirato ha cessato di spirare, ahinoi. Per il momento. Sì, credo sia una fase. Passerà.
Gotico salentino (Giulio Einaudi Editore) segna un passo avanti nel tuo percorso di scrittrice. Com’è arrivata questa storia, quanto c’è di te in Filomena Quarta protagonista del romanzo e perché hai scelto di ambientare questa avventura in Puglia, nel Salento?
Una parte della mia famiglia è salentina; come racconto spesso, il mio trisavolo Giovanni Pasca è stato il primo concessionario delle terme di Santa Cesarea e ha fatto erigere uno straordinario palazzo eclettico nel quale non ho mai avuto il privilegio di entrare, perché è stato venduto all’asta dal mio bisnonno. Credo ci siano poche circostanze più inerentemente gotiche dell’aver perduto un gigantesco maniero ben prima che nascessi, lì dove la memoria degli antenati appare sigillata, o quasi sigillata. Peraltro, sono cresciuta in Salento e continuo a crescere in Salento. Forse per questo Gotico salentino è anche un romanzo generazionale, che spera di rappresentare i turbamenti di chi ha quarant’anni al di fuori delle retoriche un po’ usuali circa la «risoluzione» della propria vita. Le campagne assolate del Salento sono mutanti: nella notte si tramutano in un coacervo di rumori e ombre di complesso discernimento, ma soprattutto di indubbio fascino.

Come in tutti i gotici che si rispettano le ambientazioni sono molto importanti: un paesino nei pressi di una palude, una vecchia casa decadente, una piccola comunità rurale sospesa tra presente e antiche credenze folkloristiche e superstizioni. Hai “studiato” o sono luoghi che in qualche modo ti appartengono?
Sono, da sempre, molto appassionata di genere. Il gotico è stato il mio ingresso nel genere quando ero davvero una bambina, proprio nella casa dei miei nonni dove ho letto per la prima volta La caduta della casa degli Usher di Edgar Allan Poe. Adoro anche la fantascienza, il fantasy, il giallo, il romance. Mi interessa la codifica del genere, di tutti i generi che sono costituiti da qualcosa di simile a mattoncini di Lego da combinare e ricombinare a proprio piacimento, sovvertendo i cosiddetti «luoghi comuni» propri di certe narrazioni, oppure rispettandoli. In Gotico salentino appaiono di proposito una pletora di elementi tipicamente gotici, alcuni dei quali da te menzionati. Aggiungerei un’enfasi su chi lavora alla e nella casa infestata, il gargantuesco tema della memoria famigliare degli avi, ovviamente gli spettri. Dopo Gotico, sempre per Einaudi, ho scritto una sorta di manuale di istruzioni del romanzo, che si intitola proprio Spettri. È un Quanto, dunque una pubblicazione unicamente digitale, ma lì ho provato a passare in rassegna i tipici tratti del gotico, specialmente di quello ottocentesco cui la mia storia si ispira più di tutto.
A proposito di gotico e horror, Filo è una “medium di provincia” evoca fantasmi a sua insaputa: alcune presenze sono inquietanti altre invece decisamente confortanti. Vuoi dirci un po’ chi sono le co-protagoniste (vive e morte) di questa storia?
In Gotico ho evocato (in modo audace, suppongo!) le regine del genere, Mary Shelley e Shirley Jackson. Sono tra le mie scrittrici preferite, e ho condotto un lungo lavoro di documentazione biografica cercando di restituire loro una presenza attuale, sebbene nel romanzo appaiano nella forma di fantasmi (o fantasime, per meglio dire). Shelley e Jackson condividono, faccenda curiosa, alcune circostanze biografiche come la presenza di mariti difficili, ingombranti, spesso tirannici eppure amati, difficili da lasciare andare. E un atteggiamento verso la maternità che si è concretizzato in maniera diversa per l’una e per l’altra. Tra le co-protagoniste vive c’è Alba, la migliore amica di Filomena, su cui torna tra poco.
I fantasmi del tuo romanzo non sono soltanto presenze dall’aldilà ma anche segreti e verità che portiamo dentro.
È sempre vero, nel gotico, o quasi sempre vero. In Spettri ho delineato la mia teoria della casa infestata come archivio, mutuando a mia volta una celebre teoria del filosofo Jacques Derrida – il cosiddetto mal d’archivio. In brevissimo, secondo Derrida ogni archivio è abitato da una pulsione di morte che si traduce in una resistenza all’ordine generato attraverso un criterio e interpretabile secondo una legenda. Per consultarlo, si chiede all’archivista. Ma nella casa infestata l’archivista esiste senza esistere, è lo spettro; nella casa infestata la memoria è ribelle e ambivalente, desidera e non desidera essere conosciuta e interpretata. Per questo la casa spaventa, si fa sentire, si rifiuta di scomparire così come chi non dovrebbe abitarla più da un pezzo, eppure la abita. La casa infestata è narcisista. Naturalmente, lo stesso Gotico salentino è fondato sul mal d’archivio.
Il tuo è anche un romanzo epistolare, ogni capitolo si apre con una lettera destinata a una Dottoressa…
Sì, nella tradizione del gotico classico e del romanzo d’appendice. È una maniera per restituire l’immediatezza quasi diaristica dell’esperienza di Filomena nella Dimora Quarta, ma c’è anche un’altra ragione. Gotico richiede una notevole sospensione dell’incredulità, come tipico del genere, ma è radicato nell’archivio stesso, nella necessità di mettere ordine razionale nella propria vita; nel proprio passato, presente, e futuro. In questo senso, Filomena poteva essere una classica narratrice inaffidabile – ma non lo è. E non lo è perché è seguita, sebbene a distanza. Nelle prime bozze del romanzo la psicologa rispondeva, più tardi abbiamo optato per l’attuale silenzio oracolare (come lo descrive Filomena stessa) che lasciava maggiore spazio all’immaginazione. Ci sono anche altre ragioni per la presenza di una psicologa in Gotico, ma non voglio guastare l’eventuale piacere di leggere i ringraziamenti
Veniamo a questioni che ci stanno a cuore, femminismo intersezionale e queer, sono presenti questi temi nella tua narrazione?
Parto dall’idea che non esista gesto non politico, e dunque non possa esistere un’arte non politica o separabile dall’artista. Gotico è un romanzo transfemminista e intersezionale perché il mio orientamento è transfemminista e intersezionale. Il gotico è un genere molto elitario: racconta di persone ricche e sospettose, vittime di invidia e rabbia sociale, in molti casi. Intersezionalmente, un lavoro sul privilegio nel gotico era inevitabile ed è un aspetto su cui mi sono concentrata molto, tra gli altri; l’ho fatto anche grazie all’aiuto della sensitivity reader Biancamaria Furci. C’è poi l’orientamento di genere: Filomena è bisessuale, il Santo è un uomo apertamente gay, Alba è una persona lesbica non binaria, Antonio contraddice i diktat del macho mediterraneo. Mary Shelley era probabilmente bisessuale e da qui origina il giro di vite fondamentale della trama del romanzo. Shirley Jackson aveva un rapporto oscuro e complicato con l’omosessualità, che tuttavia credo informi profondamente la sua scrittura. Insomma, sì, assolutamente sì: non sarei capace di scrivere nulla che non sia transfemminista, intersezionale e queer perché tutto quello che ho fatto e faccio si fonda sui medesimi pilastri.
Gabriele Torchetti

Gabriele Torchetti: gattaro per vocazione e libraio per caso. Appassionato di cinema, musica e teatro, divoratore seriale di libri e grande bevitore di Spritz. Vive a Terlizzi (BA) e gestisce insieme al suo compagno l’associazione culturale libreria indipendente ‘Un panda sulla luna‘.







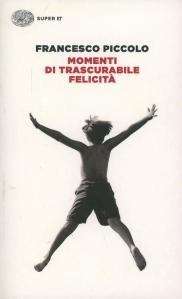

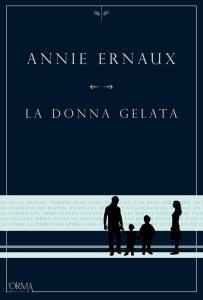
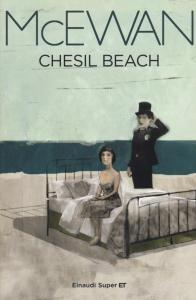




 Le Ricette Letterarie di Anne Baker
Le Ricette Letterarie di Anne Baker  Pronti a mettervi ai fornelli? Ogni piatto racconterà una storia e, perché no, vi inviterà a (ri)leggere le pagine di qualche capolavoro.
Pronti a mettervi ai fornelli? Ogni piatto racconterà una storia e, perché no, vi inviterà a (ri)leggere le pagine di qualche capolavoro. Guarda il video… in cucina! A seguire gli ingredienti e il procedimento.
Guarda il video… in cucina! A seguire gli ingredienti e il procedimento. Ricette Letterarie: la pagnotta al formaggio di Jonathan Franzen
Ricette Letterarie: la pagnotta al formaggio di Jonathan Franzen 


