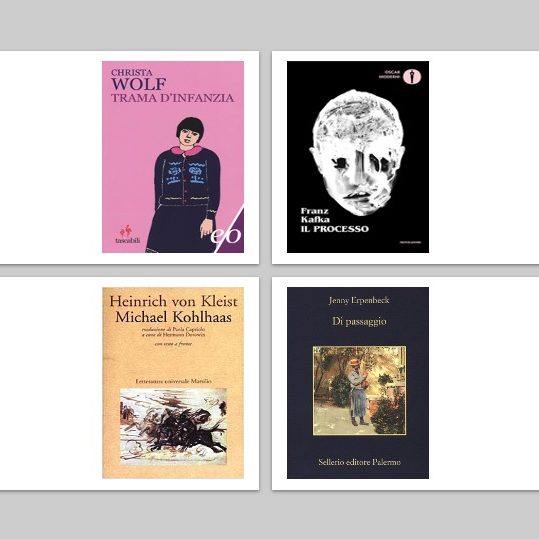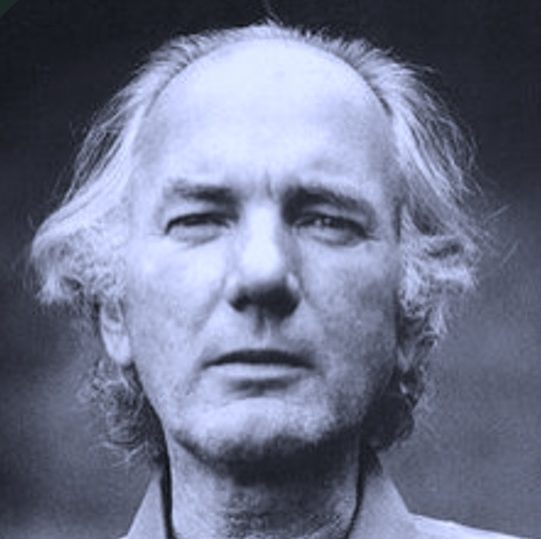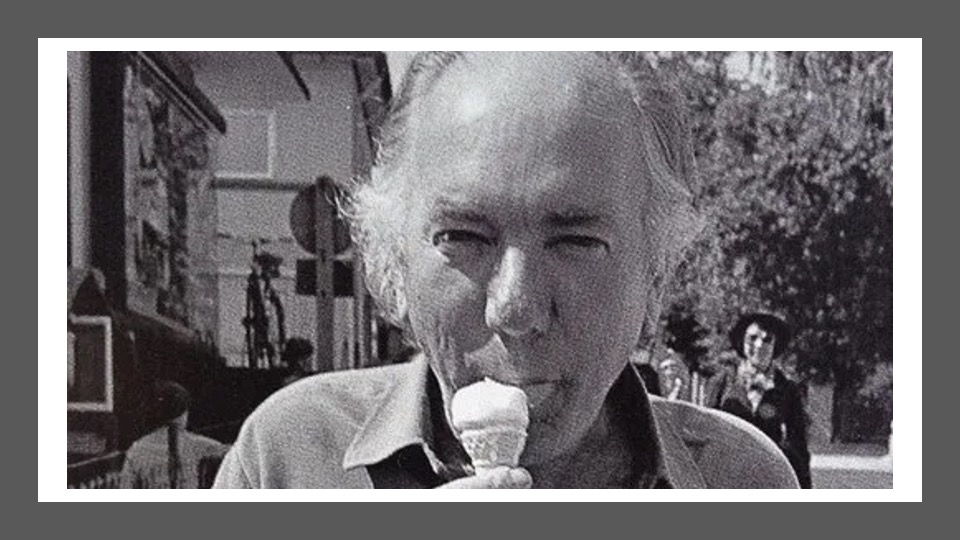C’è chi dice che la letteratura tedesca sia ‘difficile’. Troppo seria, troppo filosofica, troppo cupa. Eppure, se mai c’è stato un tempo in cui valga la pena riscoprirla, è questo. Perché, più di altre, sa andare a fondo. Sa raccontare il buio senza cedere al nichilismo e, al tempo stesso, interrogare senza semplificare. In un’epoca come la nostra di rumore, slogan e risposte immediate, essa ci offre invece domande lente, necessarie, vitali. Non è una letteratura che consola. Non intrattiene ma trattiene noi lettori in una ragnatela da cui possiamo uscire se scorgiamo i fili che ci legano o dai quali ci lasciamo legare per liberarci.
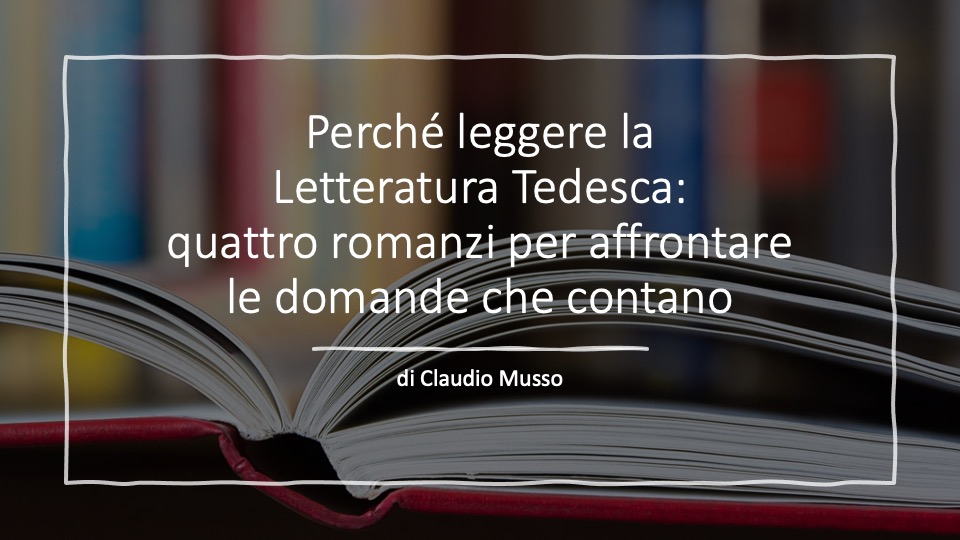
Ed allora ecco quattro romanzi che, ciascuno a modo proprio, possono aiutarci a orientare lo sguardo in questo presente frastagliato. Ecco quattro ‘mattoni’, non solo di pagine ma di sostanza, che sono quelli che ci permettono di costruire per creare qualcosa o proteggerci.
Heinrich von Kleist, Michael Kohlhaas (trad. Paola Capriolo, Marsilio)
Giustizia e disobbedienza: quando la legge non basta.
Michael Kohlhaas è un commerciante di cavalli onesto, scrupoloso, fedele al diritto. Ma un giorno subisce un’ingiustizia che le autorità si rifiutano di sanare. Da quel momento la sua vita cambia: si trasforma in un vendicatore, guida una rivolta, sfida apertamente il potere. È un uomo che crede nella giustizia fino a diventarne vittima. Leggere oggi Kohlhaas significa riflettere su quanto può essere sottile il confine tra legalità e giustizia, tra ribellione e responsabilità morale. È una parabola inquietante e profonda che ci parla del senso di impotenza di fronte a istituzioni opache e contraddittorie. Un’esperienza fin troppo attuale?
«Poiché era uno degli uomini più integri, e allo stesso tempo più terribili, del suo tempo.»
Kleist non offre modelli morali rassicuranti, ma una domanda: cosa succede quando il diritto non difende più chi ha ragione? Esistono modi per non abbandonarsi alla giustizia privata?
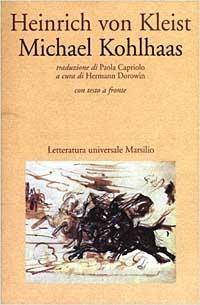
Christa Wolf, Trama d’infanzia (trad. Anita Raja, e/o)
Memoria, colpa, coscienza: la Storia dentro di noi.
Christa Wolf torna alla propria infanzia vissuta sotto il nazismo e la rilegge alla luce del presente, nella Germania Est. È un tentativo sofferto, spesso ambiguo, di interrogare sé stessa e il proprio sguardo di bambina: perché non ha visto? Perché non ha capito? Cosa resta di quella bambina in lei, oggi? Trama d’infanzia è un romanzo, non tra i più noti in Italia, che parla del passato come materia viva, mai davvero superata. Oggi, in tempi di rimozioni rapide e di verità riscritte, ci invita a una forma di memoria vigile e intransigente.
«Può darsi che il nostro compito più importante sia quello di non dimenticare.»
Wolf scrive come chi scava nella propria voce per trovare un senso più grande. È un libro che ci insegna che la coscienza si costruisce lentamente. Nella fatica della memoria.

Franz Kafka, Il processo (trad. Ervino Pocar, Mondadori)
L’alienazione dell’individuo nell’era dell’assurdo
Josef K. si sveglia una mattina e scopre di essere stato arrestato. Nessuno gli dice perché e gli spiega nulla. Inizia così un processo senza accuse, in un tribunale senza regole, in un sistema che sfugge a ogni logica. Kafka non costruisce solo un incubo: descrive un’esperienza profondamente moderna. Nel mondo di oggi, tra burocrazie impersonali, algoritmi oscuri, decisioni che ci riguardano ma che non comprendiamo, il romanzo risuona con una forza nuova. È il racconto di chi cerca un senso dove il senso è stato cancellato.
«Qualcuno doveva aver calunniato Josef K., perché senza che avesse fatto nulla di male, una mattina venne arrestato.»
Kafka, sempre variamente interpretato e interpellato, certamente non ci rassicura. Ma ci aiuta a nominare l’assurdo e a resistervi. Ci invita a non accettare l’opacità come destino.
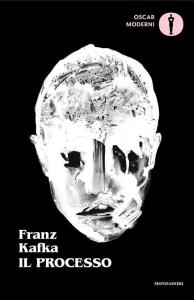
Jenny Erpenbeck, Di passaggio (trad. Ada Vigliani, Sellerio)
Una casa, cento anni, mille identità tedesche
Una casa sulle rive di un lago del Brandeburgo è la vera protagonista di questo romanzo. Passa di mano in mano, di epoca in epoca: una domestica ebrea costretta a fuggire, un funzionario nazista, un artista della DDR, una scrittrice della Germania riunificata. Ogni stanza, ogni oggetto, ogni albero ha una memoria. Erpenbeck racconta la storia tedesca del Novecento senza farne una lezione di storia. Lo fa attraverso le tracce lasciate da chi è passato: amori, lutti, silenzi. In un tempo segnato da smarrimenti identitari e fratture storiche, Di passaggio è una riflessione poetica su ciò che resta e su cosa significa “casa”.
«La casa sa tutto quello che accade.»
Non esiste luogo neutro: anche i muri ascoltano. Anche le pietre hanno una storia da raccontare. In tempi di migrazioni e dislocamenti, è un libro di radici e di mutamento.

***************************************
Ciò che unisce questi quattro romanzi non è un’estetica comune o un’ideologia condivisa, ma è un’attitudine: la volontà di interrogare, in profondità, l’uomo, la storia, il potere, la responsabilità, il linguaggio. Leggerli oggi non significa cercare risposte immediate, ma aprirsi a domande che resistono. Sono opere esigenti, sì. Ma oggi più che mai abbiamo bisogno di letture che non semplifichino, che non blandiscano o cullino. Come scriveva Cesare Cases, la letteratura, e in particolare quella tedesca, ha questo compito essenziale:
«non ci dà risposte, ma ci pone le domande decisive.»
E in tempi incerti, che sempre ci saranno, è proprio dalle domande che dobbiamo ripartire.
Claudio Musso

Claudio Musso: Vive e respira Torino e condivide un paio di geni con la dea Partenope. Formazione umanistica, grande appassionato di germanistica, di storia e di identità. Di giorno si occupa di risorse umane e la sera, o quando leggere e leggersi chiama, di quelle librose. Onnivoro per natura, ma intollerante al glutine e alle mode del momento, raminga con umorismo tra un lavoro che ama e altre passioni quali il teatro, l’opera lirica, e ovviamente la lettura, collaborando anche con riviste letterarie. Papà di Nadir, il suo gatto, non riesce per più di 5 minuti a prendersi troppo sul serio ma prova a fare tutto con dedizione, di quelle che danno senso e colore alla vita.