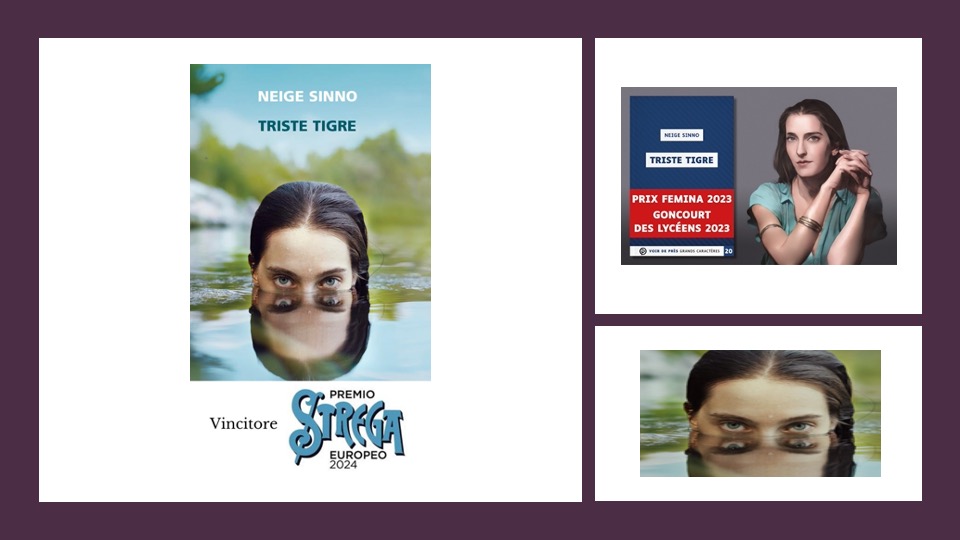L’aula de l’UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH DE FES la mattina del 13 giugno era affollata.
Mohamed è venuto a prenderci di buon ora all’hotel Mérinides.
All’università Sidi Mohamed Ben Abdellah tutto era pronto per il “colloque internationale” al quale avrei dovuto partecipare come ospite straniero.
Il tema era di quelli che a tutta prima non mi entusiasmava. “L’autonomia delle banche centrali“.
Si trattava di un tema tabù, una sorta di totem che guai a criticarlo. Ti prendevi immediatamente delle sonore reprimende. Da tutti. Era convincimento generale che l’autonomia delle banche centrali fosse una sorta di dogma indiscutibile. Come quello della verginità della madre di Dio. Assurdo. Ma era così. Ci avevano impiegato una quarantina d’anni banchieri, finanzieri e speculatori a convincere il mondo che la virtù dei popoli e la saldezza degli stati dipendeva dalla stabilità della moneta, dal controllo dell’inflazione, dall’ordinato procedere dei conti pubblici e privati, trascurando che tutto partiva dalla saggezza dei governanti e dal senso civico dei cittadini. Al di fuori del loro controllo vi sarebbe stato caos e disordine in agguato, sostenevano i novelli profeti del dio danaro.
Per anni, avevo assistito al rito della banca centrale italiana che dettava il suo decalogo mentre tutti erano in religioso silenzio ad ascoltare.
L’inflazione era il male assoluto, recitavano i sacerdoti della banca centrale. E bisognava manovrare i tassi di interesse per controllarla. Cosa sacrosanta. Lo avevo studiato ai primi esami dell’Università. Se i consumi si surriscaldano ed i prezzi corrono bisogna raffreddarli, diceva il professore e l’aumento dei tassi di interesse era l’acqua fredda che faceva alla bisogna. Ed io mi dicevo che era giusto. D’altronde il mercato a cui il professore faceva riferimento era il mercato definito da Smith, da Ricardo e dagli economisti classici: un mercato in cui vigeva la concorrenza tra gli operatori che aumentavano e diminuivano i prezzi a seconda dell’andamento dei consumi. Un meccanismo collaudato e perfetto.

Poi qualcosa si è rotto. I meccanismi si erano inceppati. Il mercato non era quello che si teneva nelle piazze delle città e dei paesi, o nelle Medine del Maghreb. I prezzi non li facevano più i produttori ed i consumatori. Anzi essi erano diventati i terminali di una catena su cui non avevano alcun potere.
Aveva fatto la sua comparsa la speculazione.
Il mondo aveva bisogno di energia e tecnologia a livelli sempre più spasmodici e chi deteneva le chiavi dell’una e dell’altra dettava legge. E dettando legge i nuovi padroni presero gusto a manovrare il mondo fino ad impossessarsene.
Smith, Ricardo e tutti gli altri, compreso Marx che aveva goduto della fama di rivoluzionario e teorico della rivoluzione comunista, ormai erano ridotti ad un cumulo di residuati storici. Inutili ed inutilizzabili.
Venne così l’idea che per rendere ben saldo e addirittura inevitabile il loro potere, speculatori e padroni del mondo dovevano abbattere l’ultimo baluardo degli Stati: quello costituito da un Istituto di emissione che batteva moneta e, a seconda dei bisogni e dei progetti, la prestava allo Stato. Cominciarono a dire che questo meccanismo era “diabolico”.
I governanti richiedevano in continuazione moneta fresca per i loro programmi ed il debito cresceva.
Bisognava azzerare quel potere ed arrivò l’autonomia delle banche centrali. La banca divorziò dal Governo. Consensualmente, ovvio. Stati e governi se avevano bisogno di soldi in più rispetto a quelli che entravano con le tasse, dovevano andarseli a cercare sul cosiddetto mercato finanziario che, guarda un po’, era nelle mani degli speculatori che facevano pagare quei soldi fior di quattrini sotto forma di interessi e dispensavano le pagelle che misuravano la capacità degli Stati di sostenere i debiti da loro alimentati.
Insomma, la virtù degli Stati e dei popoli non risiedeva più nella saggezza ma nelle catene manovrate sapientemente dai cerberi della finanza.
Il resto è storia di oggi ed è sotto gli occhi di tutti. I salari e gli stipendi sono andati diminuendo a vista d’occhio, tanto che gli operai non esistono più, esistono solo prestatori d’opera privi di diritti e senza alcun potere. I debiti degli Stati sono esplosi tanto da essere diventati dei macigni manovrati a piacimento dalla speculazione internazionale.
Le guerre sono tornate a popolare il mondo come strumenti necessari laddove la speculazione non riesce, con i debiti e gli interessi, a far quadrare i suoi conti.
La saggezza dei governanti ed il senso civico dei popoli sono roba da far ridere.
L’ignoranza, l’arroganza, il bieco perseguimento del proprio tornaconto sono alla base della politica mentre la gente cerca di sopravvivere adeguandosi ai dettami di chi controlla il mondo.
Così quando mi è arrivato l’invito dell’Università SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH di FES, a partecipare ad un loro “Colloque internationale” sull’autonomia delle banche centrali mi sono interrogato se fosse il caso di accettare o di ringraziare e passare la mano. Il tema dell’autonomia delle banche centrali è noioso e tu devi andare a recitare la verità di qualcun altro. Ma io ormai me ne sono tirato fuori. Faccio parte di quel gruppo sparuto di don Chisciotte che si sono posti, come Re Leonida alle Termopili, a guardia di quell’idea palingenetica che vuole restituire al mondo la sua dimensione autentica, fatta di senso del limite e della misura che, soli, possono rimetterlo in piedi, magari ritrovando anche la dimensione primordiale ed i valori ancestrali, sia pure rivisitati in chiave contemporanea.
E allora mi son detto che si, era una bella opportunità e che avrei colto l’invito per negare la verità dominante e dare una mano a rimettere in piedi il mondo da troppo tempo costretto a camminare a testa in giù. Quanto meno ci avrei provato.
Mi incuriosiva il fatto che l’invito arrivava da un Paese africano, il Marocco, tuttora in bilico tra tradizione e modernità, tra la tentazione di legarsi al carro della normalità del villaggio globale e l’antico richiamo a mantenere integri i suoi valori. Che fosse un’università poi a porre la questione mi intrigava ancor maggiormente. Bisognava stare attenti. L’università, almeno in Occidente si era trasformata, in molti casi, nella cinghia di trasmissione del pensiero unico, avendo da tempo rinunciato al pensiero critico allo stesso modo in cui gli Stati avevano rinunciato al perseguimento del bene comune ed al necessario esercizio del sapere a questo fine. Vi era ormai il convincimento che a governare fossero buoni tutti e che a dettare regole e leggi ci avrebbe pensato la speculazione che governava il mondo, secondo i dettami del Club Bilderbeg un tempo segreto e oggi divenuto spudoratamente patrimonio universale.
Così mi lasciai prendere dalla suggestiva idea di raccontare al pubblico dell’Università SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH di Fes, la storia di Faust e di Mefistofele.
…
Nell’aula vi era una folla di studentesse soprattutto, mi pareva, preponderanti rispetto agli studenti. Era una visione fresca ed emozionante. Molte di esse indossavano gli abiti tradizionali ed il velo, altre vestivano in maniera occidentale, come si usa dire. Ma tutte e tutti erano perfettamente a loro agio. Vi era libertà e tolleranza in Marocco e questo era già un bel segnale. Il corpo docente era piuttosto giovane. Uomini e donne. Mi son venuti incontro gioviali e sorridenti: nulla a che fare con gli stereotipi occidentali. Qui tutto mi sembrava vero.
Mohamed MHAMDI, il direttore del dipartimento di studi economici, giuridici e sociali, era lì ad abbracciarmi giulivo ricordando il mio recente incantamento notturno alla visione del palazzo reale appena giunti a Fes. Vi era il professore El Iri, felice di condividere con me la visione del mondo ampia e generale e non aziendale. Egli come me era convinto che bisognasse tornare agli studi di politica economica oggi completamente rimossi in favore degli insegnamenti gestionali. «E già » gli avevo risposto “nel mondo attuale tutto è ridotto a livello aziendale”. Gli stessi Stati sono diventati aziende e questo ci sta portando alla rovina.
L’atmosfera era elettrizzante e rilassata al contempo. Io chiuso nell’abito preso in affitto essendo il mio bagaglio fermo a Casablanca, mi guardavo per controllare se tutto fosse in ordine e di tanto in tanto mi davo un’aggiustata.
Mi sentivo addirittura felice di essere lì. Gli sguardi di quelle ragazze dagli occhi neri, grandi e lucenti mi eccitavano. Era in quegli occhi il futuro del mondo. E bisognava insinuare qualche dubbio perchéé magari le loro ricerche andassero fuori tema e scandagliassero territori non battuti o addirittura minati o recintati da filo spinato dai padroni del mondo che puntavano ad impossessarsi dell’anima ancora pura di quel Paese.
Così quando arrivò il mio turno misi da parte la relazione scritta e raccontai la storia di Faust e Mefistofele.

…
Tutto ebbe inizio con l’invenzione della carta-moneta. Iniziai.
Nel primo atto della seconda parte del “Faust”, la monumentale opera di Goethe, Mefistofele inventa la carta moneta.
Faust ha accettato la dannazione eterna della sua anima in cambio della felicità sulla terra e Mefistofele è lì a garantirgli quella felicità e prendersi, in cambio, la sua anima, a tempo debito.
Dopo aver vissuto le seduzioni dell’amore e le sue terribili profanazioni senza batter ciglio, Faust vuole la felicità assoluta che solo il potere può assicurare e si ritrova, a causa delle sue dissennate voracità, nella necessità di risanare le finanze del regno a lui consegnato integro da Mefistofele e Mefistofele gli presenta l’arma segreta: la carta moneta in luogo della tradizionale moneta in metallo.
Le possibilità che si apriranno con la carta moneta saranno infinite e Faust potrà dar corso ad ogni suo insano desiderio.
I ragazzi e le ragazze erano attenti e forse si stavano chiedendo dove volessi andare a parare. Di sicuro se lo chiedeva più di un professore e il rappresentante della banca mondiale seduto in platea.
La carta moneta, disquisiva Mefistofele, verrà garantita dalle miniere nascoste nel sottosuolo, senza preoccuparsi della loro consistenza e del loro reale sfruttamento. E tutti la accetteranno in conseguenza della sua praticità e dell’autorità del sovrano.
Mi sono fermato un attimo ed ho guardato la platea cercando gli occhi più neri e più grandi.
È il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ho detto recuperando la parabola evangelica o, meglio, mi sono corretto nel timore che quella parabola dicesse poco ad una platea abituata al Corano, ci troviamo di fronte al miracolo della moltiplicazione delle ricchezze a disposizione del principe grazie alla invenzione Mefistofelica.
Faust è entusiasta, addirittura commosso.
Egli potrà essere, di volta in volta, lungimirante capitalista o trasformarsi nel padrone assoluto del regno e del popolo, oppure, ancora, potrà essere un munifico magnate.
Era evidente la parabola racchiusa nella folle corsa di Faust verso la Felicità per il tramite di un mezzo, la carta moneta, suscettibile di aumentare a dismisura con conseguenze tuttavia nefaste, come ben presto gli era risultato chiaro man mano che egli ordinava a Mefistofele di dargli altra e altra carta moneta per coprire i debiti dei suoi azzardi.
Mefistofele vede avvicinarsi il premio del patto scellerato che dovrà concludersi con la perdizione eterna dell’anima di Faust.
Mi sono fermato di nuovo sempre più affascinato da quegli occhi grandi e neri che mi avviluppavano.
La moneta di Mefistofele non è un’invenzione peregrina. Anzi, ho aggiunto.
Va da sé, ho azzardato cercando la complicità della platea, che l’uso di essa, per le caratteristiche di duttilità e versatilità, entrambe legate alle volontà ed alle capacità di chi ne possiede il controllo, può essere indirizzato, come nella vicenda faustiana, verso il perseguimento di obiettivi nobili o meno.
Fuor dalla metafora faustiana la moneta svolgerà bene la sua funzione finché essa sarà creata, fatta circolare e gestita con regole prudenti, efficaci e lungimiranti che ne garantiscano il ruolo neutro di facilitatore dei processi di produzione, scambio e investimento, sia sul piano interno che su quello internazionale.
Ho così reinterpretato la parabola faustiana in ossequio al luogo in cui mi trovavo, ovverosia una università. Ed ho continuato con un excursus storico economico che mi sembrava doveroso oltre che adatto alla mia tesi.
La deriva speculativa ha finito per prendere il sopravvento e l’uso della moneta, il suo valore, la sua stabilità, il suo costo in termini di interessi, lo stesso accesso, sono diventati addirittura strumenti di pressione, dissuasione o convincimento.
A valle non restava e non resta che la guerra.
È la storia di oggi.
Più chiaro di così…
Ma ero confortato dai grandi occhi neri che mi osservavano, attenti e mi incoraggiavano.
Con la deriva speculativa la natura duale dell’economia mondiale ha preso definitivamente il sopravvento, ho chiosato
Il mondo si è diviso in Nord e Sud.
Il Nord ricco e sviluppato, il Sud povero e sottosviluppato.
Il Nord in possesso delle leve finanziarie, produttive, energetiche, tecnologiche necessarie.
Il Sud dipendente dal nord, anche quando detiene, in parte rilevante, quelle leve nel campo delle materie prime, della popolazione, delle intelligenze e delle forze di lavoro.
La combinazione perversa di inflazione e speculazione sul mercato internazionale dei beni alimentari, delle materie prime e delle fonti energetiche ha innescato, a sua volta, un pericoloso detonatore in grado di minare se non far esplodere le economie di interi stati oltre che le fortune di popoli, famiglie ed individui.
Quel che sta succedendo sotto i nostri occhi con le guerre combattute con i prezzi delle materie prime oltre che con i missili, gli aerei ed i carri armati, ne sono la riprova.
In tutto questo le banche centrali, soprattutto laddove dotate di autonomia e quindi indipendenti rispetto all’azione dello Stato, perseguono politiche di tassi di interesse elevati per spegnere un’inflazione che non ha nulla a che vedere con il surriscaldamento della domanda da consumi interni di cui mi avevano parlato all’università, mentre gli Stati si ritrovano ad essere essi stessi vittime, insieme ai loro cittadini, del peso degli interessi che rischia di schiacciarli.
A loro volta gli Stati, non potendo sollecitare un intervento della banca centrale a sostegno della loro azione per il rilancio dell’economia, hanno a disposizione solo la leva fiscale che, dal canto suo, mette in moto meccanismi che possono compromettere la stessa tenuta del sistema economico e sociale oltre che deprimere la capacità reddituale delle famiglie e dei singoli cittadini.
Non resta che la vendita dei beni pubblici per far fronte alle esigenze di bilancio e calmierare il peso fiscale. O addirittura la dismissione dei servizi pubblici, come la sanità, la scuola, i trasporti.
Insomma, lo Stato si trasforma in azienda ed impone alle sue articolazioni di trasformarsi a loro volta in aziende più o meno commissariate dalle istituzioni finanziarie internazionali.
Lo Stato non ha più come suo obiettivo lo sviluppo ed il progresso che portino alla felicità del proprio popolo ma il compito, obbligato, di far fronte alle esigenze del bilancio, al pagamento degli interessi sul debito pubblico, al contenimento delle spese sul funzionamento delle istituzioni e dei servizi con la conseguenza che la povertà e la deriva autoritaria diventano due convitati di pietra sempre più evidenti.
È in questo contesto che si pone la questione dell’autonomia delle Banche Centrali rispetto agli Stati di appartenenza, ovviamente per quegli Stati che ancora controllano la moneta ed i cambi attraverso la Banca Centrale.
Il tema diventava incandescente. I grandi occhi e neri cercavano risposte che andassero oltre i punti interrogativi. Ed anche i professori attendevano qualche indicazione.
Cosi pensai al Mediterraneo ed alla Grecia. Era lì che ancora una volta andava cercata la risposta. Non mi preoccupai delle reazioni di un pubblico a cultura coranica. In fondo per molti secoli e sino al milleduecento la cultura abitava da queste parti. La Medina era tuttora l’ultima interprete della cultura greca. E d’altronde fu l’arabo Averroè a salvare il sapere di Aristotele e trasmetterlo agli Europei divenuti nel frattempo analfabeti.
Cosi partii proprio da Platone per cercare qualche vena di acqua pura suscettibile di diventare ruscello e magari fiume.
Platone aveva identificato nei suoi “Dialogoi”, nel Timeo e nel Crizia, in Atlantide, la terra della civiltà e del buon governo.
Quella terra, da molti individuata in Marocco, nei pressi dei monti di Atlante, un tempo circondati dal grande fiume noto presso i Greci come Oceano che avvolgeva per intero il Pianeta, sprofondò al colmo del suo splendore nell’arco di una notte, in fondo alle acque.
Platone legava indissolubilmente le fortune degli Stati alla saggezza dei suoi governanti oltre che alle virtù dei suoi cittadini.
E lo stesso Averroé affidava alla razionalità dell’intelletto umano la soluzione delle questioni dei popoli.
Mi sembrava di aver giocato una buona carta. Platone ed Averroè come le colonne d’Ercole che potranno garantire la nuova conoscenza.

La questione dell’autonomia della Banca Centrale rispetto al controllo statale va valutata proprio alla luce dell’esistenza delle condizioni di saggezza o meno che caratterizzano le realtà attuali.
Si, mi sembrava ormai di andare in discesa e insistetti.
Non vi è dubbio che negli ultimi quarant’anni il peso finanziario sull’economia e sull’intero apparato statale è andato ben al di là del funzionale rapporto mezzi-obiettivi, sino a stravolgerlo.
Si è materializzata la maledizione di Faust ed è diventato evidente l’imbroglio di Mefistofele.
Alla base dello strapotere della speculazione finanziaria e della dilatazione inarrestabile della massa monetaria virtuale, vi è una zavorra incontrollabile nel debito pubblico e nella speculazione che si sostengono a vicenda.
Ovvio che avendo trasformato il mondo in azienda, i detentori della ricchezza finanziaria, i cosiddetti azionisti che impongono ferree regole per salvaguardare i loro ritorni o profitti, conducono il gioco a loro piacimento.
In una parola gli Stati non si preoccupano più, nemmeno teoricamente o filosoficamente, di perseguire la felicità dei popoli.
Semplicemente.
L’intera società ha subito, dal canto suo, un progressivo degrado che l’ha resa sempre più prigioniera di un consumismo fine a sé stesso che non ha nulla in comune con l’essenzialità dei bisogni ed il senso del limite e della misura con cui i popoli antichi del Mediterraneo hanno costruito il loro rapporto con la terra e con la divinità prima e con la civiltà poi.
Si, era proprio così, convenivo con me stesso e, in un consesso accademico africano mi venne spontaneo richiamare Camus che dell’Africa era innamorato come un figlio può esserlo.
È venuto meno, dissi scrutando gli occhi che avevo di fronte, il senso del limite e della misura che Albert Camus ne “l’Homme révolté” aveva definito come l’antidoto custodito dal Sud e dal Mediterraneo per controbilanciare la frenesia consumistica dei paesi europei del Mare del nord.
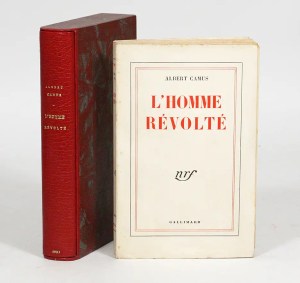
Così il divorzio tra banche centrali e autorità statali oltre ad essere divenuto il corollario della deriva speculativa finanziaria appare sempre più come l’espressione più evidente della Hybris umana che, ahimè, sta già portando alla Nemesis divina.
E sferrai l’attacco finale.
Mefistofele aveva ben capito che la virtù di un regno come di un individuo non sarebbe stata compromessa dall’introduzione della moneta cartacea o virtuale in luogo di quella metallica.
Egli sapeva che era nell’ambizione umana, nel venir meno del senso del limite e della misura chiamati a definire il rapporto primordiale dell’uomo con la terra e la divinità, il vero nemico.
E conoscendo gli uomini lasciò fare al povero Faust portandolo a capire infine, quando ormai Mefistofele era lì a riscuotere il prezzo del patto, che era in lui il guaio e non fuori di lui. Perché ogni cosa, compresa la moneta sono strumenti.
Sono gli uomini che li manovrano a farli divenire buoni o cattivi per sé e gli altri.
E finisco con l’ultimo azzardo visto che lo propongo in un Paese che si bagna nell’Atlantico oltre che nel Mediterraneo.
Se tutti gli Stati dei tre continenti che si affacciano sul Mediterraneo avessero una visione comune dei diritti primordiali ed inalienabili a cominciare da quello alla migrazione, al progresso ed alla cooperazione nel rispetto reciproco delle culture, in una parola, al diritto alla felicità dei popoli e degli individui?
E se il Mediterraneo fosse esso stesso Continente, il nostro continente comune?
E se evocassimo il mito di Atlantide e recuperassimo l’idea platonica ed averroista, che il bene comune debba essere il frutto della saggezza? E se infine rammentassimo che il fine ultimo degli Stati è la felicità dei popoli e degli individui che in essi vivono?
Mi rendo conto che ho esagerato con i punti di domanda. Ma quegli occhi grandi e neri che mi guardavano mi dicevano che si, potevo azzardare nella certezza che alla fine Faust si sarebbe salvato e Mefistofele, come nell’epilogo di Goethe, avrebbe perso la sua scommessa.
E tutto grazie ai quei grandi occhi neri pieni del desiderio di cercare le risposte.
…
Il mio intervento a “le colloque internationale” de l’Université di Fes é finito. Vi é stato però un seguito di domande e risposte che ha coinvolto una buona parte della platea. Credo che in molti abbiano colto il senso del mio messaggio. Una ragazza ha usato il termine « illegalità » per sottolineare il comportamento della speculazione lesivo dei diritti dei popoli e degli individui. Anche alcuni professori sono intervenuti per stigmatizzare una sorta di schizofrenia tra speculazione, tassi di interesse e sviluppo dei popoli.
Di sicuro qualcosa bisognerà cambiare prima che sia troppo tardi. Su questo, sembra, siamo tutti d’accordo. Beh, mi sento gratificato se non proprio felice per le reazioni che ho ascoltato e gli sguardi che mi hanno cercato. Più di una ragazza dagli occhi neri e grandi, pieni di luce, mi ha raggiunto dopo i lavori per dirmi che era bello quel che aveva ascoltato.
Forse la storia di Faust e Mefistofele ha funzionato. Forse a qualcuna di esse verrà il desiderio di leggere il capolavoro di Goethe. Confesso che questo pensiero è il più intrigante. Non che Goethe sia sconosciuto alla letteratura araba. Più di qualcuno tra i contemporanei drammaturghi arabi si è ispirato a Goethe, Tawfiq al-Hakim, uno scrittore egiziano della prima metà del secolo scorso ha addirittura preso spunto dal Faust per scrivere un suo racconto originale sul tema. Ma pretendere che degli studenti o studentesse di economia di una università del Marocco conoscano Goethe ed il Faust, forse è troppo e quindi mi auguro che la mia escursione abbia acceso anche qualche curiosità di natura letteraria accanto alla necessità di una palingenesi economica e sociale, umana tout -court, divenuta improcrastinabile pur se forse al limite del possibile.

A sera ho visto sul mio profilo Facebook più di una richiesta di amicizia. Provenivano da ragazze e ragazzi presenti al « Colloque » e da alcuni professori. Così, compulsando il mio cellulare, finalmente connesso grazie al WIFI dell’Hotel, ho scoperto di avere un bel gruppo di nuove amiche ed amici a Fes. É davvero un bel risultato, mi son detto. Chissà che l’azione di don Chisciotte, al pari di quella di re Leonida alle Termopili, non abbia successo ed un bel manipolo di ragazze e ragazzi non arrivi a prenderne il posto per raddrizzare questo mondo ed evitare la sua definitiva capitolazione.
Che la riscossa parta dall’Africa sarebbe un bel segnale. L’Africa, dicono gli analisti della globalizzazione, é destinata a segnare il futuro prossimo del mondo per il suo peso demografico ma anche per le sue risorse. Io mi auguro che lo segni anche per la sua voglia di raddrizzarlo, il futuro del mondo.
Che possa essere addirittura il Marocco a suonare la carica, grazie ai suoi ragazzi e ragazze tuttora intrisi di primordiale senso del limite e dall’altrettanto ancestrale senso della misura nella miscela di tradizione e modernità, sarebbe davvero magnifico. Perché il Marocco, paese eminentemente mediterraneo, conosce l’Oceano, affacciandosi sull’Atlantico immenso e sconfinato e possiede la forza luminosa del Sahara che a sua volta corre verso il Mediterraneo recando con sé gran parte dei popoli africani.
Questa idea di costruire il continente mediterraneo mettendo insieme le aspirazioni alla pace, alla felicità ed allo sviluppo di tutti popoli dei tre continenti che convergono nel suo bacino é molto suggestiva ed essa ha fatto brillare di ancor più vivida luce gli occhi grandi e neri che dalla platea mi fissavano. Anche il Magnifico Rettore, che qui chiamano semplicemente Doyen, si è mostrato entusiasta. Con il professor Mhamdi ed il professor El Iri ci ha dato appuntamento per domani nel suo ufficio per discutere dell’idea del Continente Mediterraneo. Ho trovato straordinaria questa apertura che è frutto di sensibilità penso, ma anche di consapevolezza che gli equilibri del mondo sono destinati a cambiare a breve e sarebbe davvero una tragedia se il Mediterraneo non ne fosse protagonista.
Antonio Corvino

Antonio Corvino, di origini pugliesi, napoletano di formazione è un saggista ed economista di lungo corso, di cultura classica, specializzato in scenari macro economici ed economia dei territori.
Direttore generale dell’Osservatorio di Economia e Finanza, specializzato nell’analisi dell’economia del mezzogiorno e del Mediterraneo oltre che nella costruzione degli scenari macroeconomici in cui Mezzogiorno e Mediterraneo sono inseriti.
In tale veste ha organizzato dal 2011 al 2015 il “Sorrento Meeting” che ha affrontato, grazie al concorso di intellettuali, studiosi, rappresentanti economici e politici, controcorrente, dell’intero Mediterraneo e di altri Paesi asiatici ed americani, con largo anticipo e visioni non scontate, le questioni esplose in maniera virulenta, negli anni più recenti: dai nodi gordiani del sottosviluppo alle migrazioni, dai giovani nuovi argonauti in cerca del futuro da qualche parte, all’effetto macigno dell’Euro sull’economia Mediterranea ed al negativo condizionamento del paradigma nord-atlantico su di essa, dall’energia alla logistica, al destino del Mediterraneo che ahimè appare sempre più compromesso.
Già Direttore nel Sistema Confindustria ha ricoperto diversi incarichi a livello nazionale, regionale e, da ultimo, anche a livello territoriale.
Appassionato delle antiche vie nelle “terre di mezzo” ha percorso numerosi cammini nel cuore del Mezzogiorno continentale coprendo oltre 1500 chilometri e traendone una serie di appunti di viaggio che han dato vita a diversi volumi e romanzi di cui “Cammini a Sud” è il primo ad essere stato pubblicato.
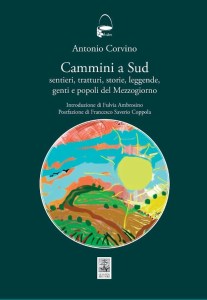
Cultore di arte ha frequentato molti artisti, talora legandosi di profonda amicizia con essi. E’ il caso di Pino Settanni, scomparso nel 2010, artista e fotografo di straordinaria sensibilità e levatura, presente nei musei internazionali, il cui archivio è stato acquisito dall’Istituto Luce-Cinecittà.
Dedito da sempre alla scrittura, questa è divenuta da ultimo la sua principale occupazione, spaziando dal romanzo di introspezione intima e personale sino all’ osservazione lucida quanto preoccupata delle derive antropologiche destinate a scivolare verso una visione distopica che solo nella memoria può trovare l’antidoto.
Nel dicembre 2019 ha curato per Rubbettino il volume “Mezzogiorno in Progress”. Un volume-summa sulla questione del Sud cui hanno collaborato trenta tra studiosi economisti ed intellettuali e trenta imprenditori fuori dagli schemi.
Sin dalla più giovane età ha collaborato con riviste di economia, tra cui “Nord e Sud” che annoverava, essendo egli un giovane apprendista, le migliori menti del Mezzogiorno. Ha collaborato, in qualità di esperto opinionista, con diversi quotidiani meridionali. Tuttora scrive su riviste specializzate in scenari economici e problematiche dello sviluppo.
Da ultimo, per l’Università Partenope, il CEHAM, e l’Ordine dei biologi, ha realizzato un corso monografico video sul Mediterraneo della durata di 15 ore destinato ad un master.
Sulla rivista Bio’s, Organo dell’Ordine nazionale dei Biologi, ha pubblicato tre saggi sulle prospettive del Mediterraneo alla luce dell’implosione della globalizzazione, indicando un nuovo paradigma policentrico dello sviluppo e proponendo la suggestione del Mediterraneo come Continente; nell’ultimo saggio si è soffermato sul ruolo del Mediterraneo nella crisi alimentare ipotizzando il ritorno della agricoltura familiare e del recupero della biodiversità quali strade maestre per una nuova visione di sviluppo legata alla valorizzazione dei territori e della agricoltura meridionale.
Sulla rivista Politica Meridionalista ha pubblicato e continua a pubblicare numerosi saggi sul Mezzogiorno indicando i Cammini e le Terre di Mezzo quali orizzonti per combattere lo spopolamento e l’abbandono dei territori interni.