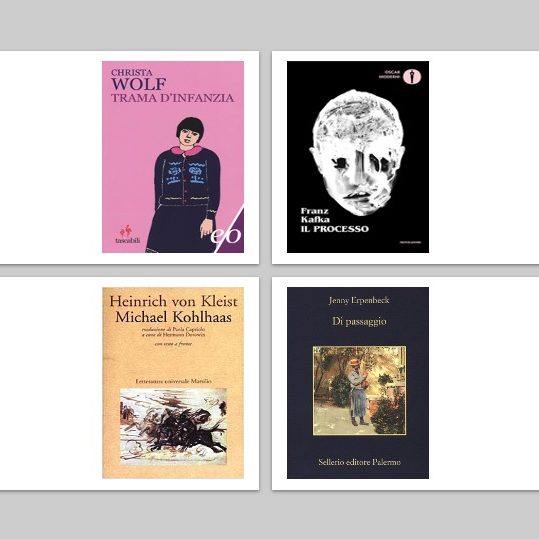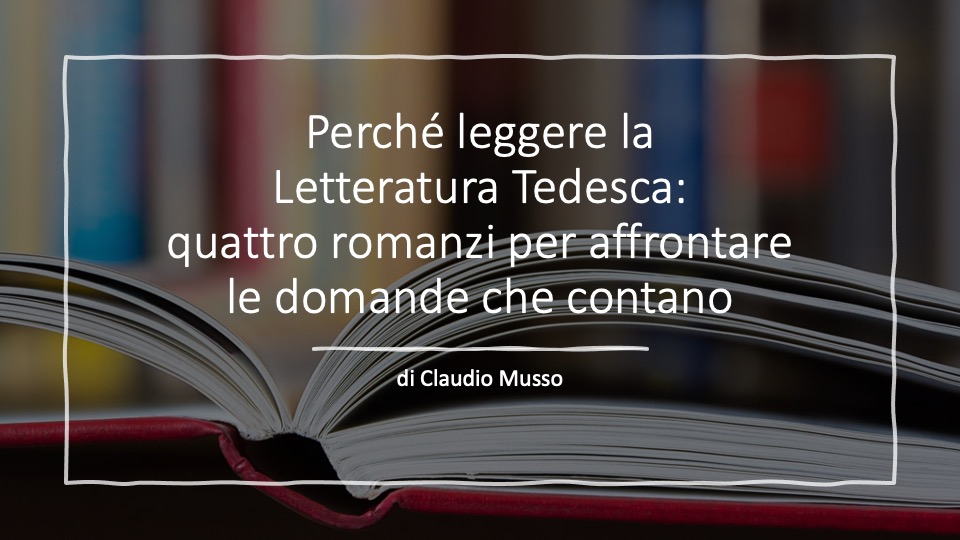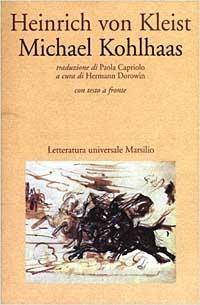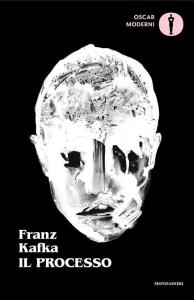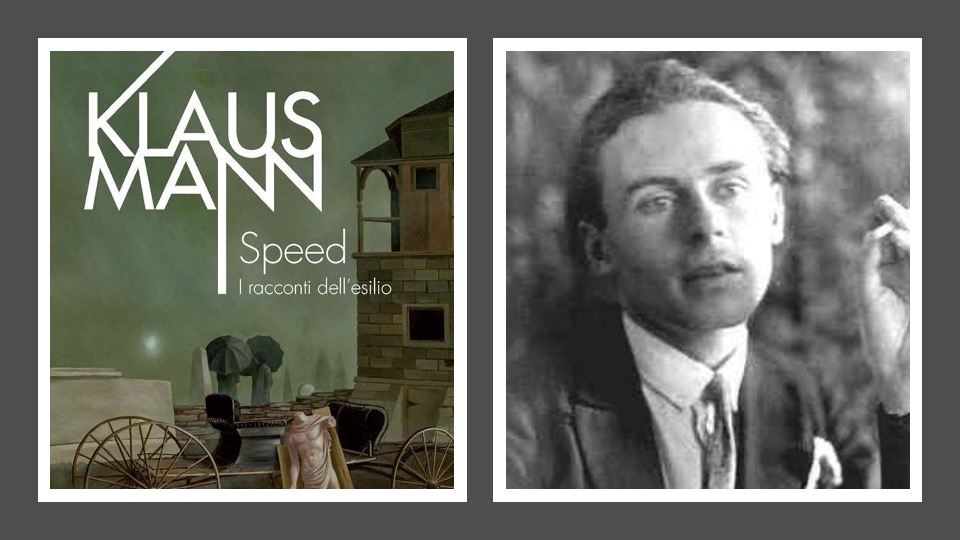L’innocente Effi Briest
Theodor Fontane (Germania 1819 – 1898) era dai ritratti un classico personaggio ottocentesco, con grandi baffi, corpulento, un’aria arguta.
Di professione era farmacista ma mentre miscelava gli intrugli dell’epoca doveva immaginare molte cose; la sua attività parallela di scrittore è assai vasta: romanzi, racconti, poesie, articoli.
“Effi Briest“, pubblicato tra il 1894 e il 1895, dapprima in una rivista e poi in volume, è il suo romanzo più celebre, tradotto in numerose lingue.
In Germania sono stati realizzati ben quattro film ispirati alla trama.
Uno, del 1974, molto bello, venne diretto da un ventinovenne Rainer Werner Fassbinder ed intensamente interpretato da Hanna Schygulla. Ci si potrebbe domandare perché un romanzo di fine ottocento ambientato prima in Pommern (Pomerania) e poi a Berlino, capitale del Königreich Preußen (Regno di Prussia) avesse attratto il regista più particolare del nuovo cinema tedesco.
Leggendo il libro si può comprenderne il motivo.

“Effi Briest” incomincia come un classico romanzo del tempo: Effi è una ragazza molto carina, diciassettenne, vivace, che vive spensieratamente insieme ai suoi amati genitori e ha tre care amiche. Suona un po’ il pianoforte, ricama, e non ha intenzione di sposarsi finché, inaspettatamente, non capita a casa loro un antico spasimante della madre, il barone Geert Innstetten, che ha 37 anni (un’età allora matura).
Il barone ha un prestigioso incarico amministrativo, è laureato in legge, è agiato e tutto fa prevedere che farà una bella carriera.
Egli chiede la mano di Effi. Sia lei, sia i genitori acconsentono.
Ma ben presto il romanzo, ispirato ad un fatto di cronaca vera che suscitò grande clamore, prende una piega inaspettata e si legge tutto d’un fiato.
In questa storia tutto sommato semplice non vi è nulla di scontato perché Fontane elabora il testo con maestria.
Innstetten è un personaggio impeccabile, tutto ciò che dice sembra ragionevole, è ligio alle convenzioni sociali, lavoratore modello, ambizioso ma paziente.
Effi non è innamorata di lui ma lo stima.
Egli la considera una bella fanciulla da dirigere e plasmare – un po’ come il Torvald di “Casa di bambola” di Henrik Ibsen (1879) considerava la moglie Nora.
Solo se lei si concede qualche battuta scherzosa sui suoi ammiratori, il suo sguardo diventa duro.
Ma dietro questa facciata si cela un marito freddo e senza alcun amore – anche se verso la fine egli dirà ad un amico di amare Effi. E forse per un attimo è sincero anche se per lui che cosa pensa la società è ben più importante della moglie.
Non le dà supporto quando lei prova nostalgia della casa paterna e della sua cittadina bruscamente lasciata per un’altra, prende in giro un gentilissimo spasimante di lei, un farmacista un po’ gobbo, premuroso e ammodo.
Nella piccola città prussiana in cui lui ha condotto la moglie, lei viene accettata di malavoglia dalla borghesia che Fontane descrive con pochi incisivi tratti: un ambiente di idee assai ristrette e molto conservatrici, si detesta sia la memoria di Napoleone, sia i cattolici, sia i moti libertari degli studenti, si invoca in modo retorico la patria, si osserva una religione di facciata, ci si scandalizza per i romanzi di Zola.
Tutto ciò diventa oppressivo per Effi. Incomincia ad avere strane impressioni, teme i fantasmi, viene turbata da una misteriosa storia accaduta anni prima (qui il romanzo risente un po’ del gotico inglese e Fontane era un ammiratore della letteratura inglese).
Entra un po’ in confidenza con Roswitha, una giovane cameriera, che al suo paese era stata quasi uccisa dal padre, un contadino, perché incinta e le era stata tolta la sua neonata data in “adozione” a chissà chi (queste estreme violenze accadevano realmente allora).
Dopo poco tempo Effi ha una bambina che ama molto e verso cui il padre ha un comportamento cortese ma non affettuoso, che invita sempre al dovere.

Finché nella cittadina non arriva il maggiore Crampas. Ex commilitone di Innstetten, Crampas non ha nessuna particolare qualità ma neppure grandi difetti, ha i capelli e i baffi biondi rossicci, è noto per fare una discreta corte alle signore nonostante abbia una moglie depressa e due figli.
Effi non rimane particolarmente colpita da lui, lo frequenta più per solitudine che per altro anche se Innestenn non approva le loro cavalcate sulla spiaggia d’inverno del mar Baltico.
Sarà Crampas a trascinare Effi in una relazione sentimentale ma l’adulterio non è il tema del romanzo, il tema è un formidabile atto di accusa verso la società bismarckiana. La cosa più sorprendente è che esso provenga da un borghese, un distinto farmacista che aveva la bizzarra mania di scrivere romanzi. “Effi Briest” ci ricorda che la società emana norme e comportamenti severi e che diventa crudele verso chi osi innocuamente infrangerli.
Probabilmente fu questo ad attrarre Fassbinder – l’adeguamento alle convenzioni sociali che può condurre al crimine.
E ciò rende “Effi Briest” un romanzo sempre attuale.
Non sono mancati paragoni con “Anna Karenina” (1877) di Lev Tolstoj e “Madame Bovary” di Gustave Flaubert (1856) anche se sono romanzi molto diversi fra di loro. Effi Briest nella sua vivace ingenuità è molto tedesca così come Anna Karenina è profondamente russa e Emma Bovary una francese di provincia.
Fontane registra accuratamente gli stati d’animo della sua eroina facendo di questo romanzo anche un romanzo psicologico.
Presumibilmente “Effi Briest” sarebbe piaciuto allo psicoanalista Erich Fromm che scrisse un saggio sui danni del conformismo, “Fuga dalla libertà” (1941).
Thomas Mann lo pose tra i sei libri che avrebbe portato con sé e il suo dissidio tra vita borghese e vita d’artista o sregolata ha qualche analogia con la vitalità di Effi Briest e la rigidità di Innestenn.
Tra parentesi, un personaggio del libro al quale sono dedicate solo poche righe si chiama Buddenbrook.
Lavinia Capogna*

*Lavinia Capogna è una scrittrice, poeta e regista. È figlia del regista Sergio Capogna. Ha pubblicato finora otto libri: “Un navigante senza bussola e senza stelle” (poesie); “Pensieri cristallini” (poesie); “La nostalgia delle 6 del mattino” (poesie); “In questi giorni UFO volano sul New Jersey” (poesie), “Storie fatte di niente” , (racconti), che è stato tradotto e pubblicato anche in Francia con il titolo “Histoires pour rien” ; il romanzo “Il giovane senza nome” e il saggio “Pagine sparse – Studi letterari” .
E molto recentemente “Poesie 1982 – 2025”.
Ha scritto circa 150 articoli su temi letterari e cinematografici e fatto traduzioni dal francese, inglese e tedesco. Ha studiato sceneggiatura con Ugo Pirro e scritto tre sceneggiature cinematografiche e realizzato come regista il film “La lampada di Wood” che ha partecipato al premio David di Donatello, il mediometraggio “Ciao, Francesca” e alcuni documentari.
Collabora con le riviste letterarie online Il Randagio e Insula Europea.
Da circa vent’anni ha una malattia che le ha procurato invalidità.