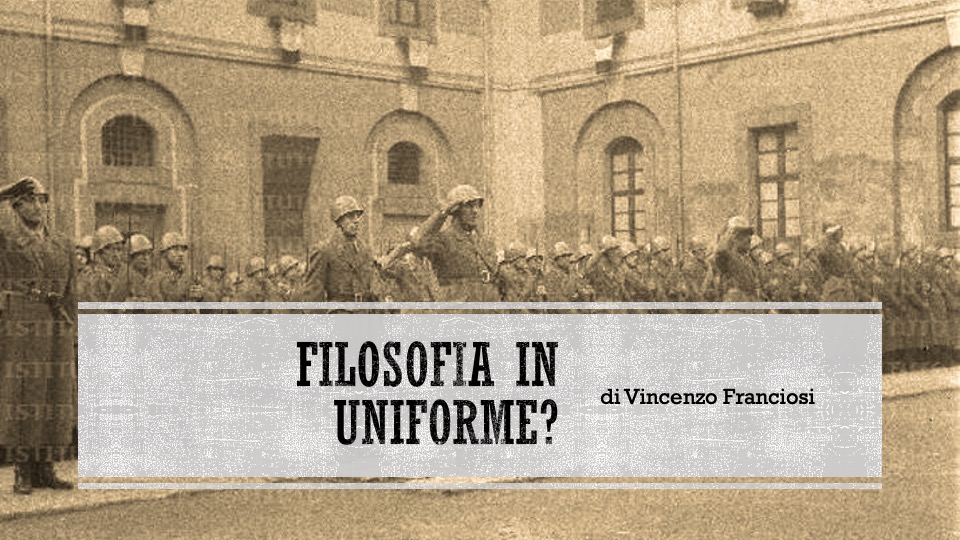La scrittrice napoletana Wanda Marasco con il romanzo Di spalle a questo mondo (Neri Pozza 2025) si è aggiudicata il Premio Campiello 2025.
Conosco Wanda Marasco da molti anni e immagino che vivendo in passato vicino alla Torre del Palasciano si sia sentita ad un certo punto attratta o forse anche trascinata, dalla vicenda umana del medico filantropo Ferdinando Palasciano e di sua moglie Olga Pavlova Vavilova, che lì abitarono; ritengo sia stato questo uno dei principali motori che l’ha spinta a richiamarli in vita attraverso la sua scrittura.
Wanda Marasco anche in questo romanzo, così come in precedenza ne La compagnia delle anime finte e ne Il genio dell’abbandono (anch’essi pubblicati da Neri Pozza, rispettivamente nel 2015 e nel 2017), scava in profondità sul senso del dolore, interrogandosi sul bene e sul male da cui è pervasa l’umanità. Infatti anche Ferdinando Palasciano e Olga Pavlova Vavilova sono portatori della lacerante sofferenza o male del mondo, che vivono in maniera differente: lei attraverso una psico somatizzazione della sua zoppia, lui assorbendo come medico tutto il dolore degli altri e infine impazzendo. L’autrice in questo romanzo affronta con grande capacità il tema della follia, non considerandola mai qualcosa di lontano, ma una sorta di mistero della psiche umana.
Ho voluto porre a Wanda due domande specifiche relative alla sua opera.

Cara Wanda, un elemento che mi interessa molto è il significato altissimo, visto da una prospettiva morale e medica della cura degli esseri umani, quello che spinge Ferdinando Palasciano a curare anche il nemico, pur essendo medico borbonico durante i rivolgimenti di Messina del ’47-’48 e la riconquista borbonica. In ciò mi è parso di trovare uno degli aspetti più grandi della missione di Palasciano, quando egli dice ‘’l’atto di curare non può fare differenza tra gli uomini’’. La medicina può essere dunque una missione sacra? Qualcosa che sfiora l’eternità?
La cura è l’ideale di Ferdinando Palasciano, è ciò che lo spinge a curare anche il nemico, perché a Messina, durante i moti del 48, comprende che l’atto di curare non può fare differenza fra gli uomini. Mentre era alfiere medico dell’esercito borbonico, sceglie di essere più medico che soldato. E la medicina è certamente una missione sacra. Palasciano può essere considerato un antesignano, un Gino Strada dei suoi tempi. Quanti medici e infermieri abbiamo visto anche morire, per esempio, nel periodo della nostra pandemia! Sì, è una missione sacra e credo che sia qualcosa che sfiora l’eternità, perché non c’è niente che debba permanere più dell’atto benefico verso la creatura umana.
Leggendo i tuoi romanzi si ha la netta sensazione di una lingua nuova e antica, originalissima, di una lingua precisa ma al tempo stesso ricca e trasfigurata, attraverso la quale tu compi un lavoro abissale di scavo all’interno della psiche e dell’emotività dei personaggi. Qual è il tuo rapporto con la tua stessa lingua?
La mia lingua è una lingua nuova e antica, nel senso che tiene conto della tradizione, ma, come sempre deve avvenire, la tradisce. E’ una lingua in cui si sono congiunte la istintualità poetica, la meditazione e la necessità di narrare. La lingua è forse il primo personaggio, per così dire, dei miei romanzi, che sono sempre caratterizzati da una alternanza di registri, dal comico al tragico. E qui, in Di spalle a questo mondo, con una prevalenza della prosa lirica, che mi consentiva il cosiddetto lavoro abissale e più profondo all’interno della psiche e della intensità dei vari personaggi. Il mio rapporto con la lingua è un rapporto di corpo a corpo, di mente a mente. Io stessa forse scrivo perché voglio essere scrittura, voglio diventare scrittura. Scrivo per questa indomabile necessità.
Cristiana Buccarelli

Cristiana Buccarelli è una scrittrice di Vibo Valentia e vive a Napoli. È dottore di ricerca in Storia del diritto romano. Ha vinto nel 2012 la XXXVIII edizione del Premio internazionale di Poesia e letteratura ‘Nuove lettere’ presso l’Istituto italiano di cultura di Napoli. Ha pubblicato la raccolta di racconti Gli spazi invisibili (La Quercia editore) nel 2015, il romanzo Il punto Zenit (La Quercia editore) nel 2017 ed Eco del Mediterraneo (IOD Edizioni) nel 2019. Con Eco del Mediterraneo (IOD Edizioni) ha vinto per la narrativa edita la V edizione del Premio Melissa Cultura 2020 e la IV edizione Premio Internazionale Castrovillari Città Cultura 2020. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo romanzo storico I falò nel bosco (IOD Edizioni), col quale ha vinto per la narrativa edita la XVI edizione del Concorso letterario Internazionale Città di Cosenza 2024. Nel 2023 ha pubblicato il romanzo Un tempo di mezzo secolo (IOD Edizioni), finalista per la narrativa all’XI edizione del Premio L’IGUANA- Anna Maria Ortese 2024. Nel 2025 ha pubblicato Taccuini di viaggio (Cervino Edizioni 2025). Collabora con la rivista letteraria Il Randagio.