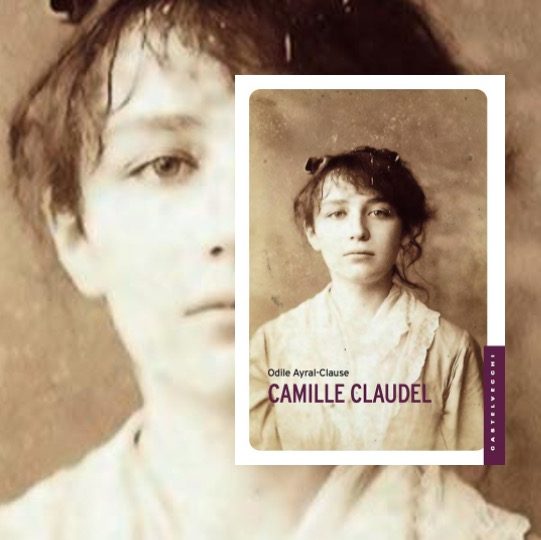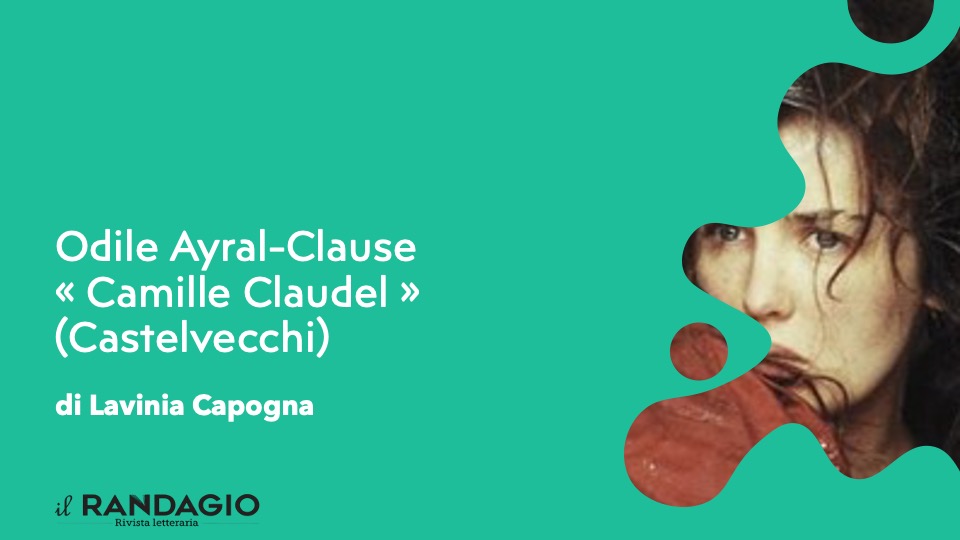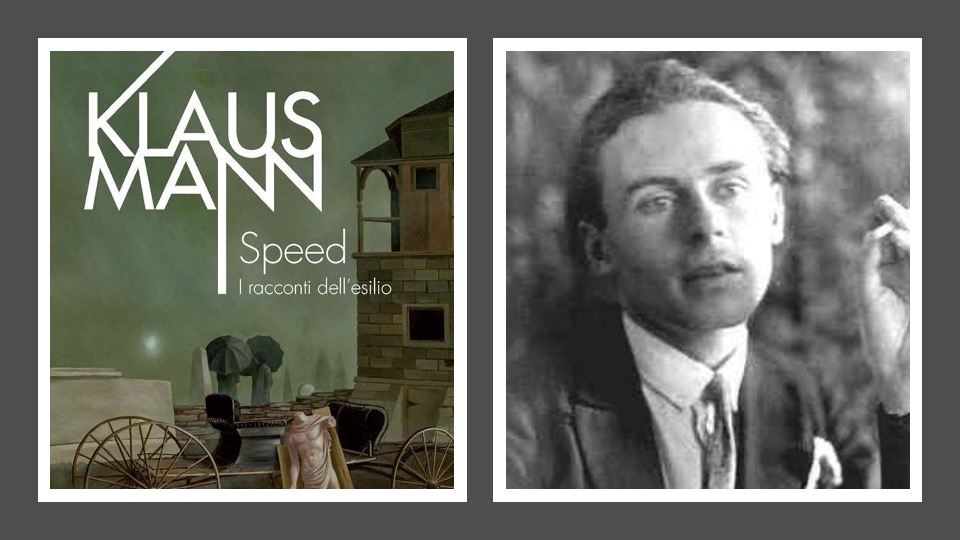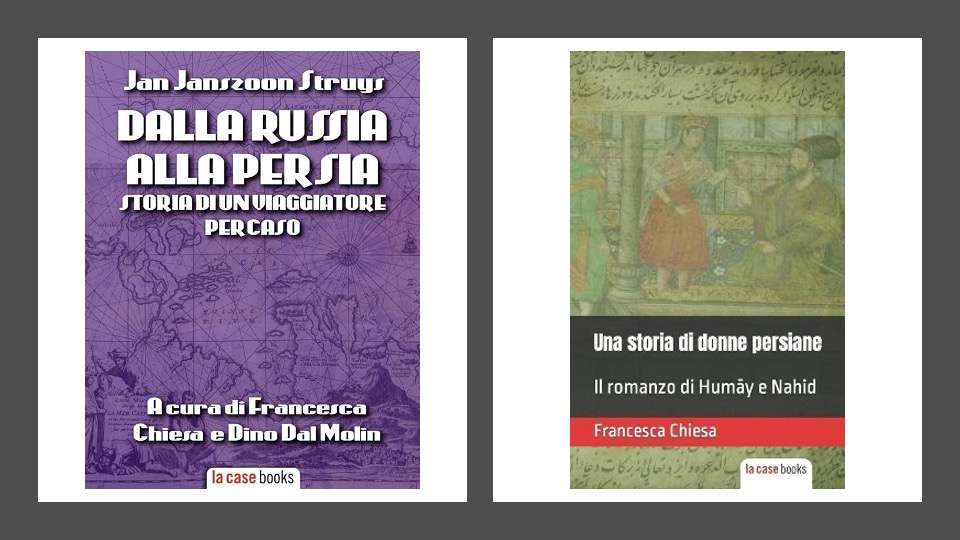Ho conosciuto il romanzo di Angelo Scuderi, “Prima di dirsi addio”, edito da Castelvecchi, per caso, su Instagram, imbattendomi nell’hashtag #cercandobea.
Con la curiosità che mi contraddistingue, sono andata a scavare e ho trovato un racconto forte, dove tutti i sentimenti sono sospesi. Beatrice e Leonardo, i protagonisti, sono due ragazzi giovani, che si incontrano per caso in una stazione siciliana, ma la loro età non trasmette la spensieratezza che meriterebbe, bensì una sofferenza non risolta che nel dipanarsi del romanzo è un crescendo continuo di esperienze attraverso gli anni che passano.
Mentre leggevo sono stata a tratti catturata dal tono lirico e quasi onirico di alcuni passaggi e a tratti stupita da uno stile narrativo all’imperfetto, un tempo che ricorda i verbali delle forze dell’ordine, che dal presente non si stacca mai né dal passato né dal vissuto traumatico dei due protagonisti, che si sfiorano e si allontanano come gli estremi di una molla.
Ho apprezzato il finale inaspettato, così ho voluto fare una chiacchierata virtuale con Angelo Scuderi, per approfondire le tecniche e le ispirazioni del suo romanzo d’esordio, non potendo essere presente alla sua prossima tappa del booktour, a Catania il 5 dicembre alla libreria Mondadori.

L’episodio iniziale dell’incontro in stazione con una ragazza di nome Bea è un fatto realmente accaduto. Quanto è stato difficile o naturale trasformare un ricordo personale in una narrazione romanzata?
“Io sono della scuola dei mentitori cretesi, l’antico paradosso che non permette soluzione tra verità e bugia. E’ stato naturale ritrovare in quell’incontro giovanile con Bea, una idea funzionale alla storia. Bea, di Verona, era nel 2016 in viaggio di maturità classica a Taormina e si stava spostando a Tindari. Il fatto di conoscersi alla stazione, già abbastanza romantico, l’emozione nascente, non aver considerato di chiederle alcun contatto, relegato com’ero nell’imbarazzo e nella trasognanza, e lei là sugli scalini dell’autobus, in attesa forse che io le chiedessi qualcosa, un numero almeno, dopo avermi invitato a raggiungerla il giorno seguente. Tutto questo era materiale da racconto a mio parere. Ed era il momento di cominciare a mentire, anche allo scopo di ritrovarla e ringraziarla per avermi tanto ispirato, con così poco o con così tanto.”
Il romanzo è scritto prevalentemente all’imperfetto, un tempo verbale che in italiano suggerisce un’azione incompiuta, un qualcosa che dura nel tempo come i traumi dei protagonisti. Perché questa scelta singolare della narrazione temporale?
“L’imperfetto è il tempo della continuità nel passato, è il tempo della ripetizione agentiva. I due protagonisti sono, per ragioni diverse, ossessivamente ricondotti nel loro passato. Ho scelto l’imperfetto – e ne faccio un uso che è davvero molto raro, se non un unicum – per dare il senso di questo reiterato tentativo di riportare il passato nel presente, per creare un ponte, appunto, di continuità, tra queste due istanze temporali, e riconsegnare anche il senso della ripetizione martellante degli eventi trascorsi nella mente dei due personaggi. Solo in un punto del romanzo – quattro righe – viene usato il remoto, a cui da siciliano sono tanto affezionato. La puntualità del remoto infatti sigla un distacco netto da ciò che è accaduto, lasciandolo indietro, dicendogli addio.”
Il lettore viene a volte portato a “chiarire il presente attraverso il passato” tramite salti e flashback. Quali difficoltà hai incontrato nel mantenere un equilibrio tra la necessità di svelare il vissuto dei protagonisti e quella di mantenere la tensione narrativa?
“Da studioso di filosofia e psicologia ho un rapporto viscerale con la temporalità e con i ricordi. La tragedia dello scrittore sta nell’immaginare avendo di fronte un nulla di oggettivo. E’ la stessa tragedia del rammemorante, tragedia in senso sublime, perché è anche motivo di elevazione spirituale. Nelle allucinazioni controllate del sogno ad occhi aperti, che definisco, citando Bachelard, trasognanza, ritrovo il senso ultimo della letteratura. La tensione narrativa diventa una tensione delle tre dimensioni temporali in relazione alla distensione dell’anima. Mantenerle insieme è la funzione principale dell’anima, o dell’encefalo, per dirla con una terminologia più attuale. Materia e Memoria di Bergson è stata una lettura fondamentale durante la scrittura. Bisogna perdersi nei meandri oscuri del disvelamento dei ricordi, come accade ai personaggi.”
Il segreto rivelato nelle ultime pagine conferisce una nuova chiave di lettura di tutto il romanzo: si passa dal destino al senso di colpa. Perché la scelta di collegare un amore tormentato a un ricordo così labile e sfumato come quello infantile?
“Non conosciamo l’origine del nostro turbamento, è una ricerca impossibile, difficile darne una maternità unitaria. Rileggere il momento del primo incontro tra Bea e Leo in stazione alla luce del finale è spiazzante, dà un senso nuovo alla storia, il senso del destino, dello scontro tra reminiscenza (Bea) e oblio (Leo). Ho voluto lasciare il lettore libero di interpretare il finale e di scandagliare il senso dalle azioni. Fa parte del mio approccio comportamentista, solo attraverso l’analisi del comportamento possiamo inferire significati e stati mentali delle persone, così dei personaggi. Cosa succede davvero? Cosa è ricordo e memoria e trauma? La cosa più straordinaria dei ricordi è che a volte sono veri. E’ nell’infanzia che bisogna ricercare l’origine del vero e del costruito.”
”Non esiste lezione così atroce che un uomo non possa mai dimenticare.” E una frase che ricorre e che sembra essere smentita dalla condanna di Beatrice a ricordare tutto e per sempre. Quale lavoro di ricerca nella mente umana hai dovuto compiere per descrivere una differenza così pregnante fra chi ricorda tutto e chi tende a dimenticare?
“Hai colto perfettamente il senso tragico della storia. La narrazione si ispira alla tradizione della tragedia greca che respiro quotidianamente abitando a Siracusa. Avevo in mente di scrivere una storia che trattasse il tema della memoria e riflettevo sulla mia difficoltà nel rammemorare gli eventi della mia infanzia, laddove invece mia sorella riesce a ricordare tutto nei minimi dettagli. Da questo scontro di contrari nasce la tragedia, come in Antigone il fulcro è lo scontro tra legge positiva dello stato e massima morale individuale, così in Prima di dirsi addio rinveniamo l’idea forte dello scontro tra memoria e oblio. Sono Gian e Bea a pronunciare questa frase in momenti diversi, loro sono consapevoli, Leo, invece, crede di ricordare, ma crede, appunto.
“Prima di dirsi addio” è il tuo romanzo d’esordio. C’è già in cantiere un nuovo progetto letterario e, in caso affermativo, manterrai un’impronta legata all’introspezione e alla relazione o esplorerai generi diversi?
“Ho in cuore almeno due romanzi. Il primo, più metaletterario, ha l’intenzione di seguire le orme posate in nuce da Prima di dirsi addio, e di scandagliare il rapporto tra scrittura e memoria, tematica platonica sicuramente. L’altro è sorprendente, perché, immagino, che per le prime cento pagine segua la corrente intimista dalla mia scrittura, ma si riveli essere altro, chissà, forse anche un giallo o un romanzo politico o un distopico. Vorrei anche pubblicare i miei racconti, tutte finzioni della provincia di Messina.”
Questo romanzo è la tua soluzione per ritrovare una persona che ti è piaciuta per un attimo, ma che potrebbe rivelarsi più o meno interessante della donna narrata nel tuo libro. Accetti il rischio di incontrarla atraverso l’hashtag #cercandobea e rimanerne o tremendamente deluso o profondamente colpito?
“Dovremmo tutti promettere senza mantenere mai” viene detto nel romanzo. Sono sicuro che Bea è una persona straordinaria, mi sbaglio raramente. Come tutte le persone straordinarie deve poter deludere per essere reale. Storicamente, posso dirti che sono più deludente io, non ho alte aspettative, le chiedo quindi di non averne, nemmeno lei. #cercandobea è di tutti d’altra parte, tutti ricerchiamo qualcosa di perduto, Bea per me è metafora di tante cose, Prima di dirsi addio è questa ricerca.
Loredana Cefalo*

* Mi chiamo Loredana Cefalo, classe 1975, vivo a Cagliari, ma sono Irpina di origine e per metà ho il sangue della Costiera Amalfitana. Da cinque anni tengo una rubrica di chiacchiere a tema vario su Instagram, in cui intervisto persone che hanno voglia di raccontare la loro storia.
Sono stata una professionista della comunicazione, dell’organizzazione di eventi e della produzione televisiva, settori in cui ho un solido background. Mi sono laureata in Giurisprudenza e ho un Master in Pubbliche Relazioni.
Ho accumulato una lunga esperienza lavorando per aziende come Radio Capital, FOX International Channels, ANSA e Gruppo IP, ricoprendo ruoli significativi nel settore della comunicazione e dei media, fino a quando non ho scelto di fare la madre a tempo pieno dei miei tre figli Edoardo, Elisabetta e Margaret.
In un passato recente ho anche giocato a fare la foodblogger e content creator, con un blog personale dedicato alla cucina, una delle mie grandi passioni, insieme all’arte pittorica e la musica rock.
L’amore per la scrittura, nato in adolescenza, mi ha portata a scrivere il mio primo romanzo, “Il mio spicchio di cielo” pubblicato il 16 gennaio 2025 da Bookabook Editore e distribuito da Messaggerie Libri. Il romanzo è frutto di un momento di trasformazione e di crescita. La storia è presa da una esperienza reale vissuta indirettamente e ricollocata nel passato per fini narrativi e per gusto personale. Ho abitato in molti luoghi e visitato con passione l’Europa e le ambientazioni del romanzo sono frutto dell’amore che provo nei confronti delle città in cui è collocato. Dal mese di giugno scorso curo il podcast del Randagio “Capitolo Zero”.