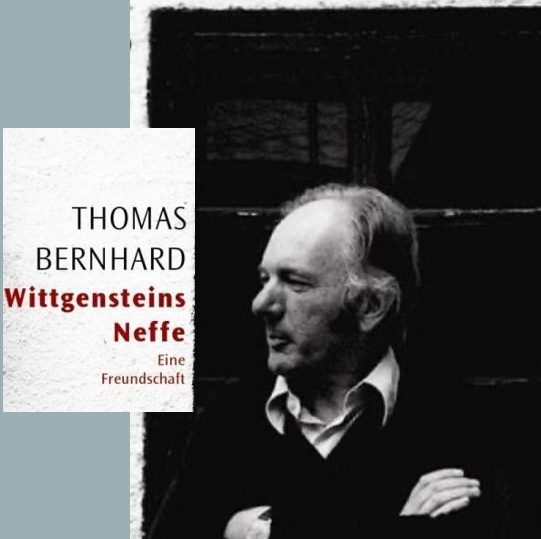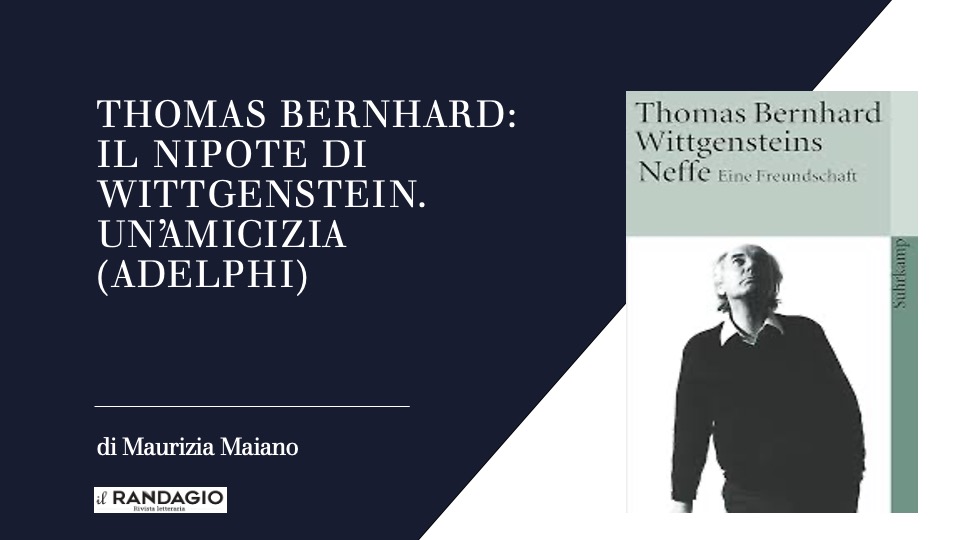Kafka non smette mai di parlarci. La sua scrittura nasce da una estraneità profonda. L’opera estraniante di uno scrittore alienato? La società capitalistica, il lavoro in fabbrica, il lavoro della produzione industriale cominciavano a mostrare il loro volto alienante. Erano anni di grandi stravolgimenti e di improvvise ricadute. Cambiare il mondo sarebbe stato possibile e anche l’arte avrebbe potuto contribuire a questa trasformazione; ma per farlo occorreva negare la tradizione. Brecht lo farà nel teatro che da classico aristotelico, diventerà epico e sostituirà la catarsi con l’effetto di straniamento – il Verfremdungseffekt. Lo spettatore non deve immedesimarsi nelle emozioni rappresentate: deve restare vigile, assumere un atteggiamento critico verso la realtà e i rapporti sociali, così da poterli mettere in discussione e persino sovvertirli. Dall’arte una spinta rivoluzionaria o l’ennesimo tentativo di cambiare un mondo che si ostina a non cambiare. Le opinioni sono diverse.
La teorizzazione brechtiana desidera un’arte capace di educare, rendere consapevoli, spingere all’azione. La sua è la fredda ragione che osserva scientificamente la realtà. È l’uomo su cui Musil ironizza perché vorrebbe interpretare i fatti secondo il semplice principio di causa ed effetto, ad una azione ne segue un’altra che sarà certa. E’ l’illusione di potersi proteggere dal caos. Ma la realtà è ingannevole, dietro questa illusione si nasconde una sola verità, l’eterno ritorno dell’eguale e nulla può davvero difenderci dal disordine del mondo.
Kafka, invece, non parte da astrazioni né da teorie. Il suo sguardo nasce sempre da situazioni concrete e vissute; si interroga sul proprio rapporto con la vita, con gli altri e lo sottopone a una riflessione che riguarda tutti e in cui tutti possono riconoscersi.
E chi meglio di lui può rappresentare la realtà in modo straniante? Solo chi vive l’alienazione in un mondo che non lo comprende e lo fa sentire inadeguato riesce a restituire con tanta precisione quel senso di smarrimento che è, in fondo, la cifra della nostra condizione.
L’identità di Kafka non è mai un luogo fisso, ma una sottrazione continua. Ovunque si trovi, è come se vi abitasse solo a metà. Il suo destino non è quello di appartenere, ma di osservare: questo lo condanna all’alienazione e al tempo stesso gli dà una lucidità unica. Le sue zone d’ombra possono essere riassunte in un elenco quasi geometrico:
Come ebreo, non appartiene al mondo cristiano.
Come ebreo indifferente, non del tutto agli ebrei.
Come tedesco di lingua tedesca, non appartiene ai cechi.
Come ebreo di lingua tedesca, non ai tedeschi della Boemia.
Come boemo, non all’Austria.
Come figlio della borghesia, non alla classe operaia.
Non si sente un impiegato, perché si pensa scrittore
Scrittore non lo è perché sacrifica le sue forze alla famiglia.
Scrive solo per sé, ma lo scrivere non la considera una professione

Il primato del padre: un retaggio antico
Kafka affonda lo sguardo nella storia di un ordine antico: il primato del padre, radicato nella nostra civiltà indoeuropea e inciso perfino nelle parole – padre, patria potestas, patrimonio. Il padre come legge, misura, autorità.
La Lettera al padre fu scritta da Franz Kafka nel 1919 e pubblicata solo dopo la sua morte, nel 1952. Si apre con parole che suonano familiari, quasi universali, ma lontane nel tempo:
Tu hai lavorato sodo per tutta la vita, hai sacrificato ogni cosa per i tuoi figli, soprattutto per me; io ho vissuto un’esistenza agiata, libero di studiare ciò che volevo, senza preoccuparmi di nulla. Non pretendevi gratitudine, ‘la gratitudine dei figli’, dici tu, ma almeno un po’ di gentilezza, un accenno di compassione. E invece io mi rifugiavo in camera tra i libri, nei miei amici stravaganti, nelle mie idee eccentriche.
Queste parole, pur appartenendo a un secolo fa, risuonano ancora oggi: riecheggiano la voce dei nostri nonni e dei nostri genitori, devoti ai figli in modo assoluto, e tuttavia mai del tutto soddisfatti dell’amore e del rispetto ricevuti. Sempre attenti alle aspettative, sempre pronti al sacrificio, sempre fragili nel loro bisogno di riconoscimento.
La tradizione biblica e la rivelazione cristiana rompono questo modello. Nel mondo ebraico, la patria potestas è già mitigata da un patto: dopo il diluvio Dio-Padre dice a Noè: non distruggerò più. Ma la svolta decisiva arriva con Cristo: per la prima volta un uomo osa chiamare Dio: Padre mio, con un’intimità prima considerata blasfema. Gesù non è solo figlio: è l’erede, colui che viene dal Padre e al Padre ritorna liberamente. In Lui nasce l’età del Figlio.
Cerchiamo un approccio diverso ed una possibile reinterpretazione con l’aiuto di Massimo Cacciari
Soffermandoci su alcuni passi fondamentali e a leggere tra le righe della Lettera al padre ritroviamo l’acuta sensibilità di Kafka. Egli sottolinea quella pericolosa diversità che caratterizza il rapporto padre – figlio:
eravamo così diversi e, in questa diversità, così pericolosi l’uno per l’altro. Tu mi avresti semplicemente calpestato, senza che di me rimanesse niente.
Eppure non attribuisce colpe:
non credo neppure lontanissimamente a una colpa da parte tua. Tu hai agito verso di me come dovevi agire.
E in questo riconosce la maschera che spesso ci imponiamo o che l’educazione ci fa intendere sia quella giusta, ma che prescinde da quella dell’amore e così continua in modo lieve sottolineando la sua fragilità di bambino:
ero un bimbo pauroso, ma anche testardo come lo sono i bimbi. Una parola gentile, un tacito prendermi per mano, uno sguardo buono avrebbero potuto ottenere da me tutto.
Ma la maschera, la tirannia paterna glielo facevano apparire:
avvolto per me dall’enigma di tutti i tiranni, il cui diritto è fondato sulla loro persona e non sul pensiero. Contro di te si era completamente disarmati. Incomprensibile mi è sempre stata la tua totale mancanza di sensibilità per il dolore e la vergogna che potevi infliggermi.
Parole violente che ferivano come una lama sottile. Quell’autorità inutile e spocchiosa che si manifestava inutilmente nella quotidianità:
quel che si metteva in tavola doveva essere mangiato, sulla bontà del cibo non si discuteva; ma tu spesso lo trovavi immangiabile, lo chiamavi “mangime” e affermavi che la “bestia” (la cuoca) l’aveva rovinato.
A tavola regnava un cupo silenzio, interrotto da:
‘Più alla svelta, più alla svelta’. E la tua fiducia in te stesso era tale che non avevi neppure bisogno di essere coerente, senza per questo smettere di avere ragione. Poteva anche accadere che tu su un certo argomento non avessi alcuna opinione, e quindi tutte le opinioni possibili in proposito dovevano essere sbagliate, senza eccezione. Potevi ad esempio insultare i Cechi, poi i Tedeschi, poi gli Ebrei, e non a un certo riguardo, ma sotto ogni punto di vista, e infine non rimaneva nessun altro a parte te.
Niente riusciva ad apprezzare del figlio che non era riuscito a plasmare a sua immagine e somiglianza, che non aveva seguito la strada che gli aveva indicato:
chiamavi gli impiegati ‘nemici prezzolati’. Urlavi, imprecavi e imperversavi come secondo la mia opinione di allora non accadeva in nessun’altra parte del mondo. E non soltanto imprecare, ma esercitare una tirannia gratuita. Ad esempio, con uno spintone scaraventavi giù dallo scrittoio merci che non volevi fossero scambiate con altre solo la sconsideratezza della tua collera ti scusava un poco e il commesso doveva raccattarle.
Anche la madre era succube del padre e tale era l’esercizio dell’autorità del padre su di lei che Kafka scrive:
se volevo fuggire da te (il padre), dovevo fuggire anche dalla mamma. E’ vero che presso di lei si poteva sempre trovare protezione, ma solo in riferimento a te. Ti amava troppo e ti era dedita con troppa fedeltà perché alla lunga potesse costituire una forza spirituale autonoma nella battaglia di suo figlio. E l’istinto infantile vedeva giusto, perché con gli anni la mamma divenne sempre più intimamente legata a te; mentre infatti, per quel che riguardava se stessa, conservò sempre la sua autonomia, entro strettissimi limiti, in modo bello e tenero, senza mai offenderti sostanzialmente, con gli anni accettò sempre più ciecamente e completamente, più col sentimento che con la ragione, i tuoi giudizi e le tue condanne nei confronti dei figli. La sua posizione era straziante e fino all’ultimo, snervante.
Quanto ad Irma, una nipote che era stata presa a lavorare nel negozio, e che per il padre aveva una venerazione, Kafka sottolinea l’innocenza con cui il padre affermava che:
non era stata una buona impiegata.
L’ebraismo era, inoltre,
vissuto come un gioco,
non frequentava assiduamente la sinagoga e
gli scritti ebraici gli davano la nausea.
E da dove veniva l’incapacità del figlio di prendere una decisione e convolare a nozze:
se non da quella pressione generica dell’angoscia, della debolezza e del disprezzo per me stesso?
Kafka e il ritorno impossibile.
Kafka sembra collocarsi esattamente qui: nel luogo dove il ritorno al padre è desiderato e temuto, impossibile e necessario. La sua lettera è una sorta di parabola alla rovescia: non il figlio dissipatore che rientra e trova un abbraccio, ma il figlio che non ha mai potuto davvero uscire, e che tuttavia non riesce più a rientrare. Il padre di Kafka non è il padre evangelico che corre incontro: è un sovrano, un giudice, un gigante.
Il bambino che Kafka era – timido, pauroso, testardo come tutti i bambini – si sarebbe potuto spezzare sotto il peso di un’autorità così massiccia. Eppure non è accaduto: qualcosa lo ha mantenuto in vita, forse una tenerezza intermittente del padre, forse la protezione della madre, forse la pura imprevedibilità della vita. Ma quanto è accaduto, ammette Kafka, forse è anche peggio: la relazione non è crollata, ma si è trasformata in paura, vergogna, senso di colpa. Il padre appare a Kafka
avvolto dall’enigma di tutti i tiranni, il cui diritto è fondato sulla loro persona e non sul pensiero.
Un’autorità che non ha bisogno di essere coerente per essere vera. Un’autorità che giudica senza sapere. Che ferisce senza accorgersene.
Lui stesso scrive: era come se non avessi idea del potere che avevi su di me.
Il bambino Kafka non vede un padre: vede un sovrano.
E pensa: posso sempre ricordargli tutto questo quando mi rimprovererà la mia ingratitudine.. Incomprensibile mi è sempre stata la tua totale mancanza di sensibilità per il dolore e la vergogna che potevi infliggermi con le tue parole e i tuoi giudizi; era come se non avessi la benché minima idea del tuo potere. Anch’io sicuramente ti ho fatto soffrire con le mie parole, ma l’ho sempre saputo, mi dispiaceva, ma non riuscivo a dominarmi, me ne pentivo già mentre lo dicevo. Tu invece con le tue parole colpivi indiscriminatamente, non ti dispiaceva per nessuno, né durante né dopo, contro di te si era completamente disarmati.
La crisi dell’età dei Figli
Nel Cristianesimo il Figlio è erede. Ma se i figli, diventati eredi, dimenticano il Padre? Allora nasce il conflitto tra uguali, la guerra tra fratelli. Per questo l’Illuminismo aggiunse alla libertà e all’uguaglianza la fraternità: senza un legame che trascende i singoli, gli eredi diventano nemici.
La Lettera al padre è lo specchio oscuro di questo: figli liberi, eredi di tutto, ma inchiodati da un terrore senza volto. Senza un padre misericordioso, e senza fratelli, restano soli davanti alla propria libertà.
Maria, la Misericordia dimenticata
Massimo Cacciari suggerisce che la filosofia e la teologia occidentali abbiano trascurato una figura decisiva: Maria, la Donna, simbolo di misericordia perfetta. La misericordia è ciò che tiene uniti i figli tra loro e al Padre. Non giudica, non punisce, non rivendica: ricorda semplicemente che siamo figli. È ciò che manca nella lettera di Kafka. È ciò che manca nella nostra civiltà: la capacità di essere eredi senza diventare accusatori. Dante lo aveva compreso: Maria è la prima a correre in soccorso dell’uomo smarrito nella selva. In lei il Figlio si rigenera, e con Lui la nostra umanità. Una società che dimentica questa dimensione non genera più, non trasmette più, non riconosce più le sue radici. Conclusione: la nostra Abendland è la voce di Kafka
Gli eventi del nostro tempo ci invitano a riflettere su questo: il nostro Occidente, sembra incapace di rinnovarsi perché ha dimenticato il suo codice originario: un padre che non è padrone, un figlio che è davvero libero, una fraternità che impedisce la guerra degli eredi, una misericordia che scioglie la durezza dei cuori. Kafka, nella sua lettera, non cerca una condanna: cerca un ritorno. Un ritorno che non trova. Un ritorno che può compiersi solo là dove il Figliol prodigo insegna a guardare: nell’incontro tra fragilità e perdono, tra autorità e accoglienza, tra padre e figlio.
Ed è forse questo il monito che ci consegna: una civiltà che non sa più tornare al Padre – o che non sa più essere Padre – finisce per smarrire anche i suoi figli.
Ebrei e cristiani mettono in dubbio questo primato. La patria potestas è vincolata ad un patto. Il padre stabilisce un patto con il figlio e dopo il diluvio dirà: “io Padre non ti distruggerò più”. Il salto diventa radicale con il Cristianesimo. Gesù afferma di essere Figlio di un Padre che è nei cieli e con il quale ha un’affinità che mai era stata affermata. Nel vecchio testamento era blasfemo dire ‘Padre mio’. Nei vangeli sinottici si afferma che la figura di Gesù è erede di tutto ciò che viene dal Padre. Gesù dice: “io sono la sola via verso il Padre” ma in contraddizione con il messaggio biblico precedente, Gesù dice: “amate il nemico”.
Gesù apre la nostra età e la nostra età è l’età del Figlio. Il cristiano crede che Cristo sia Figlio di Dio. Quest’uomo è divino. E’ un uomo che si sovrumana e si trascende. Cristo è pieno erede del Padre. Gesù è la via per il ritorno al Padre. Il figlio non è più la patria potestas, è colui che viene dal Padre e al Padre ritorna in piena libertà. Il figlio è erede e in quanto erede totalmente libero. L’età del figlio è quella in cui i figli sono totalmente liberi di tornare al padre. Nella parabola del buon Samaritano il padre non esercita alcuna patria potestas e il figlio ritorna dal padre da cui ha ereditato tutto ed in quanto erede libero. Il figlio si sente in angoscia per l’assenza del padre e questo lo spinge a tornare.
Per Kafka il ritorno è impossibile…L’annuncio del figlio dice che tutti siamo eredi ma cosa avviene se questi Figli non si rivolgono al Padre? E’ la guerra tra i Figli che, essendo tutti eredi, non possono appellarsi solo alla libertà e all’eguaglianza. L’illuminismo introdurrà la parola fraternità perché senza la fraternità è guerra fra noi. Se i Figli non si accomunano ad un bene che li trascende daranno vita ad una lotta perpetua tra di loro. L’evento è irreversibile e La lettera al padre di Kafka è l’oscenità della nostra società. I figli pieni eredi ed insofferenti di ogni potestas non possono che finire nel terrore. Se i figli non hanno un rapporto di fraternità vorranno affermare una potestas filiorum contro gli altri.
Cacciari dice che c’è una via che non è stata praticata né dalla filosofia né dalla teologia ed è la figura di Maria, la Donna. Maria è simbolo di perfetta misericordia. Perché la Donna è la misericordia? La Donna ricorda che si è figli ma figli nella misura di giustizia distributiva. Bisogna trascendere la condizione pattizia, la giustizia è misericordia e non deve volere pena e condanna ma perdono. Se dimentichiamo questa dimensione i Figli non saranno mai in un rapporto di fraternità. Lo scandalo della nostra civiltà è la totale dimenticanza di questa figura femminile all’interno dell’annuncio. I Figli atei mettono a morte il padre Lear e sono violenti come il padre. Dante mette l’accento sulla figura di Maria, è lei che si affanna per quell’uomo che si è smarrito nella selva. Questa Donna rigenera Dio e questo Dio che rigenera è il Figlio Gesù. Se non rileggiamo così la nostra società la nostra società non genererà più.
Gli accadimenti di queste ore ci servono per riflettere sullo stato delle cose e per cercare di capire perché questa nostra ‘Abendland’ stenta a cambiare e non riesce a dare una svolta definitiva al suo essere nel mondo.
Maurizia Maiano*

*Maurizia Maiano: Sono nata nella seconda metà del secolo scorso e appartengo al Sud di questa bellissima Italia, ad una cittadina sul Golfo di Squillace, Catanzaro Lido. Ho frequentato una scuola cattolica e poi il Liceo Classico Galluppi che ha ospitato Luigi Settembrini, che aveva vinto la cattedra di eloquenza, fu poeta e scrittore, liberale e patriota. Ho studiato alla Sapienza di Roma Lingua e letteratura tedesca. Ho soggiornato per due anni in Austria dove abitavo tra Krems sul Danubio e Vienna, grazie a una borsa di studio del Ministero degli Esteri per lo svolgimento della mia tesi di laurea su Hermann Bahr e la fin de siècle a Vienna. Dopo la laurea ritorno in Calabria ed inizio ad insegnare nei licei linguistici, prima quello privato a Vibo Valentia e poi quelli statali. La Scuola è stato il mio luogo ideale, ho realizzato progetti Socrates, Comenius e partecipato ad Erasmus. Ho seguito nel 2023 il corso di Geopolitica della scuola di Limes diretta da Lucio Caracciolo. Leggo e, se mi sento ispirata e il libro mi parla, cerco di raccogliere i miei pensieri e raccontarli.