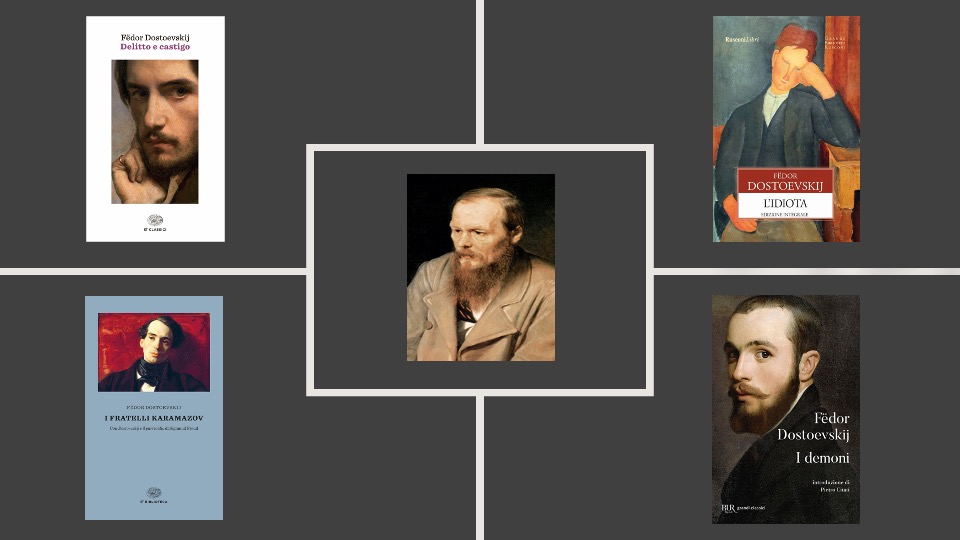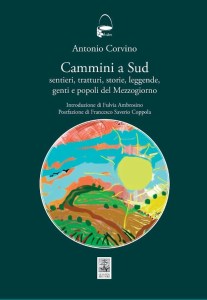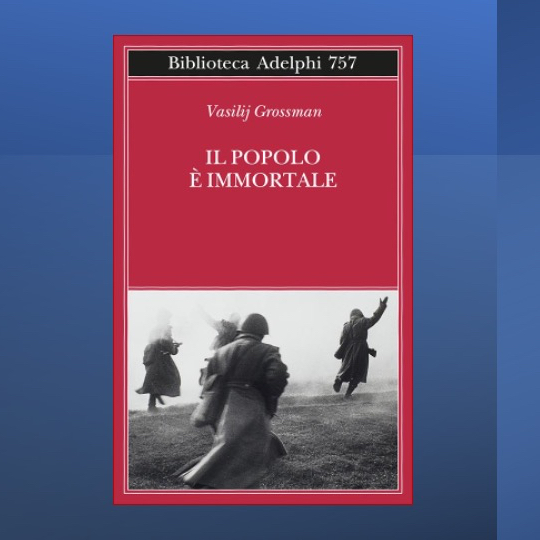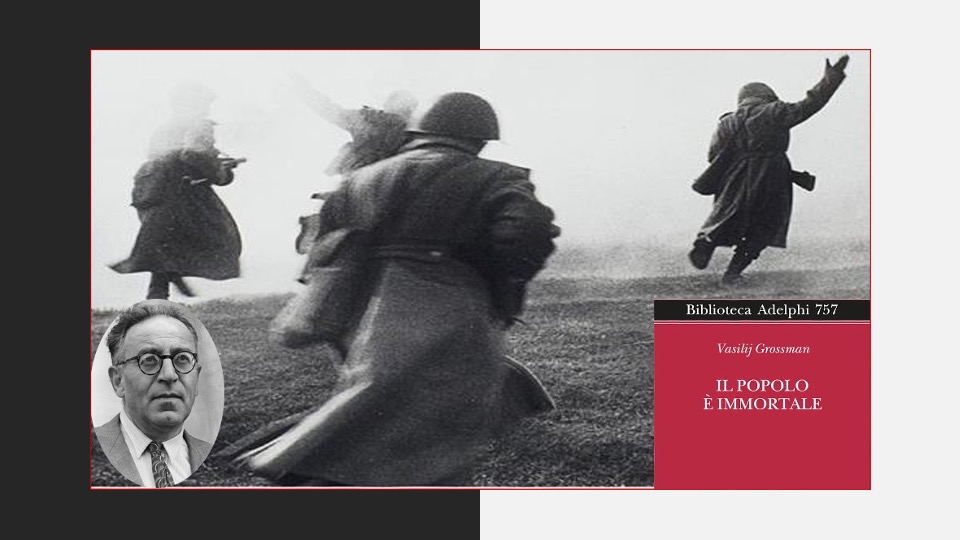Il noto romanzo Wuthering Heights (Cime tempestose) di Emily Brontë sarà pubblicato per la prima volta nel 1847 e sarà giudicato dalla critica ‘ perverso e brutale’. Emily, sorella delle altre due grandi scrittrici Charlotte e Anne, utilizzò lo pseudonimo di Ellis Bell, in quanto scrivere e pubblicare all’epoca era svalutante per una donna, così come esprimersi in qualsiasi ambito artistico. Ma Emily trasgredisce perché è nata per scrivere, come le sue sorelle, e un anno prima di morire a soli trent’anni di tubercolosi, ci lascia questo romanzo inquieto e passionale, profondamente umano e suggestivo: un capolavoro assoluto della letteratura inglese che supera ogni tempo.

Oggi è considerato uno dei più grandi classici della narrativa inglese, totalmente all’avanguardia per l’età vittoriana in cui è stato scritto, in quanto con esso si sovverte lo schema del romanzo ‘di buoni sentimenti’ per raccontare una famiglia che non è solo il luogo dell’accoglienza ma che può diventare anche un inferno in terra, un coagulo di sofferenza rabbia e vendetta.
Ho ripreso in mano Cime Tempestose (Edizione Feltrinelli 2014, trad. Laura Noulian) dopo moltissimo tempo. L’avevo letto da giovanissima, più di trent’anni fa, durante una vacanza estiva sui Monti della Lessinia, quando ancora non avevo compiuto dodici anni. Ricordo che restavo distesa sull’erba del prato della casa di montagna in cui alloggiavo con la mia famiglia senza riuscire a staccarmi dal romanzo in nessuna maniera: il mondo intorno a me aveva smesso di girare in quel momento e il fantasma di Catherine nel suo aggirarsi nella brughiera e intorno alla casa della Tempestosa alla ricerca di Heathcliff, il suo amore eterno, mi avrebbe suggestionata per molto tempo. Dopo molti anni ho finalmente adempiuto alla promessa che mi ero fatta di rileggerlo e l’effetto è stato immediato: non sono più riuscita a staccarmi dal romanzo per ore e giornate intere.
Heathcliff è senz’altro un personaggio complesso e indimenticabile: una sorta di antieroe intelligente, dannato, passionale, crudele, profondamente solo, un uomo ombroso e riservato di grande fascino, in cui si agitano sentimenti contrastanti di odio e amore, che non nasconde mai la sua rabbia, il suo desiderio di vendetta in età adulta, dopo essere stato maltrattato da ragazzo. Qui c’è una finissima analisi psicologica dell’autrice sugli elementi e le circostanze che contribuiscono a formare il carattere del suo personaggio. D’altra parte Heathcliff è un personaggio che, nonostante tutto, si fa amare per essere rimasto così fedele al suo amore infantile per Cathy, per la sua forte determinazione interiore e per il suo tormento continuo che non gli dà pace fino alla fine dei suoi giorni.
<< Il suo riserbo proviene da un’avversione spiccata alle manifestazioni esteriori di sentimenti e di benevolenza. Quest’uomo deve amare e odiare di nascosto…>>.

Anche Catherine Earnshaw, figlia dell’uomo che accoglie Heathcliff ragazzino povero e sperduto in casa, è un personaggio affascinante: una bimba selvaggia, capricciosa, testarda, che poi diventerà una donna fragile e incerta, che sceglierà il matrimonio sbagliato, e così rinuncerà a quella vita selvatica che conduceva da ragazzina in simbiosi con Heathcliff e quindi rinuncerà alla vera sé stessa, ma sarà anche capace di amarlo fino alla morte prematura di un amore tenace e segreto.
<<…Nelly, ma perché lui è più me di me stessa. Di qualunque cosa siano fatte le anime, certo la sua e la mia sono simili…>>
<<Vorrei essere ancora una fanciulla, mezzo selvaggia, fiera, libera, che se ne ride delle ingiurie…Perché sono così cambiata? Sono certa che tornerei ad essere me stessa, se potessi starmene in mezzo alla brughiera su quelle colline!>>
Quasi tutta la narrazione avviene attraverso la voce narrante del personaggio non protagonista di Nelly Dean, che rappresenta il perno, l’elemento di collegamento di tutto il congegno narrativo creato da Emily Brontë.
Ellen Dean è la governante che racconta a un’ospite, il signor Lockwood, il quale vivrà lì per un breve periodo, tutta la storia che si è svolta negli anni tra l’ampia casa di campagna detta la Tempestosa e Thrushcross Grange, nella brughiera dello Yorkshire, dove era vissuta la stessa autrice.
Il personaggio di Nelly Dean segue con affetto le vicende dei protagonisti nel tempo, è una donna saggia, onesta e generosa, ma a volte anche brusca e impertinente, tuttavia è l’unica persona assennata ed equilibrata di tutta la storia, intorno alla quale roteano tutti i personaggi, che sono svariati e abbastanza veritieri, in quanto ognuno di essi è descritto con le proprie luci e ombre.
Anche il paesaggio della brughiera è un grande protagonista del romanzo: è violento e incontaminato. Qui durante l’infanzia e l’adolescenza i due protagonisti, Heathcliff e Catherine, esprimono il loro animo ribelle e selvaggio, correndo a cavallo e passando le loro giornate nelle distese di erica; il freddo della brughiera scandisce i ritmi della loro vita a stretto contatto con la natura del luogo.
Sarà poi il personaggio della figlia di Catherine, che si chiama Cathy come la madre, a dare una svolta positiva finale al romanzo. Anche lei è una ragazza capricciosa e testarda come lo era stata sua madre, ma tuttavia molto più equilibrata e solida, provvista della stessa bontà d’animo di suo padre Edgar Linton, e una volta rimasta orfana di quest’ultimo, pur essendo caduta nelle grinfie di Heathcliff che la odia in quanto figlia di Catherine e di Edgar, reagirà sempre rispondendogli in maniera superba e sprezzante, senza alcun timore delle sue vessazioni. Mentre Heathcliff, alla fine dei suoi giorni, sarà sempre più immerso in un suo mondo fantastico in cui è tormentato dal fantasma della sua amata Catherine, la figlia di quest’ultima, Cathy, riuscirà a far innamorare di sé e ad istruire suo cugino Hareton Earnshaw, che Heathcliff aveva consapevolmente fatto crescere in uno stato di ignoranza e degradazione.
Ci sarà alla fine una strana ossessione – redenzione di Heathcliff che non riuscirà più ad essere malvagio e vendicativo come lo era stato durante tutta la sua esistenza.
<<I miei vecchi nemici non mi hanno battuto…sarebbe il momento preciso di vendicarmi sui loro discendenti. Potrei farlo, nessuno potrebbe impedirmelo…Ma a che scopo? Non ho voglia di colpire (….). Nelly uno strano mutamento s’avvicina…>>.
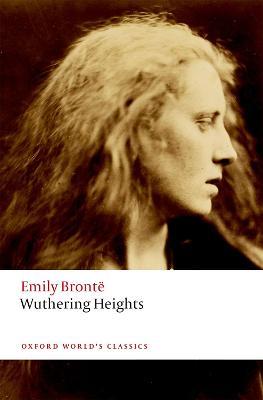
Cime tempestose è un pugno nello stomaco, un romanzo dolcissimo e terribile in cui l’autrice ha il coraggio di sporcarsi le mani e di discendere nei meandri della natura umana, nella sua mostruosità e nella sua bellezza.
L’elemento fondante è la solitudine dei protagonisti ed essa non è per loro una conquista ma un modo per immergersi nelle proprie ombre, ferite e inquietudini personali. C’è da parte della Brontë una vera e propria introspezione nell’animo umano.
Hethcliff e anche gli altri personaggi e i fantasmi che abitano questa storia indimenticabile, sembrano inoltre nascere da una visione onirica dell’autrice e da un suo personale rapporto di odio amore con il paesaggio naturale incontaminato e libero della brughiera inglese, inquieta e selvaggia ma al tempo stesso salvifica, che sembra divenire un tutt’uno con l’animo di coloro che ci vivono a stretto contatto.
Cristiana Buccarelli

Cristiana Buccarelli Cristiana Buccarelli è dottore di ricerca in Storia del diritto romano. Ha vinto nel 2012 la XXXVIII edizione del Premio internazionale di Poesia e letteratura ‘Nuove lettere’ presso l’Istituto italiano di cultura di Napoli. Ha pubblicato la raccolta di racconti Gli spazi invisibili (La Quercia editore) nel 2015, il romanzo Il punto Zenit (La Quercia editore) nel 2017 ed Eco del Mediterraneo (IOD Edizioni) nel 2019. Con Eco del Mediterraneo (IOD Edizioni) ha vinto per la narrativa la V edizione del Premio Melissa Cultura 2020 e la IV edizione Premio Internazionale Castrovillari Città Cultura 2020. Nel 2021 ha pubblicato il romanzo storico I falò nel bosco (IOD Edizioni) con cui ha vinto per la narrativa la XVI edizione del Premio Nazionale e Internazionale Club della poesia 2024 della città di Cosenza. Nel 2023 ha pubblicato il romanzo Un tempo di mezzo secolo (IOD Edizioni) con il quale è stata finalista per la narrativa all’XI edizione del Premio L’IGUANA- Anna Maria Ortese 2024. Conduce da svariati anni laboratori e stage di scrittura narrativa.