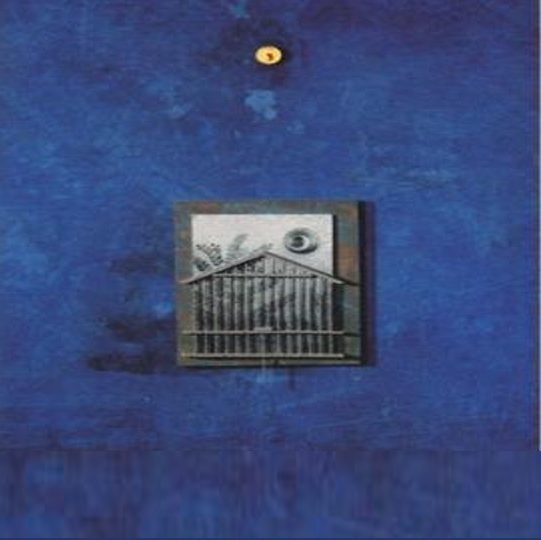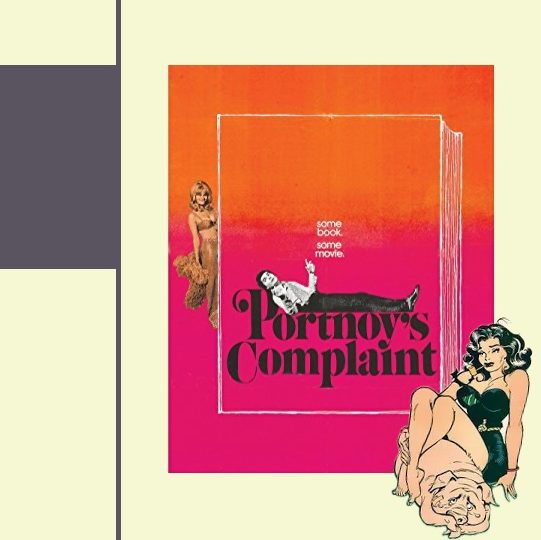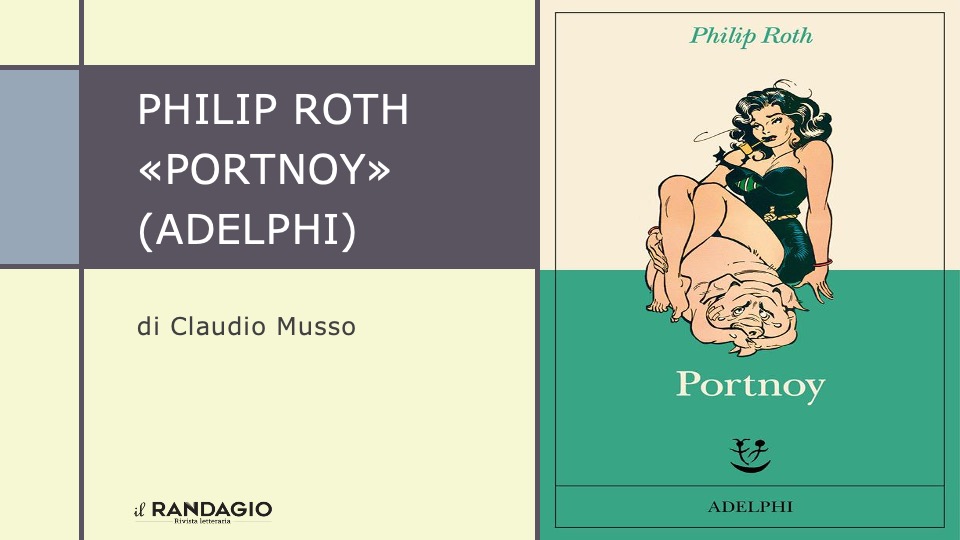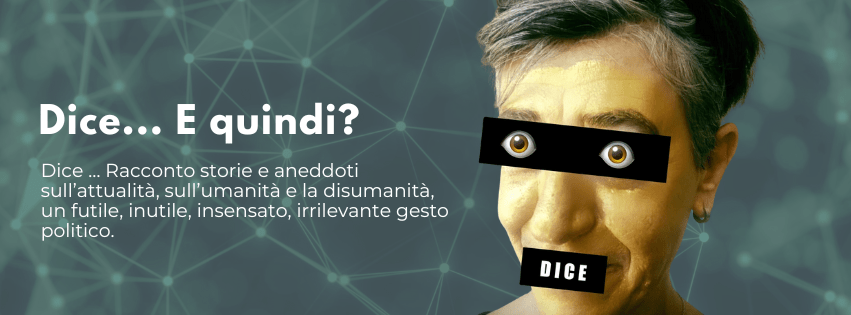Devo ammettere che, sino a poco tempo fa, non conoscevo Nina Cassian e il suo nome così “italiano”, un po’ veneto, mi ha simpaticamente attirato. Si tratta di uno pseudonimo; il suo nome completo è Renée Annie Cassian Mătăsaru. Me ne inviò una poesia un amico e così nacque la voglia di conoscerla meglio. Spesso bisogna ringraziare i nostri amici dell’anima per doni così preziosi.
Le informazioni che si trovano su di lei non sono ricchissime, alcuni dati sulla sua vita in Romania, che dura fino all’età di 41 anni e poi l’esilio negli Stati Uniti, dove muore a 89 anni.
Anche le traduzioni in italiano non sono molte e l’unico volume che ce la offre in un’edizione e in una traduzione linguisticamente attuale, di Anita Natascia Bernacchia, è quello uscito nel 2013 per Adelphi, a cura di Ottavio Fatica e dal titolo “C’è modo e modo di sparire 1945 – 2007”.
Il volume di Adelphi consente di gettare un ampio sguardo sulla produzione di Nina Cassian, sulle sue poesie fisiche, d’amore, di solitudine, sarcastiche, amare e poco convenzionali.

Nina Cassian nasce in Romania, a Galati, sul Danubio, nel 1924, da una famiglia ebrea, trascorre l’infanzia a Brașov in Transilvania, per poi trasferirsi a Bucarest a metà degli anni ’30. Cresce come artista poliedrica: recita, suona il pianoforte, dipinge e illustra libri per l’infanzia, traduce (Brecht, Celan, Morgenstern, Ritsos).
Due fra i poeti rumeni più in vista, Tudor Arghezi e Ion Barbu, la incoraggiarono a pubblicare, così escono i suoi versi per la prima volta nel 1945 sul giornale “Romania Libera” e, due anni dopo ancora nel volume “La scara 1/1”, criticato però dal regime comunista come “decadente”.
Il governo filo-sovietico si afferma in Romania all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, e si consolida maggiormente in seguito e dal 1965 con l’era Ceausescu assume tratti sempre più repressivi.
Nina cerca quindi per opportunità, non per opportunismo, di cui non è capace, di adeguarsi per un po’ alla linea retorica ed encomiastica vigente, ma la sua personalità dominante e orgogliosa non viene ben sopportata dai “compagni”.
Dopo diversi tentativi di produzione di “poesie proletarie”, assolutamente lontane dal suo personale, irriverente modo di poetare, si rivolge, a partire dagli anni ’50, alla letteratura per l’infanzia, settore in cui trova la sua voce più autentica.
Nel 1985 riceve un invito in qualità di visiting-professor negli Stati Uniti, qui le giunge però la notizia dell’arresto e successiva uccisione dell’amico e dissidente Gheorghe Ursu. Questo evento determina la svolta della sua vita personale e letteraria, Nina decide di chiedere asilo politico e non rientrare più in Romania. La reazione del governo Ceausescu non si fa attendere, la sua casa viene messa sotto sequestro, i suoi libri rimossi da biblioteche e librerie, messi all’indice.
Ha così inizio, non senza trauma, la vita americana di Nina Cassian. La recisione è una ferita che emergerà da diversi suoi passaggi poetici e dalla continua ricerca di nuove appartenenze, come capitato a molte e molti autrici e autori esuli.
Nina Cassian saluta con stupore il fatto che le sue parole possano in un altro luogo e in un’altra lingua produrre un effetto: parole nuove anche per lei, parole che scaturiscono da una sostanza di sé, sia fisica che spirituale, diversa da quelle nella sua lingua d’origine.

Hannah Arendt, che, per motivi non lontani da quelli di Nina Cassian, si ritrova, oltre quarant’anni prima, suo malgrado anche lei cittadina americana, fa proprio del discorso sulla lingua “madre” un nodo del suo pensiero filosofico.
Il linguaggio ha infatti un ruolo decisivo per potere appartenere o non appartenere al mondo, non si tratta di mera “esecuzione linguistica”, ma indica la facoltà inalienabile del “prendere parola”, dell’”avere voce” nel senso civile e politico.
Entrambe esuli sono costrette ad abitare l’inglese e trovare nella nuova lingua una seconda madre-patria, una genitorialità, una casa del cuore, del pensiero, del “verbo”.
Distaccandosi entrambe fisicamente dal proprio Paese, operano, non senza sofferenza, anche una “dislocazione” del pensiero che deve ricollocarsi trovando parole nuove.
In “Ermetica” la Cassian fornisce un’immagine macabra del pensiero-grido, che abbisogna di un altro luogo in cui venire “conficcato”; l’associazione ad un verbo preciso, fisico indica qui un’urgenza espressiva libera e istintiva che fa uso di parole-lancia acuminate per potere andare a segno. Quando però la libertà viene inibita e l’urgenza espressiva non trova sfogo, anche la consistenza della lingua, neutralizzata, cambia, fuoriesce “pendula” e afasica.
Se ci fosse un luogo dove conficcare un altro grido
quale potrebbe essere, la roccia o il mare
o l’occhio dell’uccello della notte, fisso e tondo,
duro come la pietra,
giallo come la luna?
Ah, tutto è impenetrabile.
E il grido viene fuori dalla bocca
pendulo come lingua d’impiccato.
Il rapporto di Nina Cassian con la parola, non si può dire certo statico; è traduttrice, abituata quindi a traghettare concetti, ad esplorare mondi fonetici e lessicali, inventa lingue come la spargă e la leopardă, caratterizzate da sonorità onomatopeiche, giocose e sovversive, ma trovare una nuova identità linguistica nell’inglese la mette in crisi, la fa sentire inadeguata, le pone un problema identitario e di riposizionamento.
Emblematici a questo proposito i versi:
Pur se verrò sepolta
in una terra aliena:
risorgerò un giorno
nella lingua romena.
Quasi a significare che, pur avendo ceduto al compromesso di appartenere al mondo attraverso l’inglese, questo ha comportato una sua morte spirituale, in confronto alla quale, la morte del corpo e l’accettazione di venire sepolta in terra straniera, sono comunque sopportabili.
Il tema del tormento legato all’esilio (fisico o metafisico, forzato o cercato) – pensiamo ad Ugo Foscolo, come ad uno dei primi esempi letterari più conosciuti – è qualcosa che non esita solo in poeti, artisti e intellettuali in dolorose reazioni.
Anche l’emigrazione produce, infatti, nelle persone, pur con velocità e processi diversi, sentimenti simili: la necessità di ridefinire il concetto di identità, la ricerca di nuove appartenenze, la nostalgia, l’afasia prodotta dalla mancata conoscenza della lingua e quindi la frammentazione dei diversi domini della propria vita (sfera privata, professionale, scolastica, civile), la decostruzione di concetti familiari a favore di una riattribuzione di significati, la necessità di sentirsi rappresentati ed esercitare in maniera attiva la cittadinanza.
Barbara Gramegna*

Barbara Gramegna, sono nata e cresciuta a Bolzano, a cavallo fra due culture e due lingue. I miei ambiti di studio, professione e interesse hanno come cifra comune le parole: lette, scritte, dette, ascoltate, cantate.