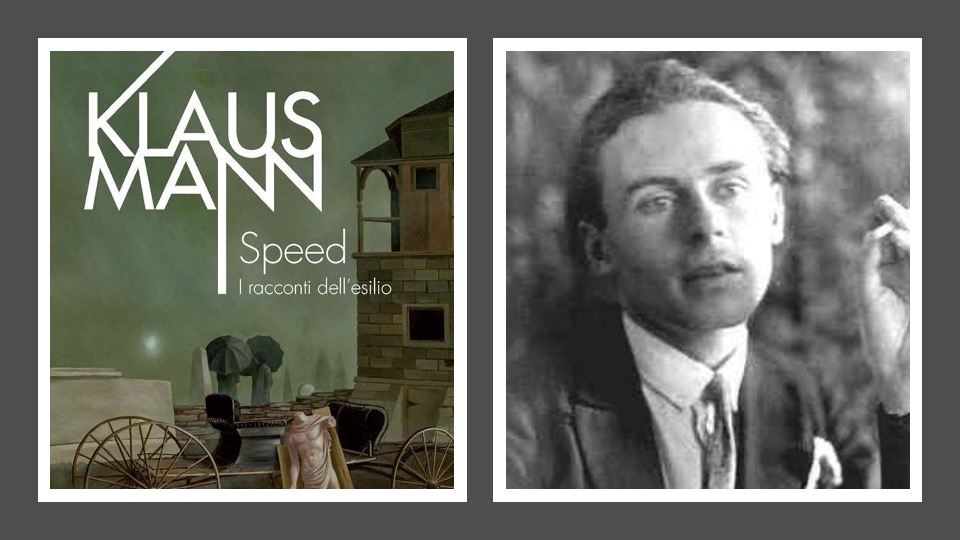Scavare in un libro come in un graffito…
E’ una bellissima storia d’amore ed anche tanto di più. E’ una storia tra due senza nome e c’è un battello sulla Morava che scorre in una terra, la Serbia, che apparteneva all’Austria-Ungheria, una terra che non conosceva l’odio tra gli stati, dove i confini, bandiere ed inni non erano necessari perché avere confini, bandiera e inni sarebbe stato legittimare e perpetrare l’odio. E Samarkanda e Numanzia, due simboli per abbracciare tutta l’Europa, vivevano la prima come grandezza e gloria, come presagio repentino, come presagio duraturo, come altro presente; la seconda, Numanzia, stava lì per ricordare che bisognava resistere e opporsi ad ogni costo alla distruzione di quel mondo.

Lui, notoriamente un misogino, si ritrova accanto una donna, una donna che aveva odiato, eppure già si fa cenno ad una strana sintonia tra i due. Perché nonostante i suoi fallimenti continuava a credere all’amore tra uomo e donna, certo credeva di più all’esaltazione reciproca che all’amore, o quanto meno evitava la parola. E intanto si sentiva in conflitto con sé e dall’altro il suo stato era paragonabile a quello di una malattia che da tempo non si presentava, bastava che a qualcuno tornasse in mente anche solo come nome ed era segno sicuro che la malattia stava per incombere e con essa un periodo infausto.
Ma che storia era stata con questa donna. Procrastinata a sufficienza! E fu lei a cominciare con la storia di loro due, poi riprese lui il filo del racconto e lei continuò a togliergli la parola di bocca, non tanto per correggerlo quanto per avere parte in ciò che era avvenuto per ripeterlo e recuperarlo per se stessa. Non ne venne fuori un dialogo, non si parlò mai di un io e di un tu, si trattò di un lui e di un lei, eccezionalmente un sì impersonale e sovrapersonale.
Gli ospiti sul battello si chiedevano cosa fosse accaduto, ma i due non fecero allusioni di nessun genere. L’unica cosa che rivelarono è che nella notte erano caduti a terra insieme, per stanchezza per sfinimento. Ma qualcosa era accaduto tra loro nel bosco di eucalipti . Là iniziò un’altra misura del tempo e l’altra misura del tempo iniziò quando ebbero l’uno occhi per l’altra contemporaneamente.
Tutto viene raccontato e il tempo del raccontare diventa un enigma fecondo. E’ uno smarrirsi ed un ritrovarsi, è un sentirsi vicini ad un agire. Quella notte sulla Morava si sentiva catturato, si trattava davvero di salvezza? Dalla sconosciuta emanava qualcosa di sofferente, di terribilmente rinunciatario ed ancora uno spavento dolce, trafiggente ossa e midollo.
Ma i due erano davvero una coppia? Durante il loro stare insieme erano successe cose straordinarie, caddero gocce di pioggia su di loro e solo sul loro tavolo. L’impazienza prima del loro incontro fruttò pazienza come non mai… nel loro primo tempo in cui avvenne anche il congedo, però senza che la misura di tempo cessasse di essere in vigore il congedo ne faceva parte. Separarsi per un periodo intermedio, in direzioni opposte, era una cosa ovvia. Nel frattempo nessuno dei due avrebbe dato notizia di sé. E una mattina fu chiaro che quello doveva essere il giorno della separazione provvisoria.
Perdersi di vista, non sapere niente l’uno dell’altro faceva parte delle regole del gioco. Non ci saremmo mai sognati allora… eppure tra i due sarebbe scoppiata una vera e propria guerra di coppia. Lei si era guardata con gli occhi intorno cercando di guardarlo e lui pensò che una purezza così lui non la meritava. E poi succedeva che quanto lui percepiva si trasformasse in un silenzioso monologo, era qualcosa che si rivolgeva alla lontana persona di riferimento, alla sconosciuta, lui le riferiva da lontano e mandava notizia di sé.

Era solo fantasia del narratore? E’ accaduto davvero, così lui informò il nostro interrogatore. Fantasia? E anche se fosse. E perché solo? Se si era trattato di un sogno la sensazione che l’aveva pervaso era però così forte e persistente come nello stato di veglia accade molto di rado. Ormai provava soltanto in sogno la gioia grande e duratura, la riconoscenza, l’affetto la voglia di vivere. Aveva l’impressione di non essere stato visto da nessuna creatura vivente per tantissimo tempo. Non c’erano più ricordi di uno sguardo umano che gli avrebbe solo lanciato anche solo una fuggevole occhiata e cominciava a sentire la mancanza di questo accorgersi di lui. Nel suo viaggio circolare anche questo suo desiderio alla fine si realizzò.
Dammi un volto umano, e la mia anima sarà risanata. Si aprì un varco fino alla coda del lunghissimo treno da dove si era incamminato nell’esigenza di un volto. In fondo al treno la ragazza, seduta per terra, leggeva con la schiena appoggiata al vetro. Quello che la differenziava era come stava seduta e come leggeva. Viveva sensibilmente insieme al libro, ne ripeteva le parole compitando, lo interrogava e si interrogava e con esso era una cosa sola. La giovane si dimostrava distaccata dall’ambiente intorno a lei… un diverso elemento? No, un elemento conforme a lei, unicamente a lei e nel quale soltanto diventava se stessa. E nel contempo non era per così dire assorta, distacco non significava per forza pensosità o isolamento.
Intanto nel corridoio e fuori coglieva ciò che valeva la pena di cogliere… E lui non finiva di saziarsi nel vedere come la ragazza, ancora quasi una bambina?, no, non più una bambina, leggeva e leggeva e leggeva. Serietà concentrata sfavillava dalla fronte… Come, una serietà che sfavillava? … e più si immergeva in quella lettrice più gli sembrava che si librasse sopra il pavimento, senza peso, e lui con lei. Sorrideva spesso potremmo dire sotto i baffi, oppure, dopo ogni capoverso scuoteva la testa: cosa che rivelava il suo stupore, un essere stata colta di sorpresa…
Un lettore così, una lettrice così lui se l’era immaginato da tempo immemorabile anche per i suoi libri. Materna appariva quella lettrice, che pure era ancora una mezza bambina, e lo sarebbe rimasta per tutta la vita. Poi lei alzò gli occhi dal libro e invece di guardare sopra la spalla guardò lui… Si mise in disparte per non farsi vedere, al tempo stesso col cuore che gli batteva, come qualcuno colto in fallo? Sì, lei lo aveva riconosciuto. E quanto avvenne lo riferì in quella notte sulla Morava, non lui ma la sconosciuta che raccontò: la ragazza non solo aveva riconosciuto l’uomo. Lei era una sua lettrice. Lei lo osservava stupita. Lo tirò per il cappotto e lo trascinò con sé verso la porta di fondo. Lei non sapeva niente di lui , niente di personale, e neppure voleva sapere da dove venisse né dove fosse diretto. Doveva sempre farle domande perché lei continuasse a parlare e lui percepiva il suo desiderio che lui, lui, gliele rivolgesse.
Il chiedere e al tempo stesso l’evitare di chiedere gli veniva in aiuto nel porre delle domande, cosa che da sempre e, sostanzialmente, gli ripugnava. Così, tra i due davanti alla porta a vetri nacque un gioco animato e visto da fuori sembrava che tutti coloro che fiancheggiavano i binari fossero i loro spettatori. Il fatto che una creatura così si confidasse proprio con lui. Che regalo. Lo meritava? ma l’essere oggetto di un regalo così immeritato divenne per lui un peso eccessivo… e così, in una parte in cui il treno veniva sganciato verso la Stiria, si congedò dalla giovane lettrice, dalla dolcissima tra mille, così gli appariva e scese. Essere solo… con l’immagine postuma della creatura.
La notte era finita. L’autore aprì gli occhi. Giorno fatto. Sole del mattino. Strinse a sé la donna sconosciuta, ma lì non c’era nessuno. Eppure erano abbracciati come una coppia non si era mai abbracciata. Amore? La donna gli aveva fatto sentire che era per lui. Cosa c’era di così strano in questo? Per lui era il miracolo. E adesso di mattina cercò di acchiapparla, era avido del suo corpo, nel vuoto. Insomma, la donna non esisteva? Certo, esisteva, fuori dal sogno, ma non gli apparteneva. Ah, il dolore per la sua assenza. Lui era definitivamente diviso…e non continuo a raccontare quello che è scritto dopo perché è troppo triste.
Ho dovuto scavare e guardare a fondo nelle pagine di questo romanzo come un pittore lavora su una tavolozza di graffito: graffiare sul fondo scuro per recuperare immagini nascoste, ne ho recuperata solo una, ma se ne possono recuperare tante altre.
Maurizia Maiano*

Peter Handke nasce a Griffen nella Carinzia, la regione più meridionale dell’Austria, nel 1942 da padre austriaco e da madre facente parte della minoranza slovena della regione. La madre morirà suicida nel 1971, evento che segnerà profondamente il giovane Handke. Il titolo della sua opera “Wunschloses Unglück, “Infelicità senza desideri”, scritta sull’onda del dolore per il gesto estremo della madre, sembra creare una congiunzione simbolico-semantica tra un destino individuale e quello storico di un paese la cui fine era segnata dall’emergere e dall’ affermarsi dei nazionalismi. La mancanza di desiderio è causa dell’insoddisfazione profonda, espressione di una malinconia dalla quale non si riesce ad uscire, perché deriva da regole interiorizzate che inibiscono il desiderio. Un nuovo mondo, in cui si è incapaci di vivere, quello che si prospetta alla madre di Handke e all’Austria-Ungheria, in cui non ci si riconosce più e in cui è troppo tardi per farne parte e cambiare. La prosa di Handke trova qui il via alla sua grande capacità di interiorizzazione e di analisi profonda del sé. Segna l’inizio di quel romanzo circolare che evoca anche nello spazio letterario quella ciclicità del tempo, della vita e della storia umana riempiendola di flashback e ripetizioni. La letteratura, lo scrivere diventano la sua grande passione. Abbandona gli studi di Giurisprudenza a Graz. Si cimenterà con la scrittura di pezzi teatrali, poi con racconti, romanzi, saggi, poesie e diari ai quali si può aggiungere anche qualche esperienza di sceneggiatore per il cinema.
La letteratura è per lui solo romantica. È polemico nei confronti della generazione di scrittori come Alfred Andersch, Heinrich Böll, Ilse Aichinger e Ingeborg Bachmann che facevano parte del “Gruppo 47” e volevano una letteratura impegnata e realistica. La sua è letteratura votata all’introspezione con una scrittura densa e minimale, altamente descrittiva e ricca di visioni quasi cinematografiche. Collabora con Wim Wenders e, dal suo romanzo “Prima del calcio di rigore”, Die Angst des Tormanns beim Elfmeter del 1970, sarà tratto l’omonimo film e poi lavorerà ancora con Wenders per il più famoso “Il cielo sopra Berlino”. Dall’amore per l’allora Slovenia yugoslava, radicato nel “ventre materno”, nasce l’interesse per la regione balcanica. Handke è un figlio di quell’Austria- Ungheria del “Nachsommer”. L’immagine di quel mondo del passato e l’ideale di una convivenza multietnica e multireligiosa avrà il suo ruolo importante nella sua difesa di Milosevic e della Yugoslavia. “Un viaggio d’inverno ai fiumi Danubio, Sava, Morava e Drina ovvero Giustizia per la Serbia” sono, forse chissà, l’antefatto a “La notte della Morava”?

*Maurizia Maiano: Sono nata nella seconda metà del secolo scorso e appartengo al Sud di questa bellissima Italia, ad una cittadina sul Golfo di Squillace, Catanzaro Lido. Ho frequentato una scuola cattolica e poi il Liceo Classico Galluppi che ha ospitato Luigi Settembrini, che aveva vinto la cattedra di eloquenza, fu poeta e scrittore, liberale e patriota. Ho studiato alla Sapienza di Roma Lingua e letteratura tedesca. Ho soggiornato per due anni in Austria dove abitavo tra Krems sul Danubio e Vienna, grazie a una borsa di studio del Ministero degli Esteri per lo svolgimento della mia tesi di laurea su Hermann Bahr e la fin de siècle a Vienna. Dopo la laurea ritorno in Calabria ed inizio ad insegnare nei licei linguistici, prima quello privato a Vibo Valentia e poi quelli statali. La Scuola è stato il mio luogo ideale, ho realizzato progetti Socrates, Comenius e partecipato ad Erasmus. Ho seguito nel 2023 il corso di Geopolitica della scuola di Limes diretta da Lucio Caracciolo. Leggo e, se mi sento ispirata e il libro mi parla, cerco di raccogliere i miei pensieri e raccontarli.