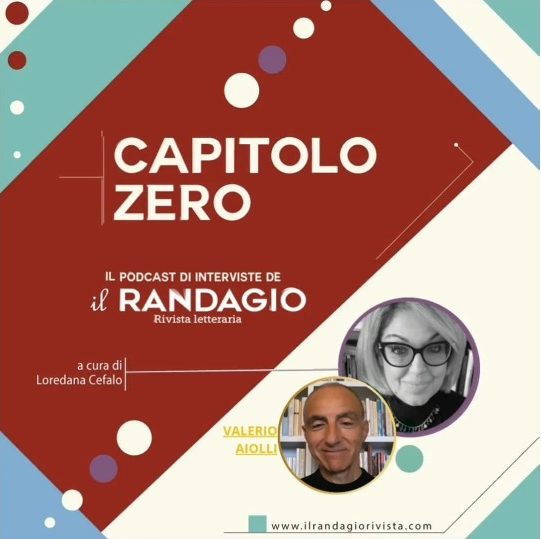“Certi giorni mi sento un albero di mele marce, altri un randagio smarrito che si allena a far finta di niente.”
C’è un calcio che non esiste più da raccontare, un calcio periferico o di provincia giocato su campetti sterrati e polverosi, fatto di sacrifici e passioni autentiche, lontano dai riflettori, dal business e dai troppi soldi. In quegli stadi improvvisati, a bordo campo o dietro una porta senza rete, che ci fosse un sole africano, o il freddo e la pioggia, c’erano i tifosi, custodi di una passione che si tramandava di padre in figlio, che vociavano e urlavano, soffrivano e si dimenavano. C’era la poesia che va scritta di quei ricordi intimi, di un mondo di sentimenti che ancora scorre nelle vene di chi quel calcio perduto l’ha vissuto e masticato.
Con Fubbàll, Remo Rapino compone questo canto popolare, attacca con la colla di farina le figurine sull’album Panini dei calciatori anonimi, dimenticati, sempre perdenti tranne che in rare occasioni epiche, di un’epica da bar di paese che vale la pena celebrare e ascoltare.
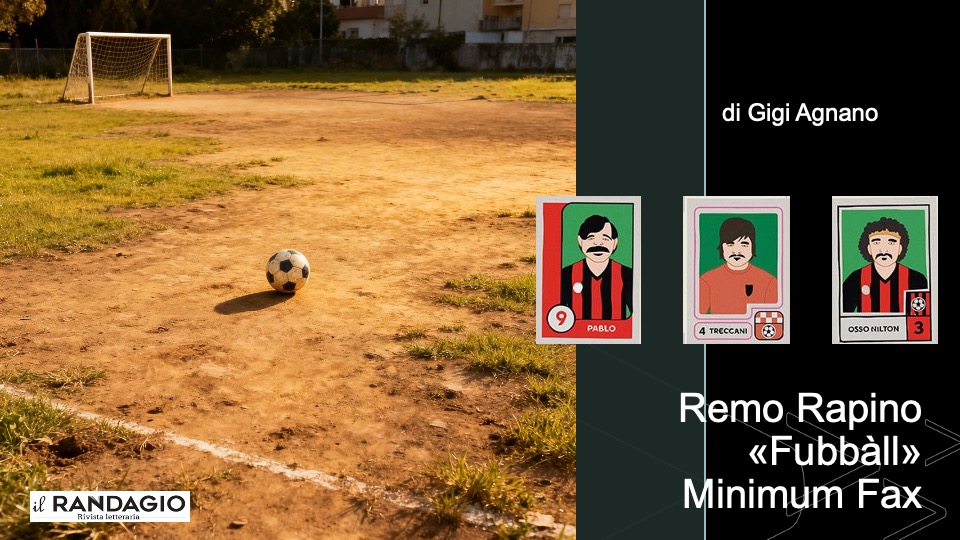
Dodici biografie di uomini semplici – una per ciascun ruolo più quella dell’allenatore – che raccontano un calcio che si misura col sudore, le delusioni, i ricordi, le cicatrici e i rimpianti. Dodici uomini – avrebbe detto Gianni Mura e lo diceva di Pelè – “con niente di speciale”: dal portiere anarchico Milo il gatto con la dote del silenzio, che con quelle mani poteva fare solo il portiere o il carpentiere, al difensore coraggioso e macellaio, “limitato ma di cuore”, che si fa apprezzare non tanto per il talento ma per l’anima che mette in campo; passando per centrocampisti saggi e generosi, poesia e geometria, che fanno l’ uncinetto con i piedi “balzanti e sbirolenti”(Gianni Brera); fino all’attaccante segnato dalla vita e dagli infortuni. Dice il terzino Glauco: “non sempre la vita ti regala poesie, anzi spesso te le toglie”.
I calciatori di Rapino ci portano con la mente alla poesia popolare di Saba, che in “Tre momenti” raccontava il calcio come un atto gioioso di comunione umana (“Festa è nell’aria, festa in ogni via,/ se per poco, che importa? “) e al Pasolini frequentatore assiduo a Bologna dello stadio Comunale e dei prati di Caprara (“i pomeriggi più belli della mia vita”), quello della rubrica “Il caos” per il settimanale Il Tempo dove poneva il suo sguardo critico sul “corpo dell’atleta”, evidenziando contraddizioni sociali e culturali che ancora oggi si rispecchiano nello sport. I personaggi marginali di Rapino hanno l’umanità e l’ironia delle voci di Soriano, quelle dei giocatori “tristi che non hanno vinto mai” di De Gregori, che affrontano la fatica e non si arrendono; richiamano alla memoria il calcio di “splendori e miserie” di Eduardo Galeano, per cui quando c’è la partita “si ferma il respiro del Paese, tacciono i politici, i cantori e i ciarlatani da fiera, gli amanti frenano i loro amori e le mosche interrompono il volo”.
Fubbàll è così la testimonianza che si fa canto corale di un calcio che non c’è più, ma che sopravvive pulito e genuino nei cuori di chi l’ha amato, un atto di memoria che restituisce dignità e valore a vite altrimenti anonime e sogni sui quali “si deve leggere la scritta Fragile”. Il lettore non legge solo storie di calcio, ma di quelle storie riconosce il pregio anche se il calcio non gli interessa affatto, perché Rapino, con uno stile in bilico tra l’ironico e il poetico, tratteggia esistenze polverose, intrise di nostalgia e va al nocciolo di un mondo complesso e passionale, profondamente umano. I suoi personaggi non sono supercampioni tatuati dalla testa ai piedi, ma persone normali che, come tutti noi, si accapigliano con la vita e perdono palla all’ultimo dribbling.
Remo Rapino, abruzzese, è stato docente di storia e filosofia. Dal 1993 ha pubblicato numerose opere di poesia e narrativa. Nel 2019 esce con Minimum Fax il suo romanzo più noto e apprezzato “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”, che si aggiudica l’edizione 2020 del Premio Campiello, risulta finalista del Premio Napoli e candidato allo Strega. Sempre con Minimum Fax ha pubblicato nel 2021 “Cronache dalle terre di Scarciafratta” e nel 2023 la raccolta di racconti Fubbàll, vincitore del Premio per la Letteratura Sportiva Gianni Mura. In questi giorni è in uscita la sua ultima fatica dal titolo “La Scortanza”.
Gigi Agnano

Napoletano, classe ’60, è l’ideatore e uno dei fondatori de “Il Randagio – Rivista letteraria“, nato il 15 ottobre 2023, anniversario della nascita di Italo Calvino.