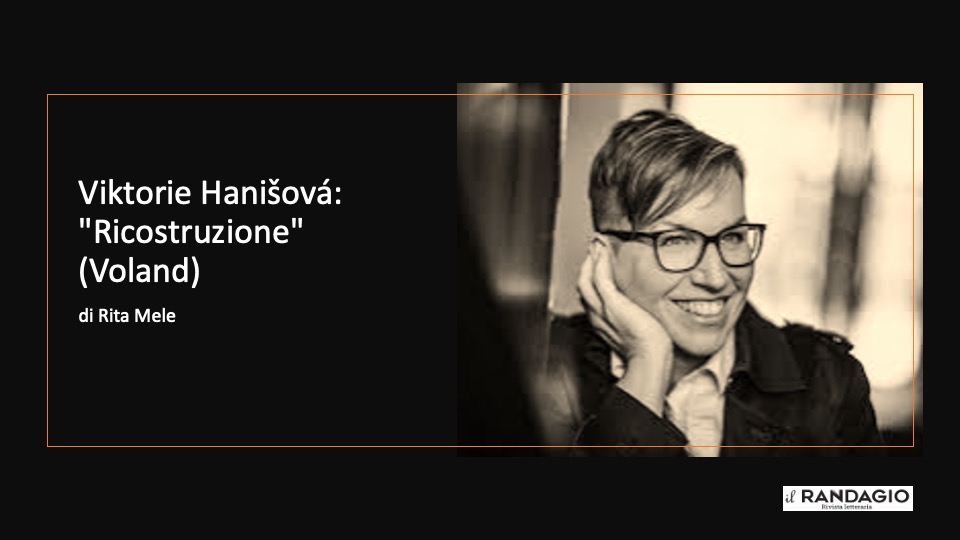Ep.8 Roberta Lepri, “La gentile” (Voland).
In un’epoca dove i diritti delle donne alla libertà di scelta, all’indipendenza e all’autonomia, in primis di pensiero, vengono urlati nelle piazze e nelle istituzioni affinché vengano ascoltati e rispettati, mi sono imbattuta nel romanzo La gentile, ultimo lavoro di Roberta Lepri, già vincitrice dal Premio Chianti 2024 con DNA Chef.
L’opera, che si presenta come un romanzo storico, sottolinea la necessità delle donne che abitavano un tempo non troppo lontano da quello attuale di affermare, attraverso il garbo, la propria identità femminile e lottare per l’autodeterminazione.
Da una raccolta epistolare e una ricerca documentale sulla figura di spicco di Alice Hallgarten Franchetti, l’autrice disegna una parabola universale sulla colpa e sulla redenzione.
Non si tratta di una semplice cronaca storica, ma di una narrazione di scavo che utilizza la parola per illuminare gli angoli bui dell’interiorità delle protagoniste. Roberta Lepri dimostra una scrittura elegante e puntuale, capace di declinarsi in registri differenti per restituire la distanza tra i due mondi rappresentati.
Da un lato abbiamo Alice, figura storica realmente esistita, che vive la filantropia come un disperato tentativo di colmare un vuoto affettivo; il suo registro è alto, riflessivo, intriso di una malinconia colta e corredato da un femminismo sottile appena accennato, ma preponderante. Dall’altro c’è Ester, figlia di contadini, per la quale l’autrice adotta un registro più asciutto, crudo e pragmatico, specchio di una realtà dove la sopravvivenza non ammette fronzoli linguistici.
Il rapporto tra le due donne è una spirale di DNA: vicine ma mai sovrapponibili, unite da un senso di responsabilità che diventa maledizione. Questa complessa dinamica è narrata con un forte distacco analitico: l’autrice osserva e descrive le differenti derive dell’animo umano senza giudizio, lasciando che i fatti risuonino nei comportamenti delle due protagoniste. Se Alice si rifugia nel rimpianto e nell’autoindulgenza della propria solitudine dorata, Ester incarna una cenerentola moderna che non aspetta il principe, ma impara a mettere da parte la gioia “come il grano in estate”, consapevole della sua estrema rarità e cogliendo il buono anche nella sventura con un coraggio senza pari.
Metafora del racconto è l’uroboro, simbolo di un’energia che si consuma e si rigenera, proprio come il legame indissolubile tra la baronessa Alice Hallgarten Franchetti e la giovane Ester, così come la forza di quest’ultima che riesce a rialzarsi con dignità anche in situazioni di estrema avversità.
Nonostante lo sfondo sia ricco di eventi cruciali (dalla Prima guerra mondiale all’ascesa del fascismo, fino alle ferite del secondo dopoguerra) la storia non schiaccia, ma funge da reagente chimico che svela la vera natura dei personaggi e ne caratterizza i dettagli.
“La vita cambia di colpo e tu credi che non riuscirai a sopportarlo. Invece ti abitui e vai avanti. Poi, dopo un po’, quello che all’inizio pareva assurdo diventa normale. Continuare senza impazzire ha comunque un prezzo.” Questa citazione riassume la filosofia dell’opera: l’adattamento come forma di sopravvivenza, ma anche come mutilazione dell’anima.
Centrale è il tema della famiglia, come in altre opere dell’autrice, intesa non come luogo di accudimento ma come fonte di ferita e tradimento. Il romanzo ci ricorda che la cicatrice inflitta da chi dovrebbe amarti è l’unica da cui non si può fuggire, nemmeno attraverso la filantropia o la ricchezza.
La riflessione disincantata del finale è tanto sconcertante quanto vera: la vita è assurda e necessitiamo tutti della qualità dell’arrendevolezza di fronte agli eventi, una “gentilezza consapevole”, ascetica, filosofica, quasi buddista, che permette di cogliere piccole sfumature di colore in un’esistenza segnata dal buio di sofferenze e sogni infranti.
La gentile è un romanzo che racconta la vita vera e che interroga il lettore sul costo della benevolenza e sulla crudeltà dell’esistenza. Roberta Lepri ci consegna una storia dove non ci sono vincitori, ma solo esseri umani che cercano di non soccombere sotto il peso del proprio destino.
È un passaggio perfetto per chiunque voglia capire come il passato continui a vibrare nel presente, proprio come un filo intrecciato in un telaio antico.
Loredana Cefalo*

* Mi chiamo Loredana Cefalo, classe 1975, vivo a Cagliari, ma sono Irpina di origine e per metà ho il sangue della Costiera Amalfitana. Adoro le colline, il profumo della pioggia, l’odore di castagne e camino, che mi porto dentro come parte del mio DNA.
Ho una grande curiosità per la tecnologia, infatti da cinque anni tengo una rubrica di chiacchiere a tema vario su Instagram, in cui intervisto persone che hanno voglia di raccontare la loro storia.
Sono stata una professionista della comunicazione, dell’organizzazione di eventi e della produzione televisiva, settori in cui ho un solido background. Mi sono laureata in Giurisprudenza e ho un Master in Pubbliche Relazioni.
Ho accumulato una lunga esperienza lavorando per aziende come Radio Capital, FOX International Channels, ANSA e Gruppo IP, ricoprendo ruoli significativi nel settore della comunicazione e dei media, fino a quando non ho scelto di fare la madre a tempo pieno dei miei tre figli Edoardo, Elisabetta e Margaret.
In un passato recente ho anche giocato a fare la foodblogger e content creator, con un blog personale dedicato alla cucina, una delle mie grandi passioni, insieme all’arte pittorica e la musica rock.
L’amore per la scrittura, nato in adolescenza, mi ha portata a scrivere il mio primo romanzo, “Il mio spicchio di cielo” pubblicato il 16 gennaio 2025 da Bookabook Editore e distribuito da Messaggerie Libri. Il romanzo è frutto di un momento di trasformazione e di crescita. La storia è presa da una esperienza reale vissuta indirettamente e ricollocata nel passato per fini narrativi e per gusto personale. Ho abitato in molti luoghi e visitato con passione l’Europa e le ambientazioni del romanzo sono frutto dell’amore che provo nei confronti delle città in cui è collocato.