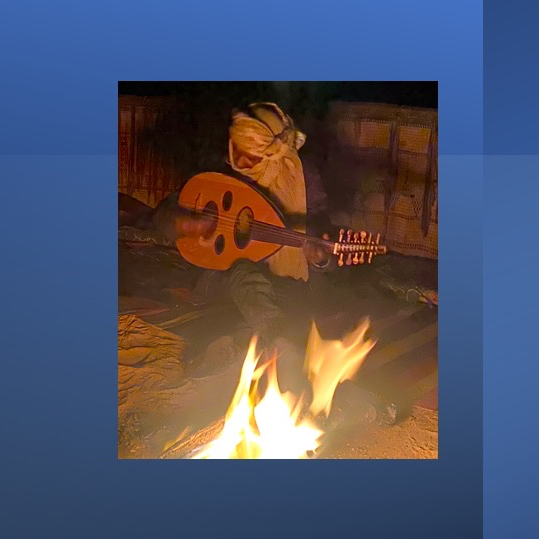In una meravigliosa villa nelle Isole Hawaii di proprietà di un batterista di fama internazionale, in un agosto “ustionato” dove ogni giorno è un capitolo come nel diario di un’adolescente, si svolge “Setole”, il secondo romanzo di Hilary Tiscione, edito da Polidoro nella collana Interzona diretta da Orazio Labbate.
Un romanzo duro, claustrofobico, doloroso, con una forza sconvolgente fin dalle prime pagine; un libro che parla del vuoto, dell’assenza e dell’attesa. Che esplora le vite di personaggi afflitti e disastrati che si muovono tutti – a parte che in un paio di sporadiche e più o meno brevi feste in spiaggia – tra le stanze, la piscina, il giardino, il bar, il viale e la dependance della lussuosa casa in collina da cui si vede in lontananza l’Oceano.

Potrebbe essere un luogo incantevole, foriero di serenità e rilassatezza, un presagio di bella vita, ma tutt’intorno alla villa anche la natura è sofferente – in questo l’autrice è quasi ossessivamente “leopardiana” -, come a rispecchiare il disagio esistenziale dei suoi abitanti: si sentono gli animali “litigare”, i gatti azzuffarsi, i cani “hanno pochi denti e disfano il cibo premendo la lingua contro il palato”, gli insetti e le rane vanno a morire in piscina, i pipistrelli in cerca del buio sono “come schizzati mossi da qualche rabbia”, le falene “volteggiano cadendo sull’erba come foglie sconvolte in fin di vita”.
Protagonista e voce narrante per gran parte del romanzo è la diciassettenne Lena alle prese con le tortuosità dell’adolescenza, una via di mezzo tra Lolita e la Liv Tyler di “Io ballo da sola”. Dice:
“Sento nello stomaco una specie di ventosa che crea una depressione sotto l’esofago, ho fame, ma non c’è nulla che mangerei. Penso di tirarmi su dal letto e resto ferma come un avanzo di torta indurito. L’aria calda mi prende la fronte come avessi l’influenza. Mi ficca nella mente una sensazione di minaccia.”
Mira, la madre di Lena, ex modella quarantacinquenne, sta generalmente nella sua stanza. Dorme o si crogiola nella sua depressione, nella “galleria del dispiacere”. Di tanto in tanto si affaccia alla finestra “regalando miseria all’aria” e, nelle rare volte in cui compare, crea imbarazzo alla ragazza, fino a determinare l’episodio centrale della trama che preferiamo sia il lettore a scoprire. Basti dire che alla voglia di vita e al desiderio di “normalità” dell’adolescente fa da contraltare il disordine morale della madre che come un dispenser naturale di disagio farà irruzione nella storia e nella vita della figlia con la sua melodrammatica inquietudine.
Va detto che entrambe le donne stanno vivendo con sofferenza, rimorsi e sensi di colpa l’abbandono, più precisamente la scomparsa di Al, padre e marito, una presenza invisibile che tutti aspettano consapevoli dell’inutilità dell’attesa.
È una crisi di gelosia di Mira contro l’invisibile marito che dà il titolo al libro ed è lo snodo delle vicende più drammatiche del racconto: le setole dello spazzolino di Al le generano una tale rabbia mista a disgusto da farle scagliare il contenitore d’argento contro lo specchio del bagno che va in frantumi ferendola.
Un altro personaggio chiave del romanzo è Cino dallo “sguardo velato”, il factotum della villa, di una saggezza che viene dal suo vissuto tanto misterioso quanto doloroso. Tutti lo trattano con deferenza perché è il solo “in famiglia” ad avere un comportamento comprensivo e affettuoso, l’unico che tenta di favorire un contesto amorevole. L’unico forse ad avere una qualche autorevolezza.
“Da quando lo conosco porta il pizzo, anni fa era corvino, adesso è rigato da una specie di madreperla che gli calza con euforia quella sua faccia scaltra. I capelli che si dividono nel centro gli fanno due onde sommesse ai lati delle tempie. Seguono l’arco cedevole del volto che guarda distante in luoghi appartati. Ha le labbra sedute in un’espressione che ha dimestichezza con la vita. Sembrano beffarsi di noi tutti con perenne educazione.”
Infine, come in ogni villa lussuosa un po’ fabbrica di San Pietro, c’è un cantiere e degli operai. E tra gli operai c’è il giovane ed avvenente Rocco, che presto diventerà il fidanzato di Lena, quello col quale consumerà la sua prima volta nel ventre cavo di un grande albero.

La Tiscione fa indiscutibilmente un ottimo lavoro stilistico nell’enfatizzare la sofferenza personale dei protagonisti, nel mettere su carta le loro vite interiori, le fragilità e le solitudini, anche se si tratta, d’altronde come succede nella realtà, di rebus irrisolvibili; nel disegnare le atmosfere di tensione e di attesa di una sciagura imminente, di una “calamità alle porte”; nel descrivere, grazie a una lingua e a un ritmo molto interessanti, rumori e odori, restituendo al lettore un’esperienza sensoriale a volte anche disturbante, in un romanzo cui è difficile non attribuire, anche per la qualità dei dialoghi, una grande forza cinematografica. Nella quarta di copertina si parla correttamente de “Il giardino delle vergini suicide” di Sofia Coppola (tratto dal romanzo di Jeffrey Eugenides), ma a me ha fatto anche pensare – quasi fosse una naturale conseguenza della lettura – alla famosa scena finale di Zabriskie Point in cui Daria immagina che la villa esploda a ralenti con tutte le sue suppellettili nella luce del tramonto.
Gigi Agnano