‘’Un amore qualunque e necessario” di Mary Beth Keane, pubblicato in Italia da Mondadori nel giugno del 2020, è un romanzo di particolare forza narrativa ed emotiva, il quale mi è stranamente sfuggito in pieno Covid, in quelle lunghe giornate in cui dedicavo molte ore del giorno alla scoperta e alla lettura di romanzi memorabili. Prima ancora di essere un romanzo di formazione e una saga familiare è, a mio avviso, uno strumento di indagine letteraria dell’autrice sui temi esistenziali del bene e del male, che possono rappresentarsi come faccende molto complesse in cui gli esseri umani e anche molto spesso i nuclei familiari sono invischiati in maniera particolarmente intricata.

Il tema della famiglia subito emerge in una rappresentazione corale: infatti la narrazione riguarda nello specifico due famiglie che vivono accanto e che sono l’una l’antitesi dell’altra; i Gleeson, con Francis il padre, Lena la madre e le tre figlie sembrano solidi e felici, mentre gli Stanhope sono tormentati dall’instabilità mentale di Anne, madre di Peter e moglie di Brian, quando ad un certo punto la serenità degli uni e l’infelicità degli altri si mescoleranno, e tutti resteranno invischiati in un rapporto di interdipendenza tra le cose che accadono, in cui gli elementi del bene e del male si intrecciano. M. B. Keane demolisce volutamente dall’interno l’idea di una felicità edulcorata della famiglia con la propria vita tranquilla ed ha il coraggio di raccontarci che le famiglie a volte possono anche essere degli inferni o delle mine vaganti.
‘’il silenzio della casa, quando sua madre si ritirava nella sua stanza non era il quieto silenzio di una biblioteca o di un qualsiasi luogo altrettanto tranquillo. Secondo Peter era più simile al breve intervallo da fiato sospeso tra il momento in cui si preme un bottone e quello in cui la bomba esplode o si disinnesca. Riusciva sempre a sentire il battito del suo cuore in quei momenti. Riusciva a tracciare il sinuoso percorso del sangue nelle sue vene.’’
In particolare la Keane, attraverso il personaggio di Anne, la madre di Peter, affronta il tema della malattia mentale e delle sue radici più profonde. Anne è stata segnata da giovanissima da un abuso sessuale da parte di un amico di famiglia, per questo motivo fugge dall’Irlanda e opera una rimozione di ciò che le è accaduto, parte per l’America dove riesce a lavorare come infermiera, poi incontra Brian e decide di farsi una famiglia; in realtà è una giovane donna fragile e instabile, e quando perderà un figlio prima di darlo alla luce, in lei si romperà un equilibrio e ciò la porterà a un’escalation di comportamenti irrazionali, fino a un estremo atto di violenza nei confronti del poliziotto Francis Gleeson, suo vicino di casa e padre di Kate. Ma Anne è un personaggio a cui l’autrice credo sia particolarmente affezionata, e le farà compiere, attraverso il romanzo, un lungo e interessante percorso di evoluzione personale. Infatti grazie all’intervento di uno psichiatra molto capace, Anne riuscirà a capire le cause dei suoi disturbi mentali e a riacquistare lucidità, tenterà in qualche maniera di essere perdonata delle persone a cui ha fatto del male e a riconquistare l’affetto del figlio Peter, con il quale in realtà non hanno mai smesso di volersi bene, dunque avrà un nuovo modo di porsi verso il mondo e la sua stessa famiglia.
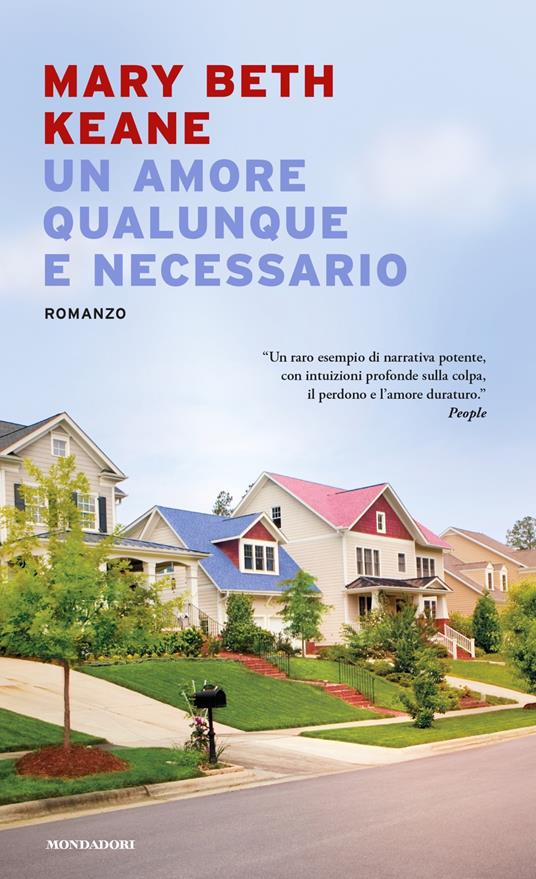
A tutta questa narrazione fa da perno all’interno del romanzo un amore puro, solido, profondo, quasi necessario nel compensare il dolore che nasce da un evento terribile; questo amore comincia a farsi sentire già dalla prima adolescenza tra i due personaggi protagonisti di tutta la storia: Peter e Kate, cresciuti insieme porta a porta. E se l’amore da solo non può guarire certi traumi e certe ferite, fra loro ci sarà un tale sentimento di cura reciproca, di compassione di accoglienza, che diventerà una forma di salvezza.
‘’E poi c’erano le cose che la sorprendevano per l’emozione che provava al solo vederle: lo yogurt di Peter vicino al suo succo d’arancia nel minifrigo; i boxer sul pavimento vicino al suo reggiseno. Una volta fece per infilarsi i jeans di Peter pensando che fossero i suoi, e quando si accorse dell’errore, si domandò se fosse mai stata tanto felice in vita sua’’
Ma anche quei personaggi che non si amano, anzi che sono stati in qualche maniera nemici e si sono distrutti la vita, ad un tratto nella storia per caso si incrociano dopo moltissimo tempo e riescono a darsi qualcosa, trovano un punto di incontro, un sentire comune e in tal senso l’autrice compie una considerevole esplorazione dell’animo umano. Ci sarà infatti un momento in cui Anne e Francis si ritroveranno a parlare della loro infanzia in Irlanda.
‘’Dapprima rimasero seduti un po’ rigidamente, Francis sulla poltrona, Anne a un’estremità del divano, ma poi si rilassarono lasciandosi andare ai ricordi. Entrambi si erano travestiti da wren-boys, i cacciatori di scriccioli dell’antica tradizione irlandese. Entrambi avevano l’abitudine di andare e tornare dalla chiesa in calesse. Entrambi ricordavano che i cibi avevano un sapore diverso laggiù, specialmente il burro, il latte, le uova. Entrambi provavano una punta di malinconia pensando all’Irlanda, o forse il rimpianto per la loro infanzia…(…..) Francis riconosceva in Anne il suo stesso dolore senza nome…’’
La Keane compie un’indagine psicologica approfondita soprattutto in alcuni dei suoi personaggi, mentre altri li fa restare volutamente sullo sfondo. A parte Anne con la sua mente particolare, anche Francis dopo l’incidente gravissimo che ha subito cambierà e cercherà di reiventarsi una vita che gli permetta di unire il suo passato con il presente. Ma l’autrice ci farà conoscere approfonditamente anche Kate con la sua personalità forte e solida sin dall’adolescenza, con la sua determinazione nel ritrovare Peter da adulta e costruire con lui una vita nonostante le difficoltà. Allo stesso modo e forse ancora di più ci fa conoscere il personaggio di Peter e seguire la lunga evoluzione attraverso il tempo; quella di un ragazzo solido e brillante negli studi e nello sport, che riesce a farsi forza da solo fin dall’infanzia, nonostante la situazione familiare difficilissima, e che poi all’improvviso da adulto precipita nell’alcolismo, in quanto dentro di lui sopravvive ancora lo spettro di quel vuoto familiare accumulato in origine, ma che riuscirà a salvarsi attraverso il sostegno e l’amore di Kate. Infine c’è George, fratello minore di Brian che, nonostante la sua vita un po’ scombinata, si offre con generosità di occuparsi di Peter adolescente, quando non ha più altri riferimenti. I personaggi principali sono talmente cesellati nella loro complessità umana, nei loro aspetti caratteriali da dare realmente a chi legge la sensazione di conoscerli fino in fondo, di camminargli affianco; hanno la particolarità di rimanere impressi in tutta la loro umanità. È dunque uno scavo in profondità nell’animo umano quello che compie M.B. Keane e Un amore qualunque e necessario è soprattutto un romanzo sull’espiazione, la redenzione e il perdono, un perdono attraverso il quale si stempera un male originario e si può arrivare a una forma di pace collettiva.
‘’E poi vide quello che non aveva mai visto prima, e cioè che Peter stava bene. E Kate stava bene. Lena stava bene. E lui, Francis Gleeson, stava bene. E capì che tutte le cose che erano accadute nelle loro vite non li avevano feriti in maniera sostanziale, nonostante quello che potevano aver creduto a volte.’’
Cristiana Buccarelli

Cristiana Buccarelli è una scrittrice di Vibo Valentia e vive a Napoli. È dottore di ricerca in Storia del diritto romano. Ha vinto nel 2012 la XXXVIII edizione del Premio internazionale di Poesia e letteratura ‘Nuove lettere’ presso l’Istituto italiano di cultura di Napoli. Ha pubblicato la raccolta di racconti Gli spazi invisibili (La Quercia editore) nel 2015, il romanzo Il punto Zenit (La Quercia editore) nel 2017 ed Eco del Mediterraneo (IOD Edizioni) nel 2019. Con Eco del Mediterraneo (IOD Edizioni) ha vinto per la narrativa edita la V edizione del Premio Melissa Cultura 2020 e la IV edizione Premio Internazionale Castrovillari Città Cultura 2020. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo romanzo storico I falò nel bosco (IOD Edizioni), col quale ha vinto per la narrativa edita la XVI edizione del Concorso letterario Internazionale Città di Cosenza 2024. Nel 2023 ha pubblicato il romanzo Un tempo di mezzo secolo (IOD Edizioni), finalista per la narrativa all’XI edizione del Premio L’IGUANA- Anna Maria Ortese 2024. Nel 2025 ha pubblicato Taccuini di viaggio (Cervino Edizioni 2025). Collabora con la rivista letteraria Il Randagio.












