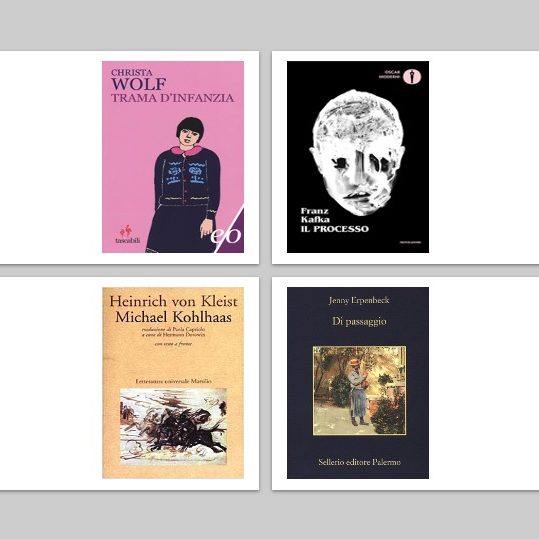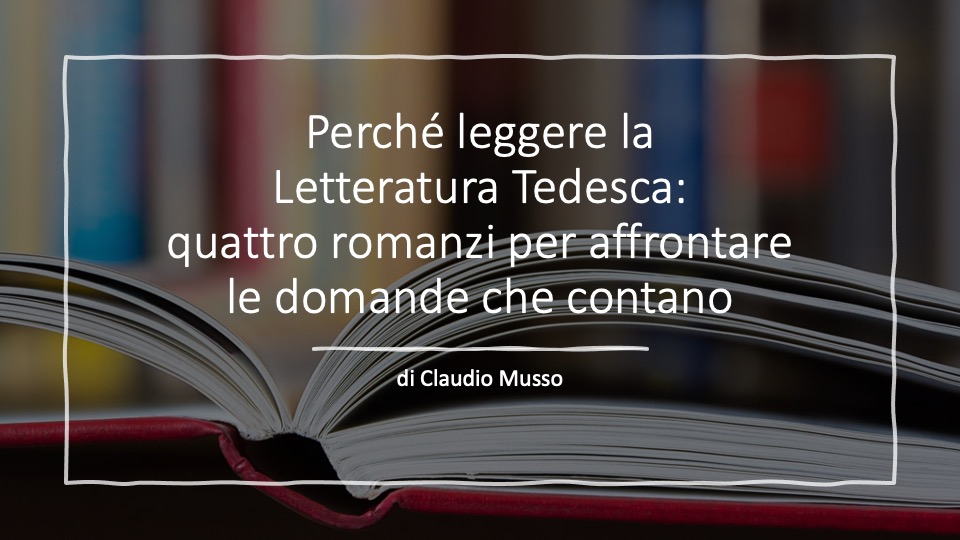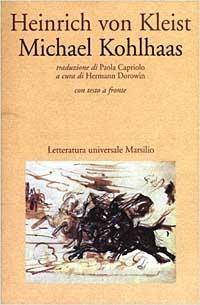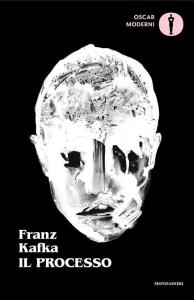Una stanza nel crepuscolo del mondo. Nessuno ascolta o annota. Non è un processo, non è una scena ufficiale. È l’ultimo incontro, forse mai avvenuto, tra due donne che sono state regine, madri mancate o manchevoli, guerriere costrette, pedine e sovrane. E ora, ci sono solo loro. Al centro una tavola lunga e stretta. L’atmosfera è sospesa e irreale. Le luci sembrano venire da candele che non si vedono. Una porta si apre a sinistra ed entra Elisabetta Tudor, regina regnante d’Inghilterra, sola, avvolta in una veste regale semplice ma austera. Dopo qualche istante da destra entra Maria Stuart, la cui nonna paterna era sorella di Enrico VIII, padre di Elisabetta, fatto che le permette di entrare nella linea di successione al trono inglese. La regina di Scozia è vestita in abiti più morbidi ma consunti dal lungo periodo di prigionia. Le due si osservano in silenzio. Si studiano. Poi si parlano.

ELISABETTA
(la voce tagliente, ma con incrinature)
«Siamo qui finalmente. Tu la martire, io la vergine di ferro. Così ci dipingono e lo faranno in seguito ma tali immagini non rendono giustizia a ciò che siamo state davvero. Ora siamo una di fronte all’altra. E tu non in effigie, non in lettere colme di suppliche o sfide. Ma così, in carne e occhi. Con quello sguardo. Ma è tardi – come tutto ciò che conta.»
MARIA
(tranquilla, non umile)
«Avresti potuto vedermi prima. E parlare unendo il mio lessico al tuo. Ma forse questa è l’unica stanza in cui potevamo incontrarci: quando ormai nulla può essere cambiato.»
ELISABETTA
«O tutto può essere detto. Ho scelto di governare con la ragione, tu con il cuore. Di essere più uomo degli uomini e ogni sentimento era un rischio. Ogni lacrima una debolezza che il mondo avrebbe usato contro di me. Perché sono una preda che molti vorrebbero stanare e immolare, io l’eretica. Anche tra il mio stesso popolo. Tra quei cattolici che vorrebbero mettermi in croce. Ma ormai il sangue è versato. Anche se ancora ti scorre nelle vene»
MARIA
(sorride con tristezza)
«Il tuo mi condanna. Ma il tuo stesso sangue, in fondo, mi riconosce. Eravamo nate per incontrarci o per distruggerci? Guarda che macerie abbiamo lasciato intorno a noi»
ELISABETTA
«Entrambe. Perché ci hanno costruite così. Una figlia della fede papista, l’altra di un matrimonio che mezza Europa considera blasfemo. Ci hanno cucito addosso le colpe dei nostri genitori e chiesto di governare mondi spaccati. Se volgo lo sguardo indietro mi chiedo se la Guerra delle Due Rose non è bastata a placare la fame di rivalsa.»
MARIA
«Ma io non volevo il tuo trono, Elisabetta. Solo un rifugio. Una promessa che il sangue reale valesse qualcosa più del sospetto che i tuoi fedeli consiglieri ti hanno instillato in quella corazza che mostri a tutta l’Inghilterra ma di cui io, ora che ti ho di fronte, vedo le crepe. Una regina non dovrebbe implorare di vivere. Ma io l’ho fatto. Tu non hai risposto.»
ELISABETTA
(si siede lentamente, come se ogni gesto fosse un peso)
«Perché mi sei sempre stata più simile di quanto volessi ammettere. La mia paura non era che tu fossi colpevole. Ma che tu fossi… giusta. Una donna come me, ma più audace, più desiderata. Più umana. Te lo dico chiaramente: ho sempre desiderato non essere me»
MARIA
«Io non sono migliore. Sono solo diversa. Non ho saputo scegliere bene gli uomini, ma ho amato e ho sperato. Tu invece hai rinunciato a ogni legame e il mondo ti ha lodata per questo. Ma chi ti ha tenuta la mano, Elisabetta, quando la notte della coscienza era buia?»
ELISABETTA
(pausa. Lo sguardo fisso altrove)
«Nessuno. Perché ho voluto che nessuno osasse. Avevo troppi occhi addosso per cedere alla debolezza. Per essere donna. Avevo il mio regno cucito sulla pelle. Ma sai, a volte ho invidiato le tue catene. Almeno quelle erano visibili. Le mie erano più sottili. Più feroci.»
MARIA
(la osserva con un’intensità nuova)
«E allora perché farmi uccidere? Perché lasciarmi cadere, se sai quanto ci hanno stretto allo stesso modo? Hai sempre cercato di fare passare l’idea che il tuo valore dipendesse dalla tua rinuncia. Io sono stata madre, sposa, amante, ciò che tu non sei mai potuta essere e che il popolo inglese avrebbe gradito. Dimmelo, perché mi mandi dal boia?»
ELISABETTA
(con voce quasi infantile)
«Perché se ti avessi salvata, non sarei più stata regina. E io sono stata educata per sopravvivere, non per amare. Ti ho temuta, Maria. Non per il potere. Ma per tutto ciò che io non potevo permettermi di essere, per tutto ciò per il quale sei maledettamente diversa da me. Ammetto tuttavia che sai leggermi come nessuno mai. Altro che mangiauomini!»
MARIA
(con tono improvvisamente dolce)
«Un po’ di carne non hai mai fatto male a nessuno, Elisabetta. Certo che è proprio vero che la genetica ogni tanto si sbaglia. Hai preso poco da tuo padre, Enrico VIII. Ma torniamo al nocciolo. Non sai quante volte ho desiderato scriverti una lettera che non fosse una supplica. Una lettera da donna a donna. Ma tu eri sempre distante. Sempre incoronata. E io sempre in ginocchio e sorvegliata a vista in quella finta casa come una criminale.»
ELISABETTA
(si alza, quasi stanca)
«Non potevo permettere che la spina nel fianco girasse indisturbata per la corte. I lord scozzesi ti davano la caccia e sei venuta a rifugiarti da me. Lo ammetto, avrei potuto agire altrimenti. Ma eri un pericolo vivente per me. E per il potere che ho ricevuto dalle mani insanguinate della mia sorellastra, un’altra papista che getta ombre sulla nostra storia. Diciamocelo, anche se non mi sottraggo alle responsabilità del tuo esilio qui, soprattutto nei modi in cui è stato attuato. Siamo state scolpite come nemiche. Una cattolica, una protestante. Una santa, una strega. Ma nessuno ha raccontato davvero il dolore che ci ha attraversate. Nessuno ci ha ascoltate. Solo giudicate e usate per partigianeria.»
MARIA
«E allora lasciamo che almeno qui, in questa stanza senza testimoni, resti la verità. Non ci siamo amate, no. Ho anche complottato contro di te. Ma ci siamo riconosciute. In segreto. Nella stessa solitudine, nello stesso orgoglio, nella stessa tragedia. E questo, forse, è più onesto di ogni perdono. E aggiungo una cosa che non dici apertamente: siamo due facce dello stesso destino, quello di nascere in un tempo in cui essere donna era già una colpa.
ELISABETTA
«Questa stanza, con le nostre verità, è più intima di qualsiasi carezza…»
(Un lungo silenzio. Elisabetta si avvicina al tavolo. Si sfila l’anello, lo posa. Lo lascia lì, tra loro.)
ELISABETTA
(guardandola negli occhi)
«Che la Storia dica pure che ti ho condannata. Ma tu sappi, e solo tu, che una parte di me morirà con te domani. Quella che nessuno ha mai conosciuto. Quella che forse, in un altro tempo, sarebbe fuggita con te, lanciando questa corona di spine nel Tamigi.»
MARIA
(si alza, dritta, fiera)
«E io morirò senza odio. Perché ho visto nei tuoi occhi ciò che nessun altro ha visto: la donna, non la regina. E questo basta. Per essere meno sola. Almeno per un istante. Ed eccoci qui insieme ancora per qualche minuto. Spogliate della leggenda. Tu sovrana d’Inghilterra, io prigioniera d’Europa. Regine sole sul crinale della Storia. Sorelle nel peso»
(Si guardano. Nessun abbraccio. Ma uno specchio. Due figure che si riflettono. Il sipario cala su un gesto che non si compie.)
EPILOGO
Due donne separate dalla fede, dalla Storia, dalla politica. Ma unite da una stessa ferita. Non riconciliazione, ma rivelazione. Questa scena non è mai avvenuta. Eppure, in qualche luogo della verità, forse sì. Sono parole rubate a due donne sempre sul ciglio del baratro che non si trovano nei romanzi ma forse in qualche angolo del silenzio.
SIPARIO
Claudio Musso

Claudio Musso: Vive e respira Torino e condivide un paio di geni con la dea Partenope. Formazione umanistica, grande appassionato di germanistica, di storia e di identità. Di giorno si occupa di risorse umane e la sera, o quando leggere e leggersi chiama, di quelle librose. Onnivoro per natura, ma intollerante al glutine e alle mode del momento, raminga con umorismo tra un lavoro che ama e altre passioni quali il teatro, l’opera lirica, e ovviamente la lettura, collaborando anche con riviste letterarie. Papà di Nadir, il suo gatto, non riesce per più di 5 minuti a prendersi troppo sul serio ma prova a fare tutto con dedizione, di quelle che danno senso e colore alla vita.