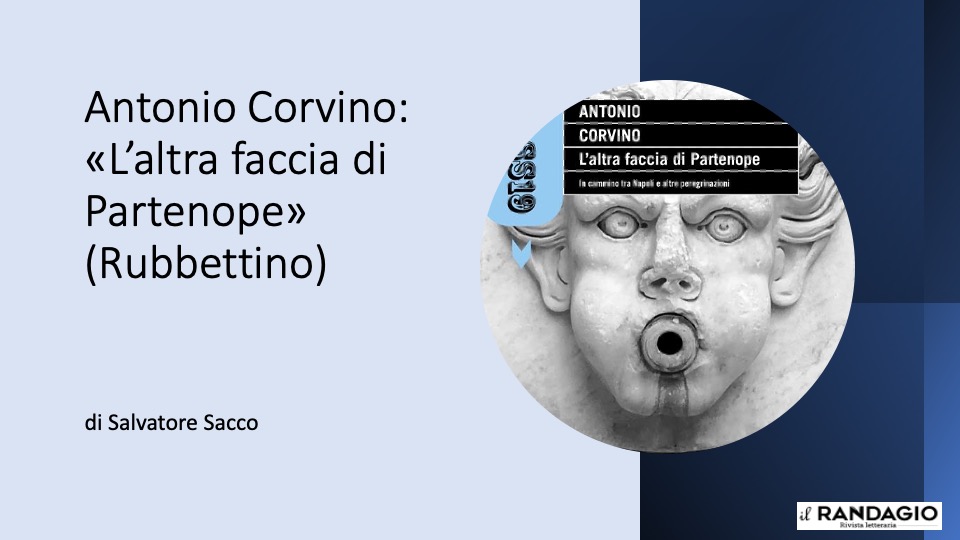Kapuściński, giornalista e reporter, acuto osservatore di terre e dei suoi abitanti, è a Teheran nei giorni in cui la storia millenaria dell’Iran persiano vive, per l’ennesima volta, una svolta determinante. L’intero paese sta infatti passando dalla morsa dell’ultimo Scià a quella del più celebre ayatollah; da un sovrano, in fondo, ad un altro, da un vacanziere patentato e armato di polizia segreta ad un transfuga all’estero pronto a ridare potere alla versione sciita dell’Islam; da un censore delle parole, se queste non esaltano la sua altezza, ad un indesiderato che fa sentire la propria voce di incitamento alla rivolta attraverso audiocassette che passano di mano in mano.

Lo scrittore è solo in un albergo disabitato di cui è l’unico cliente mentre fuori si avverte il senso di un tempo sospeso dove il silenzio, quasi irreale, è interrotto dall’odore parlante della polvere da sparo e dai coltelli che, arrotati, producono una melodia sinistra da ambo le parti della barricata: la rivoluzione iraniana è alle porte o forse è già nella testa delle persone, si attende solo la miccia. Kapuściński osserva immagini, rilegge appunti e interviste fatte a vari iraniani incontrati sul suo cammino, riannoda le proprie impressioni di questo viaggio nella vertigine e correda i suoi resoconti con puntuali riflessioni sulla esperienza della dittatura e le sue rifrazioni e conseguenze, anche psicologiche, e sulla rivoluzione di assedio, non di assalto, che il popolo opererà di lì a poco. Il tutto confluisce in Shah-in-shah uscito nel 1982, una delle opere forse più sentite dall’autore e dai lettori, e ripetutamente pubblicato da Feltrinelli nella traduzione dal polacco di Vera Verdiani.
Khomeini arriva per ultimo nelle pagine di questo libro ed è l’ultimo a salire sul palco della narrazione. Prima c’è Reza Pahlevi, lo Scià degli Scià, alfiere di una ‘Nuova Civiltà’ intrisa di Occidente, la cui parabola è il vero oggetto del testo punteggiato da una prosa vivace e amante delle istantanee. Un’occasione per dragare la storia dell’Iran e per capire in parte quella di oggi. Scrive del sovrano:
«È profondamente convinto della sua missione e sa dove vuole arrivare (per dirla con la sua innata brutalità, vuole mettere al lavoro la folla ignorante e costruire un forte stato moderno davanti al quale – dice – tutti se la facciano addosso dalla paura). Ha la mano di ferro prussiana e la sbrigativa efficienza dell’aguzzino. Il vecchio Iran apatico e sonnolento (per ordine dello scià da questo momento in poi la Persia si chiamerà Iran) trema fin nelle fondamenta».

Gli iraniani provano odio verso questa monarchia che è accreditata presso le principali cancellerie mondiali grazie al suo oro nero, è felice di vederla sparire o anche morire perché considerano lo Scià un estraneo che prende ordini dalle potenze straniere. Una testa coronata che parla un farsi tutto suo e che ha una visione del futuro in cui non si accorge del presente. Egli sta chiuso nel suo palazzo incantato e non conosce il fuori, abitato da indigenza e collasso, immerge sé stesso e i suoi protetti nel lusso più sfrenato, invade l’Iran di strumenti bellici più disparati per mostrarsi al mondo corazzato e ai tavoli che contano, fa arrivare cacciatorpedinieri in un Iran dove mancano i porti, organizza spedizioni di materiale ma mancano le strade, prova ad investire nell’industria ma mancano operai specializzati che decide di importare dall’estero. Però ha una risorsa preziosa:
«Il petrolio scatena emozioni e passioni straordinarie, perché è innanzitutto una grande tentazione. La tentazione di acquistare con poca fatica fortune colossali, forza, successo e potere. E’ un liquido sporco e maleodorante che sgorga zampillante verso l’alto e poi ricade sotto forma di una frusciante pioggia di soldi.»
L’oro nero crea l’illusione di un’esistenza completamente diversa, di una vita facile senza fatica, è una materia che contagia la mente, annebbia la vista, corrompe i cuori, rafforza il senso di potere, produce grossi profitti ma dà lavoro a poca gente, crea molti problemi sociali perché non dà vita né ad un proletariato numeroso né ad una borghesia altrettanto numerosa. Pertanto lo Scià può disporne a piacimento, ergersi a guardiano di qualcosa dal quale dipende se domani andremo in automobile oppure no. È una favola e, come ogni favola, per quanto duratura, è una menzogna perché infonde un tale senso di onnipotenza da fare credere di dribblare la sentenza del tempo.
Nella sua messa in scena il sovrano si avvale di una potente polizia segreta, la Savak, che controlla movimenti sospetti e parole che non devono mai illudere al disagio. In questo modo su un intero campo semantico si rischia di poggiare un piede per poi saltare in aria tanto da fare diventare la gente sempre più paranoica, la franchezza un sotterfugio e il coraggio una forma di collaborazione. Se anche la dittatura cade, come la fine di un brutto sogno, le irte conseguenze psicologiche sopravvivono per decenni in comportamenti inconsapevoli e nella diffidenza iraniana che ancora oggi pervade l’animo di molti, mentre l’albero del pensiero autonomo e critico fatica a rinascere.
Kapuściński riflette sul fatto che dai nascondigli, dagli anfratti e dalle fessure di queste terre sterili dove vive il popolo iraniano, privato anche dell’humus vitale dei giovani mandati all’estero, non sempre escono i migliori semmai i più forti e questi ultimi non sono creatori e promotori di nuovi valori ma sono coloro che sono riusciti a sopravvivere grazie alla maggiore capacità di resistere. E qui ci imbattiamo nello sciismo, la corrente minoritaria dell’Islam e la più accanitamente ortodossa, da sempre osteggiata e perseguitata nel mondo musulmano, il quale sembra offrire le risposte ad un’intera nazione. Più la dittatura si fa infatti repressiva, più le moschee, unico luogo che lo Scià non può toccare, si riempiono di gente, di voci libere di pensare e di dirsi. Coloro che ivi riparano non sono tutti mossi da un fervore religioso ma hanno bisogno di tirare il fiato per sentirsi di nuovo essere umani. Due mondi in naufragio trovano così lo stesso porto comune sicuro e, mentre i primi sentano allentare la presa, i secondi, il potente clero sciita, comincia il suo indottrinamento.
“Esistono popolazioni alle quali da secoli tutto va male, tutto si sbriciola tra le mani, che hanno sempre il vento contrario, che non fanno in tempo a intravedere un barlume di speranza senza che questo subito si spenga: popoli che si direbbero marchiati da un fato avverso.”
Quando cade una dittatura? Quando le persone smettono di avere paura. Perché quest’ultima fa delle persone il sostegno di un sistema che odiano, lo Scià può contare su di loro, sui loro timori e ad un cenno dall’alto rispondono, in una strana simbiosi, con un fremito di spavento. E quando cade il monarca iraniano? Quando esce un articolo di giornale con una parola di troppo che riunisce persone che non indietreggiano più di fronte ai manganelli. La rivoluzione, che rovescia l’oppressione e la miseria, coglie tutti di sorpresa, persino coloro che l’hanno sempre desiderata. Perché essa è un dramma che l’uomo tende come tale ad evitare ma è sempre un ultimo tentativo per un popolo che ha capito che non c’è altra via di uscita. Ora è tempo per Khomeini di tornare in patria e, mentre vengono abbattute le statue dello Scià, il demiurgo si mette subito all’opera:
«Il talento dello sciita si manifesta nella lotta, non nel lavoro. Contestatori nati, sempre scontenti e all’opposizione, dotati di un forte senso della dignità e dell’onore, appena scoccò l’ora di dare battaglia si sentirono di nuovo nel loro elemento»
Claudio Musso

Claudio Musso: Vive e respira Torino e condivide un paio di geni con la dea Partenope. Formazione umanistica, grande appassionato di germanistica, di storia e di identità. Di giorno si occupa di risorse umane e la sera, o quando leggere e leggersi chiama, di quelle librose. Onnivoro per natura, ma intollerante al glutine e alle mode del momento, raminga con umorismo tra un lavoro che ama e altre passioni quali il teatro, l’opera lirica, e ovviamente la lettura, collaborando anche con riviste letterarie. Papà di Nadir, il suo gatto, non riesce per più di 5 minuti a prendersi troppo sul serio ma prova a fare tutto con dedizione, di quelle che danno senso e colore alla vita.