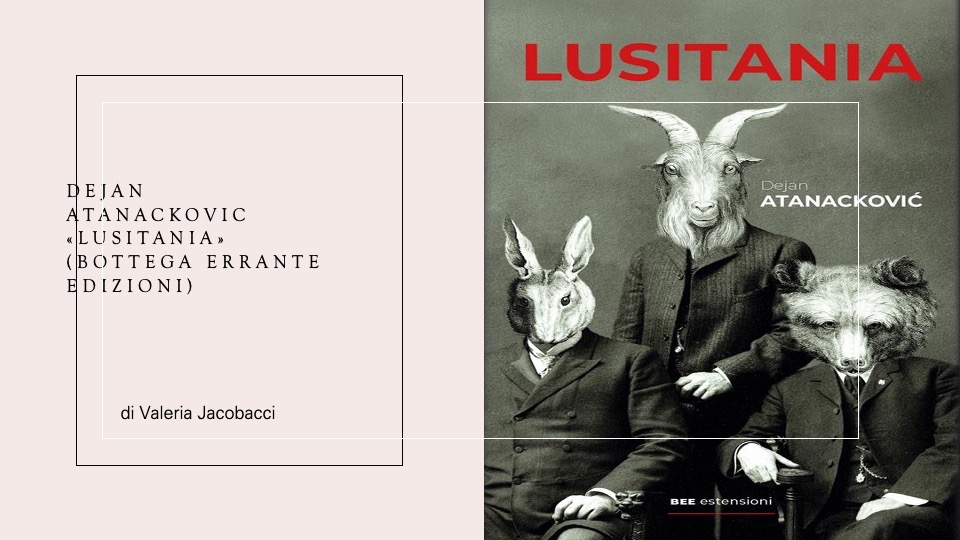Ben trovato fior di Camomilla / Memoria antica / Segno dell’infanzia amica
Un tuffo nell’infanzia, questo scritto di Antonio Corvino, non solo del poeta e dell’uomo ma di un’epoca, di un secolo, di un periodo storico, il nostro, in cui il passato si scioglie come neve al sole, il più antico come il più recente, e l’illusione di un eterno presente sbiadisce perché neanche l’attimo si lascia individuare e svanisce come un’immagine insostenibile. Uno Zibaldone ricchissimo di suggestioni, bucoliche e georgiche insieme, nel disperato salvataggio di una cultura che nessuno vuole. Nessuno? I tratturi erano percorsi tracciati dai pastori per portare le mandrie al pascolo, probabilmente le stesse mandrie contribuivano a scavare il percorso calpestandolo con gli zoccoli, in autunno il percorso era dalle montagne verso la pianura e in primavera il contrario. Antonio Corvino descrive il suo peregrinare attraverso pascoli e terre solitarie, un mitico pastore, Titiro o Melibeo, fuori tempo e dentro il tempo poetico. Chi abbia fra le mani l’ultimo libro di Ken Follet, “Il cerchio dei giorni”, per Mondadori, in bella vista sui banchi delle librerie durante il periodo natalizio, avrà letto una storia di pastori, coltivatori e abitanti dei boschi, intenti, in una mitica Valle, sprofondata in una lontana preistoria, a trasportare enormi pietre guidati da una sacerdotessa, al fine di costruire un tempio di pietra all’ombra del quale sviluppare il commercio e crescere come umanità. Si tratta evidentemente di un mito antico, da Stone Age, suggerito dall’imponente e misterioso Stonehenge o dalle Piramidi egiziane, indubbiamente la storia stessa dell’umanità alla quale manca però la dimensione poetica. Dietro questa storia infatti non c’è Teocrito, l’inventore della poesia bucolica, manca evidentemente Virgilio, perché l’antico non è stato rivisitato nei secoli dei secoli, lo sguardo del narratore è obiettivo, pragmatico e smanioso di omologazione. Che farci? Abbiamo perso alcune prospettive per favorirne altre. Il “cormorano”, uccello acquatico e solitario a rischio di estinzione, nel quale l’autore si individua, segue invece un altro percorso, almeno metaforicamente, ama la solitudine e la contemplazione, il panteismo dei poeti. La letteratura latina si rifaceva a quella greca, il taglio filosofico pervadeva lo studio del mito, in breve, era già cultura, oggetto di studio. La modernità di Greci e Romani era matura quando nasceva la poesia bucolica e pastorale. E’ ancora questa la matrice culturale del “cormorano”.

La commozione davanti a una pianta di oleandro, la suggestione di un profumo di basilico o l’emozione davanti alle distese di ginestre e alle terre ricoperte di arbusti selvatici coprenti centri distrutti dai Saraceni o templi greci di pietra una volta policroma sono gli elementi costitutivi del libro di Corvino. I personaggi di Follet non possono commuoversi e non commuovono nessuno perché sono veri, ragionevoli e molto consapevoli di una loro metastoricità. La cultura classica era smaliziata e modernissima quando Tibullo tesseva l’elogio della vita campestre e Virgilio rimpiangeva il campicello perduto. Chi ha ancora una vecchia casa in campagna può capire. I poeti romantici e preromantici scombussolarono l’idillio classico, anche all’orrido il mondo antico era abituato e lo contrapponeva nel dualismo apollineo-dionisiaco del teatro greco, l’horror batte ancora cassa al cinema, l’apollineo è più difficile e lo è perché la pace sospirata dopo gli orrori della guerra non è più legata alla primavera profumata e alle messi estive immerse nella canicola. Essere poeti è un lusso e un caso, dipende da dove si nasce e dall’animo in grado di cogliere certi sussurri. La poesia vive un momento critico, è troppo dolce o troppo salata, troppo facile e troppo difficile, troppo semplice e troppo complicata. Inoltre, la solitudine non piace, in solitudine prevale la noia perché non c’è bellezza da contemplare.
Torniamo al poeta di “La solitudine del cormorano”: ha avuto la fortuna di nascere nel Sud, in un luogo di rara bellezza, in lui si incontrano il passato e il presente, in questo scritto fatto di versi e pagine in prosa, il diario di Corvino mette insieme una placida quiete e un grande dolore di partecipazione ai mali dell’umanità: “I dittatori parlano di libertà, gli aggressori di pazienza, i violenti di bontà, i ricchi di povertà, gli ignoranti di sapienza, i guerrafondai di pace, i blasfemi di perdono e Dio stesso era diventato ateo, tanto Cristo taceva.” L’autore sintetizza così le contemporanee assurdità, l’elemento cristiano si sovrappone al mondo classico, il “cormorano” contempla le attuali incongruenze in attesa di possibili spiegazioni.
Valeria Jacobacci

Valeria Jacobacci, scrittrice e pubblicista, è appassionata conoscitrice di storia partenopea e di biografie, spesso femminili, di donne che hanno caratterizzato i loro tempi. Si è interessata alla Rivoluzione Napoletana, al passaggio dal Regno borbonico all’Unità, al secolo “breve”, racchiuso fra due guerre. Ha pubblicato numerosi articoli, saggi e romanzi.