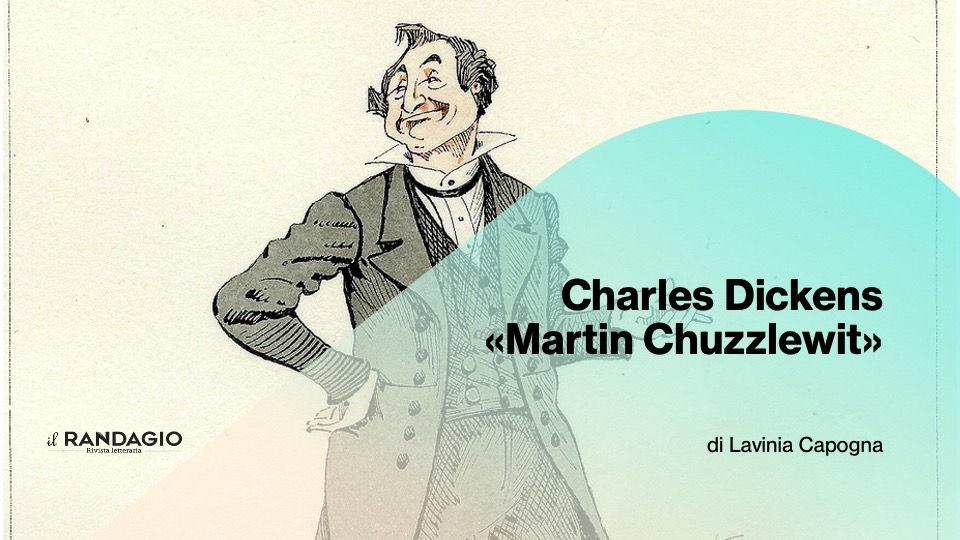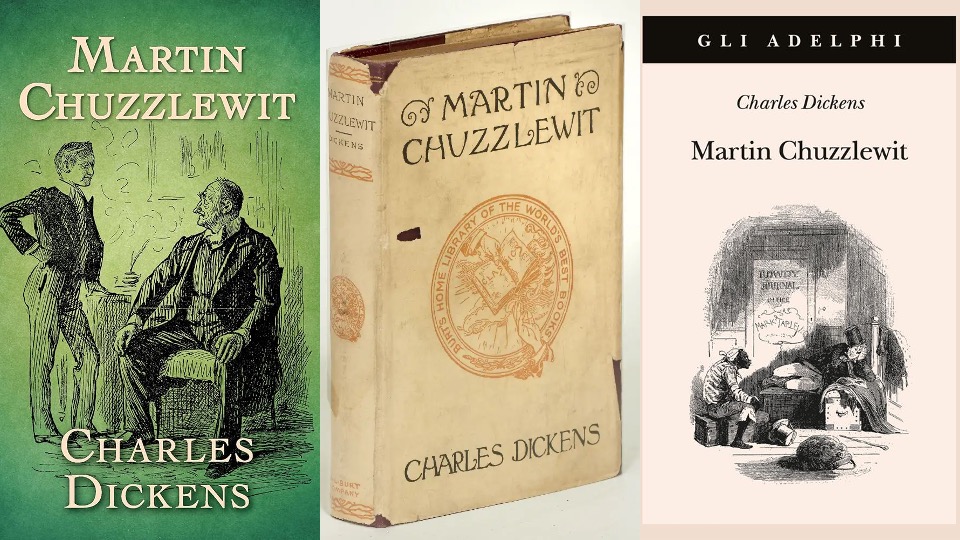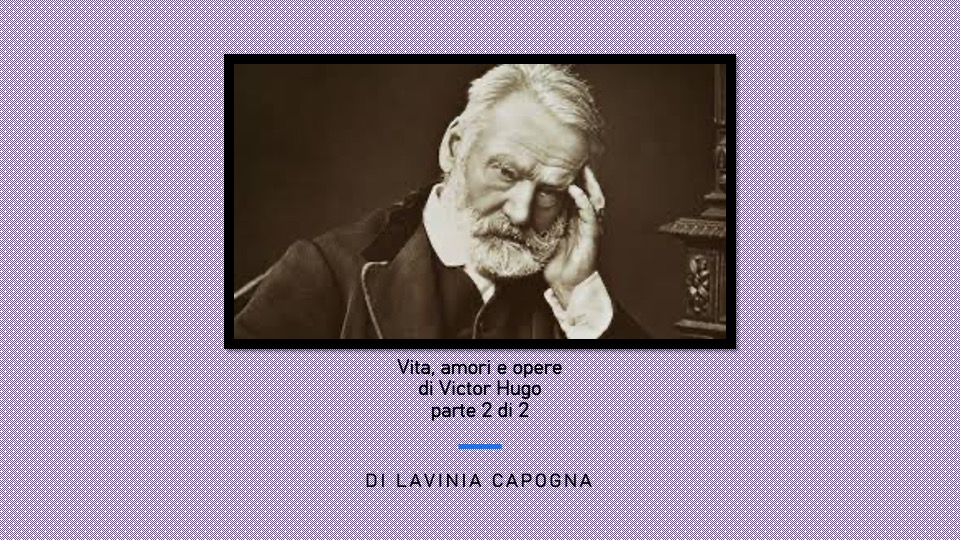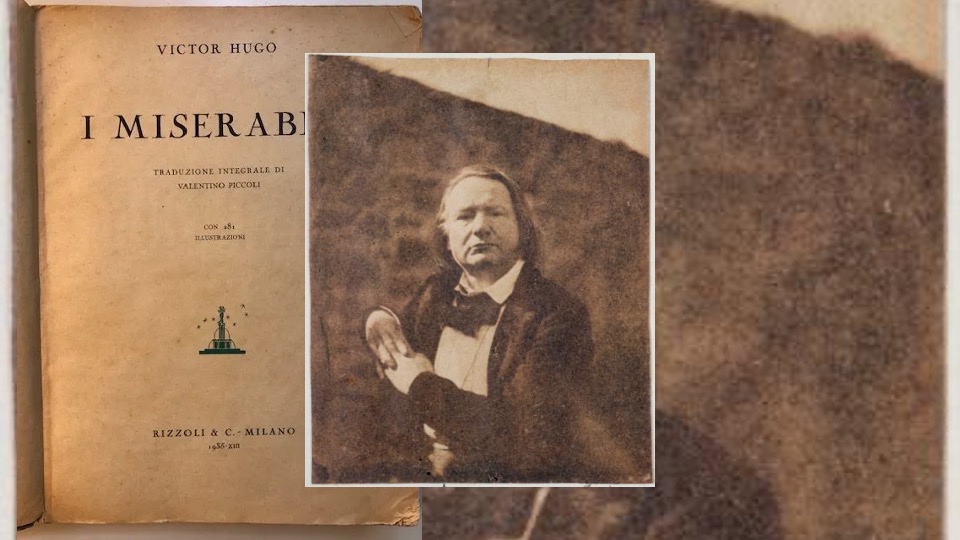Klaus Mann e Johanna, tra amore e lotta politica
“Si era avventurata con Ragnar in una regione dove non c’era nulla, solo lei e lui; ora dipendeva completamente da lui. Ma poteva contare su di lui, su di lui e sul suo incomprensibile cuore?”

Klaus Mann (1906 – 1949) è stato uno dei più bravi scrittori tedeschi della prima metà del Novecento. Non gli fu di aiuto il fatto di essere figlio di Thomas Mann, celebre scrittore e Premio Nobel. Per quanto insensato sembrava inevitabile per i critici un ricorrente confronto con il padre a cui egli non aveva mai chiesto aiuto. In realtà erano/sono due scrittori molto diversi nei temi e nello stile: il tema principale che attraversa l’opera di Thomas Mann è il dissidio tra vita d’artista e vita borghese e quello di Klaus Mann è il tentativo di vivere, riuscito o meno, in una società alienata.
Anche lui tentò di resistere e assai coraggiosamente per poi smarrirsi nell’oppio e nel suicidio, a soli 42 anni nel 1949 (*).
Gay dichiarato quando non lo era nessuno, protagonista della vita culturale e mondana nella Repubblica di Weimar (1919 – 1932), Klaus Mann fu uno dei più impegnati antinazisti tedeschi. Nel marzo del 1933 scelse l’esilio a Parigi, poi ad Amsterdam ed infine negli Stati Uniti dove divenne cittadino americano e partecipò, non combattendo, alla Seconda guerra mondiale arrivando anche a Roma dove scrisse parte della sceneggiatura del film “Paisà” di Roberto Rossellini.
Fondò anche due prestigiose riviste letterarie antifasciste a cui collaborarono parecchi scrittori e filosofi, tra i quali il nostro Benedetto Croce.
A lungo rimosso anche in Germania, perché troppo scomodo (ancora non mancano articoli di reazionari contro di lui) è stato riscoperto negli anni ’70-’80, gli sono state dedicate alcune biografie e una piazza a Francoforte sul Meno, Klaus Mann Platz.
Riguardo alla sua ampia opera letteraria c’è stato un grande ritardo da parte delle case editrici italiane. La sua bellissima autobiografia, “La Svolta”, venne pubblicata nel 1962 ma poi si dovette aspettare fino agli anni ’80 per poter leggere qualche altro suo libro tradotto sull’onda del successo del film “Mephisto”, tratto dal suo romanzo omonimo e Premio Oscar.
“Fuga al nord” (Flucht in den Norden) pubblicato nel 1934 dall’editore Querido di Amsterdam (una stimata casa editrice che fu l’unica ad accettare i testi degli esuli tedeschi) è stato finalmento edito per la prima volta in Italia nel 2024 dall’editore Castelvecchi che sta portando avanti l’encomiabile iniziativa di pubblicare l’opera omnia dello scrittore (io lo avevo letto, tempo fa, in originale e l’ho riletto in questi giorni in questa edizione assai curata).
Fu il primo libro di quella che viene denominata Exilliteratur (letteratura dell’esilio, 1933/1945).

La maggioranza degli scrittori aveva infatti lasciato la Germania quando Hitler era andato al potere: Thomas Mann, Heinrich Mann, Bertolt Brecht, Erich Maria Remarque, Anna Seghers, Ernst Toller, Ludwig Renn, Oskar Maria Graf, Jacob Wassermann, i filosofi Theodor Adorno, Hannah Arendt, Walter Benjamin, il bulgaro Elias Canetti, gli austriaci Stefan Zweig, Joseph Roth e altri.
Erich Mühsam venne invece ucciso in un campo di concentramento nel 1934.
La protagonista del romanzo è Johanna una ragazza tedesca ventenne, comunista, intelligente e vulnerabile, che ha appena lasciato la Germania grazie ad un passaporto falso.
Ella raggiunge nella bianca e quieta Helsinki in Finlandia una sua amica e compagna di studi, Karen.
Karen è una ragazza molto graziosa, dolce e ragionevole.
Johanna pensa di fermarsi solo qualche giorno e poi di raggiungere i compagni a Parigi.
La stessa sera del suo arrivo conosce Jens, uno dei fratelli di Karen, uno snervante, spudorato fascista che l’importuna mentre ballano insieme.
Finalmente tornate a casa, Johanna racconta a Karen qualcosa della devastante realtà tedesca. Poi, inaspettatamente, le due ragazze fanno l’amore – che qui assume valore di un atto di conforto e di empatia piuttosto che sentimentale. Sarà l’unica volta – Karen, che è innamorata di Johanna e che già nella sua famiglia è sacrificata, le celerà abilmente la sua delusione.
Ma c’è anche un segreto nella vita di Karen, qualcosa che lei non ha raccontato neppure a Johanna.
Nella vasta tenuta di campagna della famiglia, Johanna incontrerà gli altri familiari e Ragnar, l’altro fratello di Karen, indolente, mutevole, affascinante, antifascista, che le presterà un libro di Rimbaud. Sarà l’inizio di un percorso emotivo, di un amore senza domani, di un oscillare tra il dovere etico dell’impegno e un desiderio di fuga e di oblio in sintonia con il viaggio, quasi iniziatico, che i due amanti faranno agli estremi confini del paese, tra splendidi boschi e laghi ma anche desolati villaggi lapponi.
Il Leitmotiv del libro è lo straniamento di Johanna di fronte al mondo che è andato in frantumi (le persone di una certa età che non riescono più a ritrovarsi, i suoi confusi e dignitosi genitori, la madre di Karen che vive del lontano passato quando la Finlandia faceva parte dell’Impero russo e si andava in vacanza sulla Costa Azzurra francese), la brutalità inaudita del nazismo, un mondo in cui tutti i valori si stanno disintegrando, in cui il suo amico Bruno è a rischio della vita, in cui si perde la patria (bellissimo il dettaglio dell’emozione che lei prova nel vedere casualmente dei libri tedeschi nella locanda). In cui, infine, l’amore stesso può essere conforto, come con Karen, ma anche annullamento, come con Ragnar.
Ciò che ha attratto di più del libro nel tempo è stata la storia d’amore, piuttosto osé, tra Johanna e Ragnar ma in realtà esso descrive perfettamente la situazione politica senza essere mai didascalico.
Lo stile è scorrevole, assai coinvolgente, intenso come un crescendo musicale, a tratti struggente, in qualcosa chiaroveggente (la lucidissima previsione della guerra che scoppierà cinque anni dopo).
La trama si ispira ad una storia vera: Ragnar è un ritratto dell’avvenente Hans Aminoff con cui Klaus Mann aveva avuto una breve ma importante relazione sentimentale. Poco dopo Aminoff si era sposato. Egli era rimasto in contatto con Klaus Mann che aveva provato sentimenti di rimpianto, come si legge nei suoi “Diari”.
Aminoff aveva anche acquistato tutte le copie di “Fuga al nord” nelle librerie di Helsinki temendo di essere riconosciuto (apparteneva ad una famiglia nobile assai nota nel paese).
A Johanna invece aveva dato i tratti della sua amica Annemarie Schwarzenbach, bionda e delicata scrittrice svizzera.
(*) Per chi volesse approfondire le opere e la vita di Klaus Mann suggerirei il mio articolo “Klaus Mann e l’integrità intellettuale”, che si trova nel mio libro “Pagine Sparse – Studi letterari”.
Nota: da “Fuga al nord” è stato tratto nel 1986 un film discontinuo diretto dalla regista finlandese Ingemo Engström.
Lavinia Capogna*

*Lavinia Capogna è una scrittrice, poeta e regista. È figlia del regista Sergio Capogna. Ha pubblicato finora sette libri: “Un navigante senza bussola e senza stelle” (poesie); “Pensieri cristallini” (poesie); “La nostalgia delle 6 del mattino” (poesie); “In questi giorni UFO volano sul New Jersey” (poesie), “Storie fatte di niente”, (racconti), che è stato tradotto e pubblicato anche in Francia con il titolo “Histoires pour rien” ; il romanzo “Il giovane senza nome” e il saggio “Pagine sparse – Studi letterari”.
Ha scritto circa 150 articoli su temi letterari e cinematografici e fatto traduzioni dal francese, inglese e tedesco. Ha studiato sceneggiatura con Ugo Pirro e scritto tre sceneggiature cinematografiche e realizzato come regista il film “La lampada di Wood” che ha partecipato al premio David di Donatello, il mediometraggio “Ciao, Francesca” e alcuni documentari.
Collabora con le riviste letterarie online Insula Europea, Stultifera Navis e altri website.
Da circa vent’anni ha una malattia che le ha procurato invalidità.