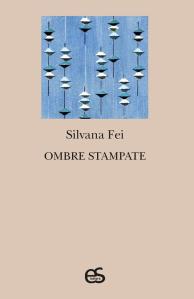Sandra Petrignani fra le ombre di Jung
A ottobre Neri Pozza ha pubblicato l’ultimo romanzo di Sandra Petrignani, Carissimo dottor Jung, che ruota intorno alla figura del fondatore della psicologia analitica. Come accade spesso nelle opere di Petrignani, nel libro la realtà si mischia alla finzione formando una simbiosi narrativa particolarmente efficace. In Carissimo dottor Jung ci si raffronta anche al tempo perduto o – per dirlo con più leggerezza – al tempo che “passa”, cioè alla vecchiaia e alla morte, come scoprirà il lettore del romanzo. Ho pensato di porre a Sandra Petrignani qualche domanda.

EP: Comincerei osservando la peculiarità della struttura del libro, con i capitoli della scrittrice Egle Corsani, che sta per l’appunto scrivendo un romanzo su Jung, alternati ai capitoli che narrano della visita di Christiana Morgan a Jung, che infatti è proprio Egle a scrivere. Nel corso degli anni, direi a partire da La scrittrice abita qui, uscito nel 2002 sempre per Neri Pozza, hai creato una nuova forma di narrazione biografica che è a un tempo romanzo e documento. Molti tuoi libri sono sia affabulazione narrativa che concreta ricerca dei fatti, cioè delle vite di cui ti occupi. È stato un processo studiato? Hai sempre saputo dove ti avrebbero portata le esistenze che affrontavi? Quanta intelligenza c’è nelle tue strutture narrative? Qual è invece la loro componente istintiva?
SP: Comincio dalla fine. Direi che la componente istintiva è predominante. È l’istinto a dirmi: di Duras occorre che tu ne sappia di più, oppure: Jung può aiutarti parecchio in questo momento difficile della tua vita. Io seguo l’istinto non solo quando scrivo, ma anche nei rapporti con le persone, nelle scelte che mi trovo a fare… E poi naturalmente studio, approfondisco, osservo a lungo le immagini, le fotografie, i gesti dei personaggi di cui mi occupo, dentro i video se ce ne sono. Dicono moltissimo la voce, la gestualità, la forma delle mani, i tic, lo sguardo. Anche quando, da giornalista, intervistavo grandi protagonisti, li lasciavo parlare dentro il registratore e intanto osservavo con molta più attenzione il loro muoversi nello spazio, il modo in cui si rivolgevano a me.
EP: A un certo punto Egle osserva che alla sua amica, Lorenza, non interessa tanto la trama del libro che sta leggendo quanto la mano del grande scrittore che c’è dietro, cioè lo stile. Suppongo che sia così anche per te; non per niente uno dei tuoi autori prediletti è Thomas Bernhard, un grande stilista. D’altra parte in Carissimo dottor Jung sembri quasi riappacificarti con alcune tecniche dei romanzi più prettamente narrativi; penso in particolare ai dialoghi. Il tuo è anche un libro sulla vecchiaia e sulla perdita. La forma tradizionale del romanzo – dialoghi compresi – è necessaria per raccontare il morire del tempo intorno a noi? Mi interessa il tuo parere sia di scrittrice che di lettrice.
SP: In realtà non ho simpatia per i dialoghi, né come scrittrice né come lettrice. Preferisco il discorso indiretto. Ma in questo mio Jung ho dovuto arrendermi a parti molto dialogate, perché volevo immaginare il modo di essere del grande analista svizzero nella vita quotidiana, nell’umiltà con cui intratteneva rapporti con i suoi cani, col giardiniere, con l’amica-badante Ruth, e perché dovevo farlo interloquire non solo con Christiana Morgan, venuta a Küsnacht dagli Usa proprio per dialogare di nuovo con lui dopo tanti anni, ma anche con pazienti e colleghi, donne soprattutto. Del resto la terapia analitica si basa sul dialogo, no?
EP: Infatti è forse il tuo romanzo con più dialoghi. A un certo punto Egle dice di essere stata a trovare Italo Calvino e Antonio Tabucchi nei loro appartamenti parigini. Sei davvero stata a trovarli? A proposito di Tabucchi – e tornando alla domanda che ti facevo prima – mi viene in mente un suo titolo postumo che è in realtà un verso di Carlos Drummond De Andrade: Di tutto resta un poco. Ti chiedo: cosa resta di tutto quanto, cioè delle vite che viviamo o che abbiamo vissuto? I capitoli finali del libro, mi sembra, rispondono in parte a questa domanda…
SP: Ho conosciuto Tabucchi quando per un periodo ha abitato a Roma. Provò anche a farmi pubblicare il mio primo romanzo, Navigazioni di Circe, da Adelphi, ma senza successo. A Parigi però non sono mai andata a trovarlo, anche se eravamo rimasti in contatto e ho sempre molto amato i suoi libri. Di Calvino ho visto ben tre case: quella di Roma per un’intervista e quelle di Parigi e di Roccamare dopo la sua morte, perché ero diventata amica della moglie Chichita. Avevano molto amato entrambi quell’intervista, fatta due mesi prima che morisse, e lei mi chiese di darle la registrazione. Così feci e mi prese in grande simpatia… Non so cosa pensassero Calvino e Tabucchi del “dopo”, io mi sono convinta, attraverso il buddismo, certi studi sulla reincarnazione, e con Jung, che non finisca tutto con la morte, ma che la vita sia un’esperienza fra un prima e un dopo di cui dovremmo approfittare al meglio per accorciare il ciclo delle rinascite.

EP: Restando in qualche modo nel tema delle rinascite, in Egle non è difficile individuare un tuo doppio romanzesco, come già nella Nina di Addio a Roma e nella Elettra di Autobiografia dei miei cani. Nel capitolo L’osservatore è l’osservato – titolo che proviene da una frase di Krishnamurti – scrivi: “Forse il romanzo su Jung è venuto a chiudere un cerchio nella sua vita. O magari ad aprirlo?” Credi che Carissimo dottor Jung sia la “biografia romanzesca” (ma la definizione è inesatta) in cui racconti più di te? Pensi davvero che possa chiudere un cerchio? O magari – come lascia intuire il saluto dell’uomo alla fine del romanzo – ne stai aprendo un altro? Il tuo Jung è un arrivederci o un addio?
SP: Al momento non ho nessuna spinta interiore per mettermi a scrivere qualcos’altro. E io non so scrivere romanzi tanto per scrivere. È stato un’esperienza molto forte questo mio Jung effettivamente e del resto non ho niente di impubblicato, se non un mucchio di racconti, dentro i cassetti, su cui mettermi a lavorare. Ma i racconti sembra non li voglia leggere nessuno… Chissà poi perché…
EP: Io li leggerei volentieri. Ho amato molto i racconti di Poche storie (Theoria, 1993), che andrebbero ripubblicati, e prima o poi mi procurerò anche i racconti di Vecchi (Theoria, 1994; Baldini&Castoldi, 1999). Ma torniamo a Carissimo dottor Jung. Lo definirei un grande libro di sogni. Ti capita mai di sognare gli scrittori che hai conosciuto? E quelli che hai letto o di cui hai scritto? I morti ti dicono qualcosa, come in quella poesia di Wisława Szymborska, Intrighi con i morti? Le ombre ti spaventano?
SP: No, non mi spaventano per niente. Vivo fra molte ombre, del resto. Ma sogno poco, e ancor meno ricordo. Scrittori non mi pare di averne mai sognati. Comunque Szymborska è una poetessa del mio cuore…
EP: Nel libro Jung sostiene di avere le prove dell’esistenza di un aldilà. D’altronde molte tue opere parlano di fantasmi. Non penso soltanto alle biografie, ma anche, per esempio, a Care presenze, o persino a Catalogo dei giocattoli, come scrive Manganelli nella prefazione (“Scrivere un libro sui giocattoli. Non è un’idea brillante? Semplice? Inquietante? Ma è, forse, un’idea terribile. È come scrivere un libro sui fantasmi, sulle apparizioni…”). Per te leggere significa convivere con gli spettri? E scrivere?
SP: In parte sì, è proprio così. Soprattutto scrivere. È portare a galla l’inconscio, che di fantasmi è fatto – prima di tutti quello dell’infanzia – e se ne intende. Leggere uno scrittore con cui sono in sintonia è conoscerlo profondamente. Se è morto, sì, un po’ è riportarlo in vita.
EP: Hai un rapporto molto particolare con la morte e con i morti. Ti capita mai di visitare i cimiteri? La possibile esistenza di un aldilà ti spaventa o ti rassicura?
SP: I cimiteri non mi piacciono. I miei morti cerco di tenermeli vicini, “sentirli”. Mi spaventa il buio. La fine totale di tutto, che tutto ciò che si è faticosamente capito nella vita vada perduto. Mi sembra uno spreco insensato.
EP: Per allontanarci dal macabro direi di porti una domanda che è anche un divertente corto circuito fra realtà e finzione. A un certo punto del libro, nel capitolo La turbolenta corrente del tempo, Egle legge a Lorenza il romanzo Emma, di Jane Austen. Ora, nel 2012 hai tradotto proprio Emma, per Einaudi. Egle legge l’edizione Einaudi? Il tuo alter ego ha fra le mani la traduzione di Sandra Petrignani? O magari hai immaginato un mondo alternativo in cui Egle Corsani – e non Sandra Petrignani – ha tradotto Jane Austen. Ma cosa ti ha spinto a tradurre proprio Emma?
SP: Emma è davvero il romanzo che amo di più di Austen. Per questo l’ho tradotto. Ma tradurre è un mestiere molto difficile, più di scrivere, perché devi scrivere assumendo un’altra identità! Per questo l’ho fatto raramente.
EP: Carl Jung è il primo uomo a cui dedichi un romanzo. È stata un’esperienza diversa rispetto ai libri su Marguerite Duras e su Natalia Ginzburg? In questi anni di scrittura ti sei sentita anche “attratta” da lui, come talora capita alla tua Egle? Jung era un tipo burbero, scrivi, però capace di infinita dolcezza. Era il tuo genere di uomo?
SP: No, proprio no. Troppo Maschio Alfa, troppo consapevole. A me sono sempre piaciuti gli “incrinati” come diceva Grazia Deledda. Però, un momento, parlo di me giovane. Ora magari mi potrei innamorare di uno come lui che ha risposte per tutto, chissà… Non a caso ho scelto di raccontarlo da vecchio, nell’ultimo anno di vita, quando più che risposte, torna a farsi tante domande…
Io, scrivendo, amo spostarmi sempre. Ho scritto dei luoghi delle scrittrici e in tante si sono messe a farlo. Ho scritto di scrittrici famose… idem. Entrare in una psiche maschile è più difficile se sei una donna? Mah, devo dire che mi è piaciuto molto. Forse anche perché Jung era un uomo che capiva profondamente le donne, e le stimava, e le amava.
EP: Sebbene tu non sia un’autrice per così dire “politica”, si sente che hai scritto Carissimo dottor Jung in un tempo di guerre crudeli e insensate. Le guerre le fanno soprattutto gli uomini. Penso all’Ucraina, penso a Gaza… Il Jung bambino e il Jung anziano sono tormentati dalla stessa domanda: “Se Dio è buono, perché il male?” Lasciando da parte Dio, ti chiederei la stessa cosa, cara Sandra: perché esiste il male? L’uomo si salverà dalla sua stessa ferocia?
SP: Non ne era sicuro nemmeno Jung, figurati io! Certo il periodo che stiamo attraversando sembra essere tornato a una barbarie che la tecnologia avanzata rende più devastante e forse più crudele. E non solo per le guerre che si sono scatenate fino a sfiorarci, ma anche per la psiche dei singoli che si scatena in comportamenti efferati. E spesso ancora più ignobili perché stupidi. C’è in giro una pericolosa incapacità di ragionare, di capire se stessi e l’altro da sé.
EP: Amo molto alcuni tuoi romanzi ormai fuori edizione. Penso in particolare a Come fratello e sorella, pubblicato da Baldini&Castoldi nel 1998, dove c’è una definizione del suicidio molto forte ma a mio parere decisiva: “Il suicidio, sosteneva lui, non è una richiesta di affetto, non è un gesto amichevole. È mandare a fare in culo tutti quanti, definitivamente, e tutti insieme.” Prima o poi il libro si ristamperà? Che rapporto hai con i tuoi libri più vecchi? Dopotutto hai pubblicato Navigazioni di Circe nel 1987, ben prima del Circe di Madeline Miller…
SP: Non mi rileggo mai, se non per caso. Non sono molto attaccata a quel che ho scritto, anche se sono contenta di averlo fatto. Per cui non mi do per niente da fare perché i miei libri tornino in libreria. Non tormento gli agenti letterari, non ricatto gli editori. Se ci pensano loro, bene (e devo dire che qualche volta lo fanno), se no, pazienza. Vivo molto nel presente. E poi il mondo è pieno di libri fondamentali che la gente non ha ancora letto…
EP: Rileggendo le parole sul suicidio e gli elenchi di Come fratello e sorella mi è tornato in mente un brano molto bello di Carissimo dottor Jung, ossia quando Egle pensa che la vita è “un gioco di costruzioni che si sfalda”. L’affermazione potrebbe riguardare anche Catalogo dei giocattoli, in effetti, ma non solo. Una delle particolarità delle tue opere, credo, è di osservare con lucidità non tanto la morte quanto il morire del tempo. O meglio, il passare del tempo, come dice l’insegna del bar in cui si incontrano Egle e Lorenza alla fine del libro, raffrontando il tempo che “passa” al tempo “perduto” di Proust. In fin dei conti il tempo che passa o che muore è anche la storia di Addio a Roma, no? E torniamo al verso di Carlos Drummond De Andrade che ti ho citato in precedenza: Se di tutto resta un poco. Il tempo che passa ma che riaffiora nelle opere può essere – per il lettore, per lo scrittore – un tempo presente, vale a dire vivo? La letteratura e l’arte sono un ripiego dalla vita che fugge o anche una possibile àncora di salvezza?
SP: Che belle cose mi dici e che belle domande. Ma io non ho una mente filosofica e quindi tutto quel che posso dire è molto personale. Per me scrivere (e leggere inevitabilmente) è stata un’àncora di salvezza fin da piccola. Credo che i veri artisti con la loro arte hanno cercato e cercano soprattutto di guarirsi, e di essere amati, anche, forse. Quanto all’immortalità dell’opera immagino che, in punto di morte, sia una ben magra consolazione….
EP: Un’ultima domanda. A un certo punto il tuo Jung dice a Christiana: “Il compito consiste nell’adempimento della propria vocazione e singolarità. È questo che dà un senso alla vita, ma è un compito che non esclude la possibilità della sconfitta.” Quali sentimenti e emozioni smuovono in te queste parole? Sandra Petrignani, a differenza di Christiana Morgan, sa accettare la “sconfitta”?
SP: Ne ho dovute accettare parecchie sinceramente. E sono una che ama arrendersi, piuttosto che combattere con le unghie e coi denti. Quella frase di Jung, come altre, è un grande insegnamento. Conoscersi, cercare di essere all’altezza della propria vocazione (che può essere anche semplicemente quella di non averne nessuna) e accettare la possibile sconfitta senza tragedie e senza farlo pagare a chi abbiamo vicino. Io mi aiuto anche un po’ con qualche farmaco, quando serve. Che male c’è?
EP: Grazie.
Edoardo Pisani*

*Edoardo Pisani è nato a Gorizia nel 1988. Ha pubblicato i romanzi E ogni anima su questa terra (Finalista premio Berto, finalista premio Flaiano under 35) e Al mondo prossimo venturo, entrambi con Castelvecchi. Sempre con Castelvecchi ha pubblicato un libro su Rimbaud, E libera sia la tua sventura, Arthur Rimbaud! Nel 2026 Marsilio pubblicherà il suo terzo romanzo.