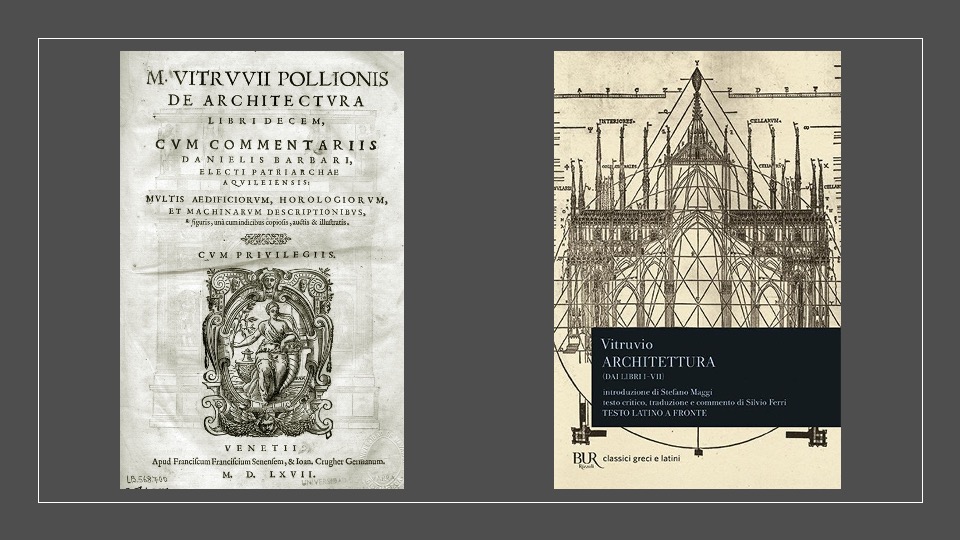Johann Wolfgang von Goethe nasce nel 1749 a Francoforte da una benestante famiglia borghese. La cultura dell’epoca è sintetizzata nelle sue opere. Nel Prometeo c’è tutto lo Sturm und Drang, ne I dolori del giovane Werther tutta la passione romantica che rompe con la ragione dell’Illuminismo, nella trilogia del Wilhelm Meister l’evoluzione del borghese dal momento della rivolta contro la propria famiglia fino al suo inserimento sociale come medico per operare in modo attivo nella società ed essere utile agli altri.
Il”Faust” riflette un personaggio storico effettivamente esistito: Johannes Georg Faust, nato nel 1480 nel Wuettenberg, che si attribuiva straordinarie qualità, ma era solo un intelligente ciarlatano. L’opera tutta possiamo considerarla espressione del classicismo di Weimar su cui si consoliderà l’amicizia tra Schiller e Goethe. Il Faust come sintesi letteraria della filosofia kantiana e dell’ Inno alla gioia di Beethoven.

Per avere accesso al significato profondo del Faust di Goethe bisogna cercare di spiegare la parola chiave per comprenderlo: la ”Sehnsucht,” termine romantico che non è nostalgia, nel senso in cui comunemente la intendiamo, ma desiderio del desiderio, tensione inappagabile che il Faust vorrebbe superare proprio stipulando il patto con Mefisto. Quest’ultimo avrebbe potuto conquistare la sua anima qualora Faust fosse riuscito a dire all’attimo: ”fermati sei bello”-“verweile doch, du bist so schön”- Faust non vorrà raggiungere fama, gloria e potere come il Faust di Marlow, ma semplicemente sentirsi appagato anche per un solo attimo nella sua vita. Il Faust di Goethe è la sintesi dell’essere Uomo e delle sue alterne vicende. Ma perché Faust, nonostante i suoi innumerevoli errori, sarà alla fine salvato? Nel prologo, nel dialogo tra il Signore, der Herr, e Mefisto, il primo affermerà che “l’uomo nella sua tensione oscura è sempre cosciente della retta via – der Mensch in seinem dunklen Drang ist des rechten Weges wohl bewusst”. In parole semplici l’azione ci induce all’errore. Così la romantica Sehnsucht è in contrapposizione all’ideale classico, che sarà ricerca di equilibrio tra mondo esteriore e mondo interiore, tra tensione idealistica e senso della realtà, consapevolezza dei limiti che dobbiamo pur porci e diventa, in senso positivo, lo “Streben nach” il tendere verso qualcosa, il motore di ogni azione umana. Essa è l’elemento determinante del Bildungsroman, Romanzo di formazione, a cui il Faust, anche se conosciuto comunemente come tragedia, appartiene. E’ la Sehnsucht, lo Streben nach (il tendere verso qualcosa) che porteranno l’io narrante a raggiungere, attraverso l’Erfahrung, esperienza e l’Erlebnis, esperienza vissuta, l’Erfuellung, la realizzazione di sé, la pienezza. Faust, desideroso di sapere, si rende conto di non saper nulla. Il suo è un sapere libresco, ciò che gli manca è la vita reale.

Il primo tentativo di Mefisto per conquistare l’anima di Faust è quello di condurlo nella Cantina di Auerbach a Lipsia tra gli studenti, ma egli non si sente attratto da quella vita. Mefisto lo porta, allora, nella cucina della strega dove viene ringiovanito. Gli farà poi conoscere Margarethe dalla quale si sentirà fortemente attratto, ma ciò che attrae Faust è la semplicità di Margarethe, è il vederla felice nel suo piccolo mondo. Affinché si consumi la storia d’amore tra i due sarà la stessa Margarethe a somministrare alla propria mamma un sonnifero che purtroppo sarà letale. Faust sedurrà la giovane abbandonandola subito dopo. Sarà sfidato a duello dal fratello di lei che ne vorrà vendicare l’onore. Mefisto condurrà Faust sul Brocken per fargli vivere la famosa notte di Valpurga abbandonandosi ai piaceri, ma egli è richiamato dall’immagine di Margarethe, donna –amore contro la donna –lussuria, ritornerà da lei e la troverà in prigione in quanto infanticida. Faust vorrebbe farla fuggire, ma lui è lì per il suo dovere di uomo, non per amore. Lei lo capisce e dichiarerà la sua volontà di espiazione.
Le successive esperienze di Faust sono legate al mondo della politica. Alla corte dell’imperatore insieme a Mefisto rimetterà a posto le finanze dello Stato.
Lunga è la via della conoscenza ed anche l’Arte è un gradino nel percorso della conoscenza e della comprensione del senso della vita. Mefisto evocherà Elena di cui Faust si innamorerà. Elena simbolo della bellezza e dunque dell’Arte. L’unione tra Elena e Faust rappresenta l’incontro tra il mondo nordico-romantico e quello greco-classico. Dalla loro unione nascerà Euforione che ha la bellezza della madre ed il titanismo faustiano. Grecità classica e titanismo non sono equilibrati. L’elemento dionisiaco prevarrà in lui e sarà causa della sua fine. Euforione morirà lanciandosi, novello Icaro, da una rupe per unirsi a coloro che combattono in Grecia per la libertà, morendo chiede alla madre di non abbandonarlo, lei lo abbraccia e insieme svaniscono nel nulla, a Faust rimane tra le mani solo il velo di Elena. L’incontro con Elena, l’incontro con l’Arte, è un altro gradino dell’esperienza faustiana, ma non rappresenta l’assoluto, esso costituisce un momento nella formazione dell’individuo, ma non può sostituirsi alla realtà. L’Arte non può essere tutto nella vita dell’uomo, non è il suo ultimo senso.
Faust è ora chiamato dall’imperatore che gli affida come feudo un litorale che dovrà strappare alla furia del mare, rendere fertile e qui fondare una nuova società dove gli uomini vivranno in pace e dove regnerà la giustizia sociale. L’idea più alta che l’uomo possa perseguire. Improvvisamente accade l’impensabile, a Goethe non sfugge niente del comportamento umano. Faust lavora alacremente ed in modo instancabile alla fondazione di questa nuova società. La sua è però una società artificiale e meccanizzata, nel suo desiderio di conquista e di potere la ybris non si acquieta e cosi ordina a Mefistofele di cacciare Filemone e Bauci, che li vivevano tranquilli, la capanna viene incendiata e l’anziana coppia muore tra le fiamme. E’ una società giusta quella che Faust crea? E’ una società giusta che germoglia da ciò che è ingiusto, “come la crescente inclinazione ad imporre ciò che è giusto attraverso ciò che è ingiusto, ma se si scruta in questo nuovo germe del giusto vi si scopre una macchiolina che si dilata “ (Italo Calvino) E’ cosi? La risposta rimane aperta. Ormai Faust è alla fine del suo cammino, la vecchiaia lo sopraffà, diventa ricurvo e cieco. Si sente in pace e sereno e immagina la felicità degli uomini. Ora finalmente può dire all’attimo: “Fermati sei bello”. Sembrerebbe che Mefisto abbia vinto la scommessa e invece no.
Gli Angeli canteranno: “Es Irrt der Mensch solange er strebt”: “Colui che agisce sbaglia” e “Wer sich streben immerbemüht, den müssen wir erlösen”, “Chi agisce deve essere salvato”.
Oggi non abbiamo ancora smesso di porci la domanda: Come perseguire il bene senza fare il male?
Maurizia Maiano*

*Maurizia Maiano: Sono nata nella seconda metà del secolo scorso e appartengo al Sud di questa bellissima Italia, ad una cittadina sul Golfo di Squillace, Catanzaro Lido. Ho frequentato una scuola cattolica e poi il Liceo Classico Galluppi che ha ospitato Luigi Settembrini, che aveva vinto la cattedra di eloquenza, fu poeta e scrittore, liberale e patriota. Ho studiato alla Sapienza di Roma Lingua e letteratura tedesca. Ho soggiornato per due anni in Austria dove abitavo tra Krems sul Danubio e Vienna, grazie a una borsa di studio del Ministero degli Esteri per lo svolgimento della mia tesi di laurea su Hermann Bahr e la fin de siècle a Vienna. Dopo la laurea ritorno in Calabria ed inizio ad insegnare nei licei linguistici, prima quello privato a Vibo Valentia e poi quelli statali. La Scuola è stato il mio luogo ideale, ho realizzato progetti Socrates, Comenius e partecipato ad Erasmus. Ho seguito nel 2023 il corso di Geopolitica della scuola di Limes diretta da Lucio Caracciolo. Leggo e, se mi sento ispirata e il libro mi parla, cerco di raccogliere i miei pensieri e raccontarli.