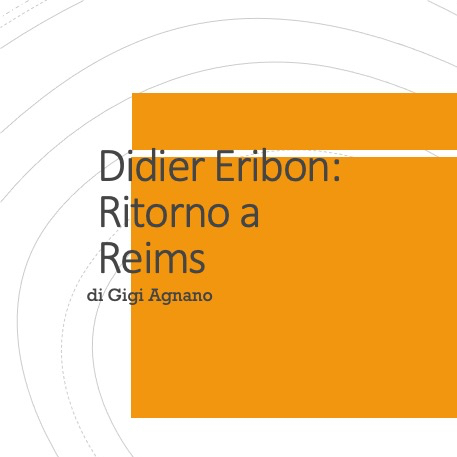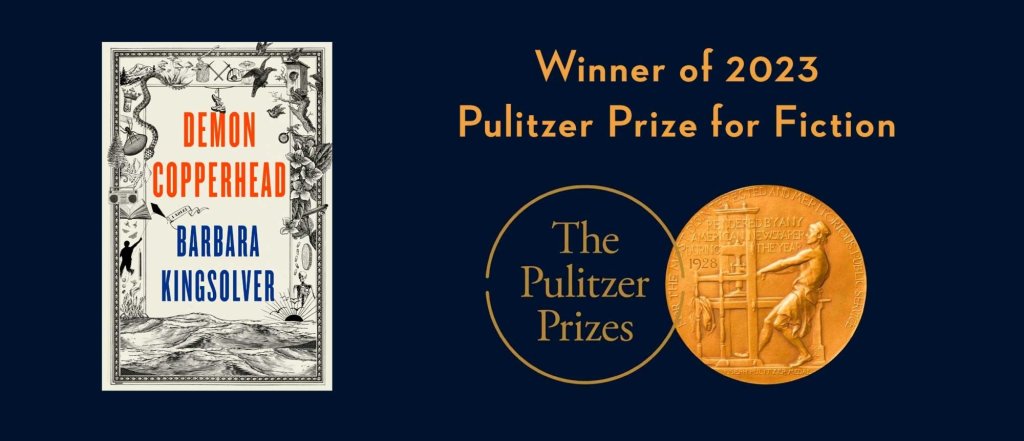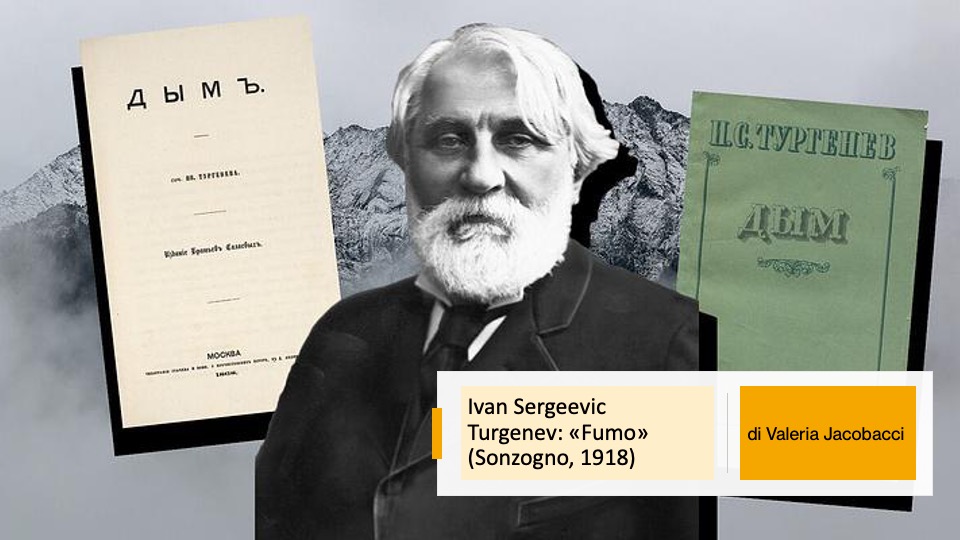Nei romanzi di Édouard Louis, di cui il Randagio si è occupato recentemente (leggi l’articolo), viene più volte citato come mentore e fonte d’ispirazione il sociologo Didier Eribon, in particolare per la sua opera più famosa che è “Ritorno a Reims”, uscita in Francia nel 2009 e pubblicata in Italia da Bompiani con la traduzione di Annalisa Romani.
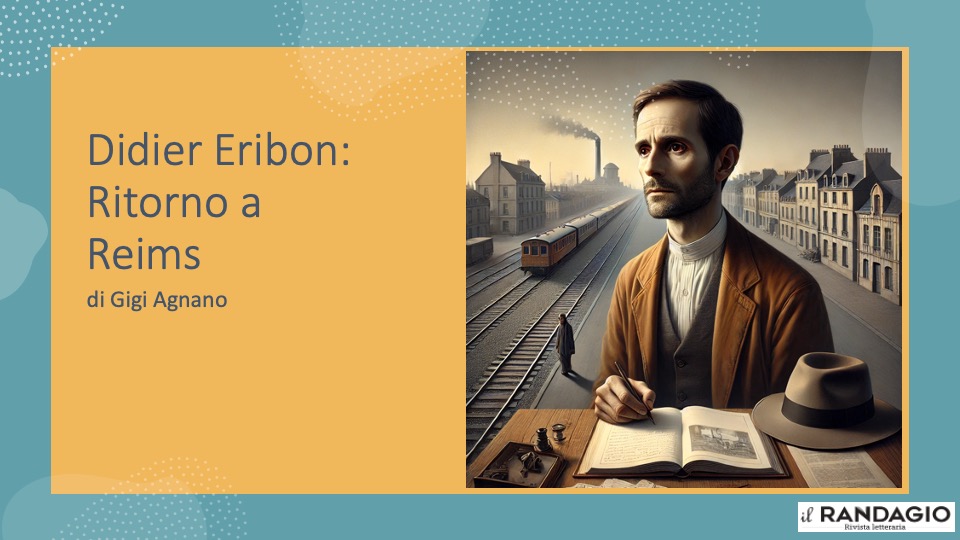
In un lavoro che è per metà autobiografia e per metà saggio sociologico, Eribon racconta il ritorno nella città natale a seguito della morte del padre. È l’occasione per rituffarsi con la memoria nell’ambiente d’origine da cui si era separato trent’anni prima. Sfogliando con la madre l’album fotografico, ricorda l’infanzia e l’adolescenza nel quartiere operaio della cittadina di provincia, i litigi incessanti in famiglia, l’odio per il padre, gli insulti e la vergogna per la propria omosessualità e il distacco definitivo dai parenti, da Reims e dalla sua classe sociale.
Per affermare una nuova identità, Eribon si trasferisce a Parigi, dove conosce Bourdieu e Foucault, intervista Claude Lévi-Strauss, scrive articoli per riviste e giornali, saggi tra cui “Riflessioni sulla questione gay”, intraprende la carriera accademica e comincia a godere di una discreta notorietà. Sono gli anni in cui prevale una forma di vergogna per l’umiltà delle sue origini, come fosse qualcosa da nascondere nel nuovo contesto intellettuale e borghese nel quale è ormai introdotto. Vergogna mista ad un’istintiva volontà di separarsi del tutto da un ambiente omofobo, limitato e violento e di esistere in un altro mondo, diverso da quello cui il destino sociale l’avrebbe condannato. Un mondo in cui è possibile far emergere la propria soggettività gay e affermare il gusto per l’arte e la letteratura.
E’ un ritorno dell’autore a se stesso, una riflessione per definirsi, per ripercorrere le traiettorie e le contraddizioni del proprio percorso, le scelte spesso dolorose, gli sforzi per inventare e ricreare un sé nuovo e migliore. Siamo lontani da qualsiasi autocelebrazione o compiacimento, non c’è alcuna esibizione narcisistica – come accade in tanta autofiction così in voga negli ultimi anni con risultati spesso discutibili -, ma piuttosto la realizzazione di un’opera stimolante, fortemente “rivolta agli altri”, nata dall’esigenza impellente di mostrare che altre vite sono realizzabili e che ci possono essere prospettive alternative a quelle che una società opprimente tende ad importi (“la terribile ingiustizia di una distribuzione ineguale di opportunità e di possibilità”).
E il ritorno alle origini, allo stesso tempo, poiché il processo di emancipazione aveva comportato un taglio netto col passato (“per inventarmi mi occorreva, prima di tutto, dissociarmi”), cicatrizza le ferite e produce una ricomposizione, una sintesi e ha un effetto terapeutico. La vergogna può trasformarsi in orgoglio:
“… questo viaggio, o piuttosto questo processo di ritorno, mi ha permesso di ritrovare questa “regione di me stesso”, come avrebbe detto Genet, da cui avevo così tanto cercato di evadere. Uno spazio sociale che avevo allontanato e uno spazio mentale in opposizione al quale mi ero ricostruito, ma che continuava ugualmente a costituire una parte essenziale di me. Così sono andato a trovare mia madre ed è stato l’inizio di una riconciliazione con lei. O, più esattamente, di una riconciliazione con me stesso, con tutta una parte di me che avevo rifiutato, respinto, rinnegato.”

Ma “Ritorno a Reims” non è solo un lavoro di autoanalisi, la testimonianza di un figlio di operai in un determinato contesto sociale e culturale. L’esperienza personale è il pretesto per proporre un’analisi più ampia sull’evoluzione della società e della politica francesi.
Uno dei pregi del libro sta proprio in quest’intrecciarsi di storie intime e commoventi con stimolanti analisi teoriche. Uno degli obiettivi di Eribon, infatti, è quello di riportare alla ribalta una riflessione sulla classe operaia, di cui più nulla si dice nel discorso pubblico e politico, vittima di molteplici forme di violenza, tradita dal Partito Comunista e sempre più attratta dall’estrema destra.
Egli stesso si rende conto, nel dialogo con la madre, di questa disattenzione anche nel proprio lavoro, di aver scritto molto fino a quel momento delle questioni relative all’omosessualità (del “verdetto sessuale”) e per niente dei rapporti di classe (della “vergogna sociale”); di aver cancellato ogni riferimento alle classi popolari, agli stili di vita e di pensiero della classe operaia.
E in quegli anni, i genitori, da comunisti convinti sono diventati elettori del Fronte Nazionale; i fratelli, che non hanno conosciuto alcun successo, lo sono sempre stati dal raggiungimento della maggiore età. Quella che un tempo era un’affiliazione “naturale” delle classi popolari al Partito Comunista si è tramutata negli anni ’80 in un progressivo spostamento verso l’estrema destra, a partire, sostiene Eribon, dalle elezioni del 1981 che vedono l’affermazione dei Socialisti e la partecipazione al governo del PCF. A suo parere, l’abbandono delle politiche di classe da parte dei partiti di sinistra a favore di politiche neoliberali e la disattenzione per le questioni economiche e sociali che colpiscono i lavoratori (disoccupazione, bassi salari, condizioni di lavoro precarie, minori tutele, disuguaglianze crescenti) ne hanno determinato la progressiva disaffezione. L’abbandono delle classi popolari da parte della sinistra ha avuto l’effetto di lasciare uno spazio vacante che il Fronte Nazionale è riuscito ad occupare con un inganno, ovvero valorizzando il francese (contro lo straniero) piuttosto che l’operaio (contro la classe dominante capitalista).
L’intreccio di introspezione autobiografica e di critica sociale, di personale e di politico, non può non rimandare ad un’altra voce fondamentale della letteratura contemporanea francese, sia per tratti biografici, che per tematiche e stile, ovvero ad Annie Ernaux, con la quale Eribon condivide in primo luogo le origini operaie. Entrambi hanno scritto ampiamente della loro formazione, degli sforzi per migliorare la propria condizione sociale e, nel contempo, dello spaesamento e dei sensi di colpa per il tradimento delle proprie radici. Sia Eribon che Ernaux (in particolare ne “La vergogna”, “Il posto”, “Gli anni”) hanno analizzato il contesto storico e sociale a partire dalla propria esperienza; ambedue affrontano riflessioni teoriche e sociologiche con uno stile sobrio, essenziale, rigoroso, rendendo in tal modo i propri ragionamenti alla portata di ogni tipo di lettore.

Un altro scrittore cui Eribon dichiara in “Ritorno a Reims” di far riferimento è James Baldwin (1924-1987), che, da nero e omosessuale, ha raccontato il razzismo e l’omofobia della società americana. Uno dei numerosi punti in comune è l’odio nei confronti del padre, incarnazione di un mondo da cui entrambi hanno preso le distanze, spiegato non tanto dal punto di vista psicologico, bensì storico e sociale. Eribon cita Baldwin più volte per rappresentare la similitudine delle loro esperienze, in questo caso a proposito della reazione al lutto:
“Avevo detto a mia madre che non lo volevo vedere perché lo odiavo. Ma questo non era vero. Era solo che lo avevo odiato. Non volevo vederlo come un relitto: non era un relitto quello che avevo odiato.”
O ancora:
“Credo che una delle ragioni per cui le persone rimangono aggrappate così tenacemente ai loro odi sia perché intuiscono che, una volta sparito l’odio, saranno costrette ad affrontare il dolore.”
Ma “Ritorno a Reims” è un’opera estremamente ricca e complessa, che riprende – rinnovandole e attualizzandole – molte tematiche della letteratura del secolo scorso (l’identità sessuale, le dinamiche sociali, la memoria, la critica alle classi dominanti) e che ha significativi legami con la tradizione naturalista e realista dell’Ottocento (la povertà, l’ingiustizia sociale). D’altro lato, essendo anche un saggio sociologico e politico, il libro dialoga col pensiero critico in particolare di Sartre e Bourdieu.
E il lettore non potrà non rallegrarsi del valore complessivo di un libro toccante nei suoi capitoli più “intimi” e letterari alternati a riflessioni politiche e sociologiche stimolanti e profonde.
Di Didier Eribon L’Orma Editore ha recentemente pubblicato “Vita, vecchiaia e morte di una donna del popolo” con la traduzione sempre di Annalisa Romani.
Gigi Agnano