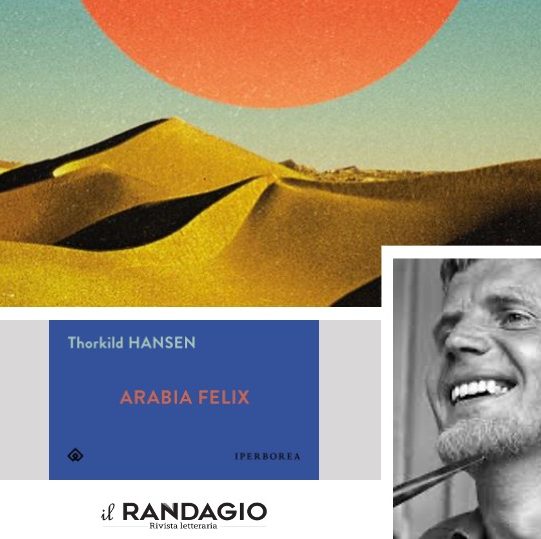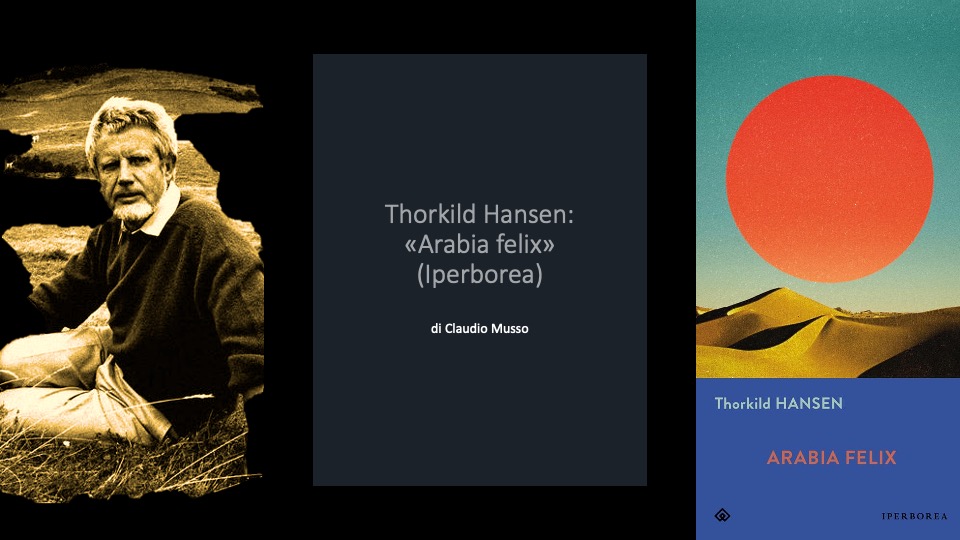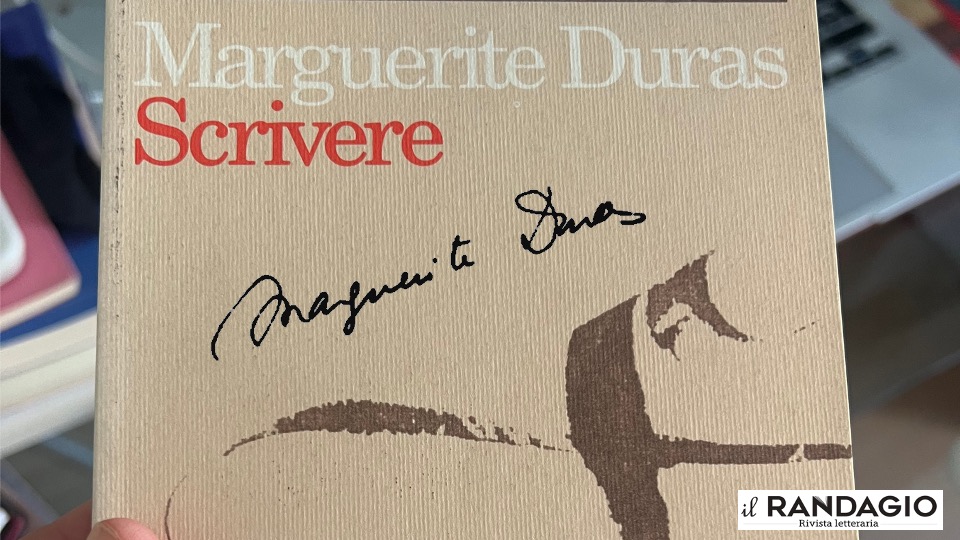E un bambino li condurrà – su Non è qui, di Davide Morganti
Hans Christian Andersen insegna che è sempre un bambino a gridare che il re è nudo. Analogamente, forse soltanto un bambino può credere davvero nelle meraviglie e nei miracoli che la religione e gli scritti sacri promettono essere autentici. Infatti, nonostante molte tiritere teologiche, di rado gli adulti si abbandonano alla fede con la disarmata ingenuità che essa richiede. L’adulto è scettico dinanzi all’impossibile, il bambino no. Così in Non è qui – pubblicato questo mese da Editoriale Scientifica – Davide Morganti si approccia ai temi di Dio e della Resurrezione con uno sguardo infantile, il proprio, rimembrando le sue perplessità al riguardo ma anche i suoi incanti per qualcosa che può anche essere possibile e dunque vero.
Non è qui è un memoir sulla fede che si legge come un romanzo o forse, meglio, è una lunga divagazione intorno ai temi di Dio e della memoria che si svolge però in forma prettamente narrativa. Il titolo proviene dal Vangelo di Luca: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato.” O dal Vangelo di Matteo, citato nell’epigrafe: “Ma l’angelo disse alle donne: ‘Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove è deposto.’” Dunque il titolo si riferisce al cadavere di Cristo, che il bambino protagonista, Davide, animato da un “desiderio crudele di Dio”, sa essere veramente risuscitato e quindi altrove, non nella tomba in cui gli adulti lo cercano, loro che stentano a credere nell’impossibile. Ma quindi la morte cos’è? E la vita? Dove finirà ognuno di noi dopo la morte? “Dove ci metteremo tutti?” si chiede il bambino. “Saremo come meduse nel mare?” E ancora: cos’è l’aldilà? È forse una “discarica celeste”?
Davide Morganti è un irregolare delle lettere italiane. In un suo libro precedente, l’ultimo volume del mastodontico Atlante della fine del mondo (Marotta&Cafiero, 2022), faceva scrivere a Emanuela Cocco – ma era probabilmente lui stesso a scrivere – che “Morganti si faceva volere bene ma era anche un presuntuoso […], la buona volontà non gli è mai mancata ma quel carattere difficile gli ha bruciato mille occasioni e la sua scrittura ne risente di questo fallimento”, come a dire che nei suoi libri c’è sempre qualcosa che si ribella non tanto allo scrivere quanto al saper scrivere, ossia che cerca non l’esattezza dello stile bensì la velocità dell’istinto che si fa parola e quindi narrazione, racconto.

Così negli anni Morganti si è andato forgiando uno stile a tratti anche orale che risente di un Céline forse mal digerito ma che raggiunge pure notevoli momenti di pathos e di esaltazione. Ha saputo giocare con la forma del romanzo, come in Il cadavere di Nino Sciarra non è ancora stato trovato (Wojtek, 2019), che potrebbe essere definito l’impossibile romanzo di un critico impazzito, o nel già citato Atlante della fine del mondo, che visita ogni Paese al mondo in compagnia dell’impacciato picaro moderno Casimiro Boboski, oppure in un romanzo che ha non poche cose in comune con Non è qui e che fu molto amato da un giovanissimo Roberto Saviano, il quale scrisse che aveva “il sapore di un classico”, cioè Moremò (Avagliano, 2006), un libro colorito e spericolato in cui il protagonista è a sua volta preda di ossessioni religiose, come il Davide di Non è qui.
Non è qui è un romanzo che vive di alti e bassi, come sempre nella scrittura di Morganti. Ci si diverte spesso, talora ci si commuove, a tratti si imparano cose nuove. La lettura offre sempre un punto di vista inedito e originale sulla fede e di conseguenza su Dio, su cos’è Dio per noi mortali, per noi che siamo ossessionati dalla morte e che non possiamo credere che essa riguardi anche Dio, o Cristo, o persino noi stessi, noi che dunque abbiamo inventato i miracoli dell’aldilà e della vita eterna per nascondere la certezza paradossale di dover abitare il mondo anche da morti. Però i bambini lo sanno. E lo scrittore, se è tale, sa di dover tornare bambino per raccontarlo, per raffrontarsi a se stesso e a Dio, specchio dell’impossibile, un impossibile che soltanto un bambino, il bambino che è stato Davide Morganti e che anche noi siamo stati, può rendere credibile e infine reale.
Di conseguenza il ricordo (parola che contiene la sillaba cor ed è quindi un ritorno alle intermittenze del cuore) diventa non soltanto racconto ma anche memoria e a tratti autobiografia, ed è qui che abbiamo le pagine più felici del libro, quando Morganti scrive, per esempio, di Ciro il Pellicano, fortissimo a pallone ma destinato a morire di overdose, o di altri suoi amici mai dimenticati, o della morte di mastro-don Gesualdo nel romanzo di Verga, o della signora Anna, una barbona miope con gli occhiali doppi attaccati con lo scotch, “sempre con molte buste della spesa rigonfie non so di cosa, la bocca incavata per i pochi denti rimasti, si diceva fosse stata una prostituta durante la guerra e che andasse in giro con i marinai americani, a me pareva strano immaginarla visto come era brutta, vecchia, malandata, di lei ricordo la puzza e la buona educazione, parlava a bassa voce, mia mamma per lei aveva piatto, bicchiere e posate a parte, le dava da mangiare e anche da dormire certe volte, la notte io sentivo la sua puzza ma nessuno di noi si lamentava, era normale fare queste cose, la signora Anna era come se non ti guardasse mai e parlava un italiano dolce, la voce affabile, ogni tanto spiccava qualche parola inglese, che mia mamma…”
Il periodo della signora Anna va avanti per una pagina intera ed è esemplificativo di ciò che Morganti ha fatto con il proprio stile e con la lingua, spalancando ogni proposizione alla successiva, come in una matrioska russa, evitando però strutture composite o arzigogolate e rifacendosi all’oralità piuttosto che alla complessità. I grandi novecentisti ci insegnano che uno stile proprio si paga caro, che può essere a un tempo un limite e una forza, e così è per Davide Morganti, il quale in Non è qui affabula come solo un bambino sa fare, precipitandosi lungo le frasi con passione e meraviglia, nell’indomabilità stilistica e emozionale del ricordo, che da sempre – in letteratura e nella vita – ci insegna che siamo anche ciò che siamo stati: il bambino che ci osserva, il bambino che ci guida.
“E un bambino li condurrà” dice il profeta Isaia, nella Bibbia ebraica. In questi tempi neri forse dovremmo davvero ritornare alle nostre infanzie e ai testi sacri, alla meraviglia di poter immaginare Dio.
Edoardo Pisani*

*Edoardo Pisani è nato a Gorizia nel 1988. Ha pubblicato i romanzi E ogni anima su questa terra (Finalista premio Berto, finalista premio Flaiano under 35) e Al mondo prossimo venturo, entrambi con Castelvecchi. Sempre con Castelvecchi ha pubblicato un libro su Rimbaud, E libera sia la tua sventura, Arthur Rimbaud! Nel 2026 Marsilio pubblicherà il suo terzo romanzo.