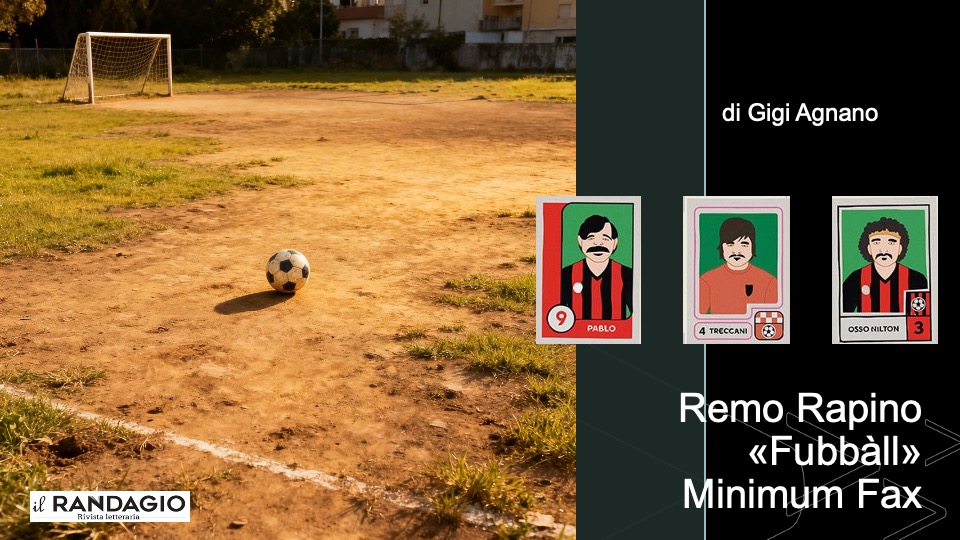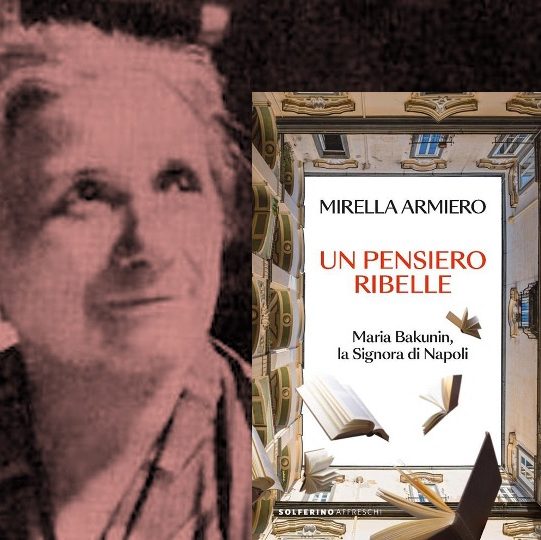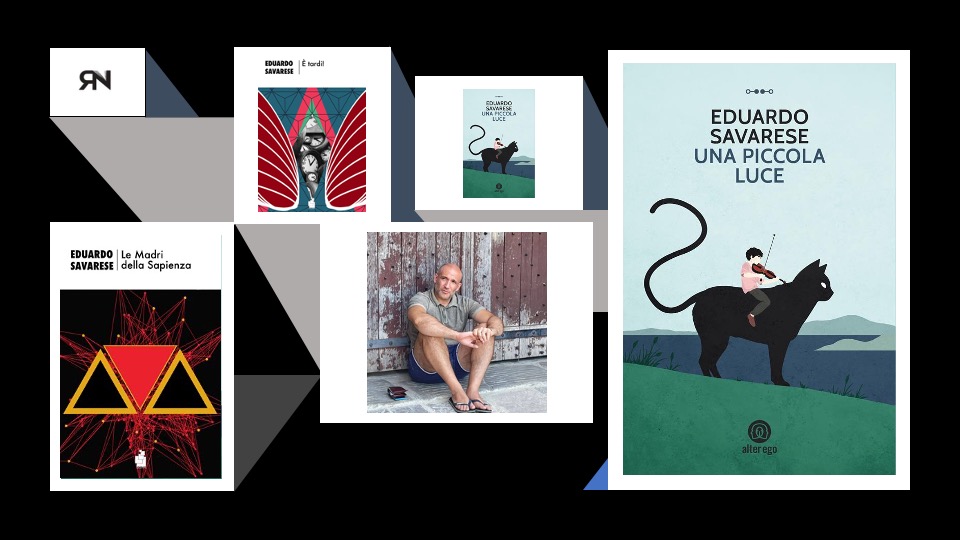Sono qui davanti a una pagina bianca di un file di Word. Scriverò? E con un click il mio messaggio raggiungerà alcuni amici. Il problema è che non riesco a scrivere, e penso… forse così si sarà sentito Lord Chandos quando cercava di descrivere il suo stato d’animo a Francis Bacon: non riuscire a trovare le parole giuste per raccontare il mondo. Tutto sembra essere diventato banale e inutile; non abbiamo il diritto di esprimere giudizi su di esso. Ci siamo persi in una intricatissima matassa di causa ed effetto e il bandolo che ci serviva per vivere in modo razionale si è spezzato.

Sono immobile, incapace di pensare e di raccontare ciò che ho “vissuto” nelle lunghe ore trascorse con L’assassinio del commendatore: un ometto di appena sessanta centimetri dipinto da Amada Tomohiko, seguace della pittura Nihonga e vissuto a Vienna durante il nazismo, una città non paragonabile a nessun’altra. Suo figlio Masahico darà in affitto la casa di suo padre al narratore senza nome, appena divorziato da Yuzu. Il narratore conoscerà Menshiki, che ha acquistato casa nelle vicinanze per osservare da lontano Akikawa Marie, la ragazza che vive con Akikawa Yoshimoto: il padre naturale o quello putativo? Akikawa Sokho, sorella di Yoshimoto, si prende cura di Marie e diventerà l’amante di Menshiki.
Tutti incontri casuali, apparentemente slegati, e tutti riconducibili al narratore che osserva con attenzione e minuzia. È lui che, in ogni situazione, in ogni piccolo accadimento, non si ferma alla superficie delle cose e ne cerca relazioni e connessioni: niente gli sfugge. La meraviglia — quel caso eccezionale per cui un pittore trova alloggio nella casa del grande Amada Tomohiko — e il rievocare la Vienna degli anni bui del nazismo e la pittura Nihonga, realizzata con la tecnica e i materiali della tradizione giapponese, sembrano farci cogliere, senza troppi giri di parole, che il nazismo non aveva nulla a che fare con Vienna, unica nella sua bellezza ed eleganza; e che la pittura Nihonga era espressione autentica delle proprie radici, lontanissima dal nazionalismo più becero.
L’artista-narratore è, come tutti gli artisti, attento a percepire ogni segno, ogni strano suono che gli giunge nel silenzio notturno della casa. Una campanella tintinna, ma non si sa da dove provenga, fino a quando si scopre una buca nel bosco: era poggiata lì, in fondo. Una grande buca e una campanella. Una campanella che ha fatto scoperchiare una buca. Ma quella buca era giusto scoperchiarla? Non sarebbe stato meglio rivivere tutto in modo nuovo?
Cosa potrebbe essere questo richiamo che viene da così lontano? Una campanella in una buca, e il suo suono che deve ricordarci qualcosa. Quasi due secoli fa, all’inizio dell’era Meiji (1868-1912), fu imposta l’occidentalizzazione del Giappone come politica governativa. Il Paese doveva allinearsi all’Occidente in tutti i campi: scientifico, letterario, filosofico, artistico. Doveva dimenticare se stesso? La pittura a olio occidentale, yōga, sostituì quella millenaria del Nihonga, che tende alla semplificazione e alla stilizzazione, elimina il superfluo e riduce gli elementi naturali alla loro essenza, usando pigmenti minerali applicati su carta washi o su seta, sempre materie naturali. Era come se tutto il passato andasse perduto invece di aprire a nuove strade e a nuove interpretazioni.
Per caso i miei occhi si posano su una pagina del romanzo:
“No, signore, è troppo rischioso prendere per lei una strada riservata alle metafore. Se una persona vivente vi si addentra, basta sbagliare percorso una volta e rischia di finire in un mondo assurdo. Ci sono doppie metafore nascoste ovunque… si acquattano nelle tenebre, creature pericolosissime. Lei dovrebbe portare con sé qualcosa per farsi luce… incontrerà un fiume. È un fiume metaforico, ma l’acqua è reale. E al di là del fiume c’è un mondo che fluttua al vento della correlazione, un mondo che si estende all’infinito.”
È il nuovo mondo, il mondo delle possibilità: ha perso il suo centro di gravità permanente, è fluido e interconnesso, e si apre a direzioni imprevedibili. Cultura occidentale e cultura orientale si incontrano, come già Goethe, nel suo Divano Occidentale-Orientale, aveva intuito: un’immagine capace di ridurre ogni molteplicità a un principio unificatore.
La scrittura di Murakami è come una musica: si dissolve e si ricompone in una nuova armonia, in un andamento lento, costante e pieno di tensione. Libera la fantasia, le associazioni. È come un dipinto: lo leggi e lo interpreti ogni volta in modo diverso. È il doppio senso dell’arte: aiuta a conoscere la realtà, a riflettere, a capirsi — e rende ancora più labili i confini tra ciò che è reale e ciò che non lo è.

Breve biografia
Mi chiedevo come leggere la vita di Murakami. L’opera artistica riflette sempre l’essenza di ciò che si è. Se penso ai suoi romanzi immagino vite parallele, melodie di sax mentre un gatto cammina come un equilibrista sul cornicione di una casa al confine tra realtà e irrealtà. Il mondo in cui entrò — e che fece suo — gli apparteneva già: i suoi genitori erano insegnanti di letteratura giapponese. Artista lo era da sempre; pensava solo di amare di più la musica jazz. L’unica musica che poté poi trasferire nella sua scrittura, così creativa ed estemporanea, capace di inventare nuove melodie.
Prima di diventare scrittore, Murakami gestì con la moglie, dal 1974 al 1981, un jazz bar, il Peter Cat, nella città di Kokubunji, alla periferia occidentale di Tokyo. Restava in piedi fino a tarda notte e, dopo la musica raccoglieva bicchieri vuoti come fossero tracce di vite, note musicali rimaste in sospeso. Alle due del mattino la dimensione del tempo cambia: siamo immersi nel cuore buio della notte e non percepiamo nel sonno l’alba che verrà.
Murakami non si muove negli spazi letterari che crea: sembra piuttosto aggirarsi tra essi, scrutando ogni angolo, varcando silenzi, leggendo negli oggetti sparsi, nei mondi specchiati, nelle lune doppie e negli animali che osservano l’uomo come se sapessero qualcosa che lui ha dimenticato. Dai suoi romanzi si esce come da un sogno che ci lascia storditi e incapaci di spiegare.
Visse a lungo all’estero; ritornò in Giappone dopo il terremoto di Kobee l’attentato alla metropolitana. Era il 1995. Parve che un’altra porta si fosse aperta. Da lì nacquero libri che ascoltano il dolore invece di descriverlo.
Murakami, nato a Kobe nel 1949, vive oggi in un luogo che sembra una stanza sospesa tra le epoche. Corre ogni mattina, traduce Fitzgerald e Carver — autori a lui consoni —, colleziona vinili che sembrano avere un proprio respiro. Qualche volta, dicono, un gatto appare, lo guarda e se ne va. Forse è lo stesso di quando era bambino. Forse no.
Murakami non ha mai avuto bisogno di una risposta per continuare a scrivere. Nei suoi libri si entra come in un crepuscolo: non ci sono trame e, se ci sono, rimangono sospese. Non cercano limiti. Viviamo il suo racconto senza imboccare la strada della metafora.
Maurizia Maiano*

*Maurizia Maiano: Sono nata nella seconda metà del secolo scorso e appartengo al Sud di questa bellissima Italia, ad una cittadina sul Golfo di Squillace, Catanzaro Lido. Ho frequentato una scuola cattolica e poi il Liceo Classico Galluppi che ha ospitato Luigi Settembrini, che aveva vinto la cattedra di eloquenza, fu poeta e scrittore, liberale e patriota. Ho studiato alla Sapienza di Roma Lingua e letteratura tedesca. Ho soggiornato per due anni in Austria dove abitavo tra Krems sul Danubio e Vienna, grazie a una borsa di studio del Ministero degli Esteri per lo svolgimento della mia tesi di laurea su Hermann Bahr e la fin de siècle a Vienna. Dopo la laurea ritorno in Calabria ed inizio ad insegnare nei licei linguistici, prima quello privato a Vibo Valentia e poi quelli statali. La Scuola è stato il mio luogo ideale, ho realizzato progetti Socrates, Comenius e partecipato ad Erasmus. Ho seguito nel 2023 il corso di Geopolitica della scuola di Limes diretta da Lucio Caracciolo. Leggo e, se mi sento ispirata e il libro mi parla, cerco di raccogliere i miei pensieri e raccontarli.