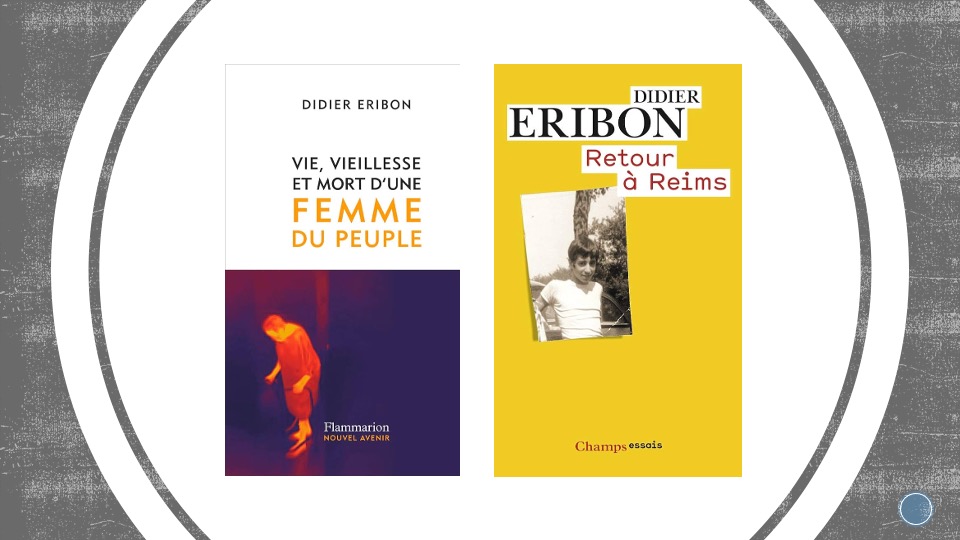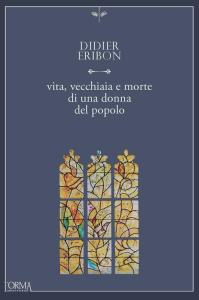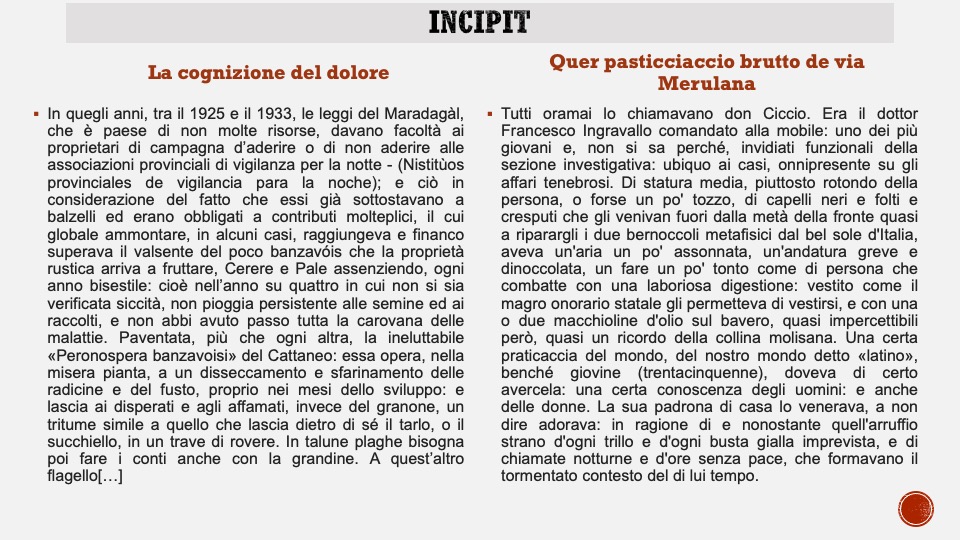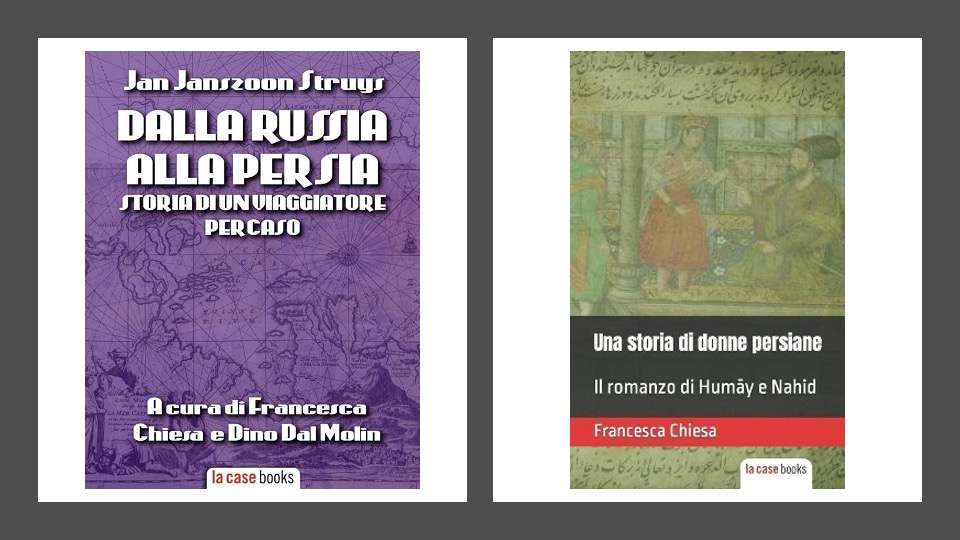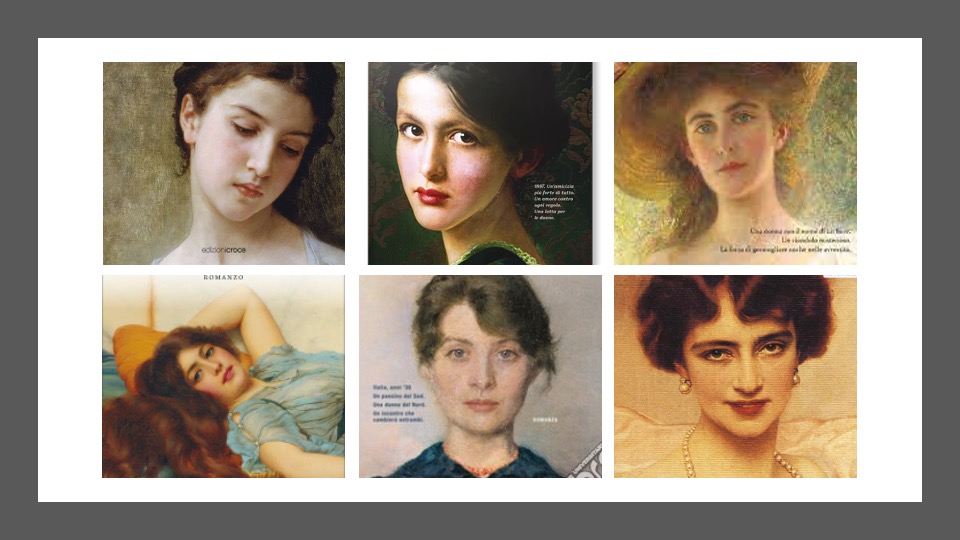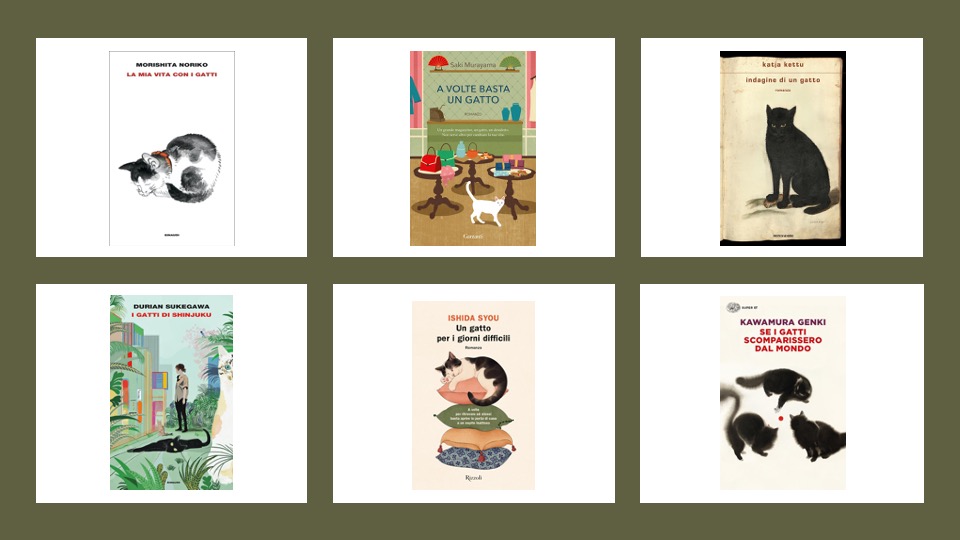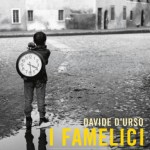Fin dai suoi albori, il teatro è sempre stato un mezzo efficace sia per criticare il potere, sia per raffigurare le variegate sfaccettature dell’umanità, sia per generare una riflessione sui temi trattati in chi assiste alla rappresentazione. Il contributo che segue è tratto da un articolo che ho pubblicato in Francia tempo fa,[1] ed esamina due figure femminili create a circa duemila anni di distanza, che mostrano un sorprendente numero di somiglianze, nonostante la diversità di fondo faccia dell’una il simbolo dell’amore materno e dell’altra della follia infanticida. Sebbene siano state create in epoche distanti e in paesi diversi tra loro, il minimo comune denominatore è lo stesso, e si prestano bene per rappresentare l’infelice attualità della condizione della donna, ma anche degli stranieri, vengano essi da altri paesi o da altre classi sociali. Nel caso di specie, queste due donne hanno caratteristiche comuni e speculari che le rendono estremamente vicine e al tempo stesso ne fanno due eroine: la prima positiva e la seconda negativa. Mi riferisco a Filumena Marturano, protagonista dell’omonima commedia di Eduardo De Filippo, e Medea, l’eroina creata dal poeta tragico greco Euripide. Filumena Marturano presenta molti elementi riconducibili all’impianto tragico di Medea, e attraverso la lettura parallela dei due testi, cercherò di evidenziare quegli aspetti che, per la loro universalità, permettono di collocare Filumena tra le figure mitiche del teatro italiano, facendone un mito della contemporaneità, così come Medea viene considerata un mito della classicità.
Filumena Marturano fu scritta nel 1946, e fa parte dalla Cantata dei giorni dispari. Il testo fu scritto per la sorella Titina che si era sentita sottovalutata nelle commedie precedenti. È l’unica commedia che reca nel titolo il nome di una donna ed è la prima commedia che esplora l’universo psicologico femminile.
Medea fu scritta nel 431 a.C. per le Grandi Dionisie, i festeggiamenti dedicati a Dioniso che si svolgevano ad Atene. Medea è nativa della Colchide, una regione non greca al confine con il Mar Nero, l’odierna Georgia, ed è la figlia del re Eete e la nipote di Elio, o dio Sole. Compare sulla scena quando Giasone arriva con gli Argonauti ad Aia, la capitale della Colchide, per impadronirsi del Vello d’oro. Medea s’innamora di Giasone, e fa uso delle sue arti magiche per superare gli ostacoli che Eete frappone a Giasone per impedirgli di completare la missione. Quando il Vello d’oro viene conquistato, Medea tradisce il padre, e scappa con Giasone. I fuggitivi sono accolti da Creonte, il re di Corinto, dove si stabiliscono ed hanno due figli. In seguito, Giasone sposa segretamente Glauce, la figlia di Creonte, scatenando la vendetta omicida di Medea che uccide i figli per impedire che siano esiliati, e fugge ad Atene. La tragedia si svolge a Corinto. [2]

Tra tutte le commedie di Eduardo, Filumena Marturano è quella che maggiormente presenta i tratti della tragedia greca.
Partendo dalla didascalia iniziale di ben quattro pagine, colpisce la disposizione dei personaggi:
[…] In piedi, quasi sulla soglia della camera da letto, le braccia conserte, in atto di sfida, sta Filumena Marturno. Indossa una candida e lunga camicia da notte. Capelli in disordine e ravviati in fretta. Piedi nudi nelle pantofole scendiletto.
[…] Nell’angolo opposto, precisamente in prima quinta a destra, Domenico Soriano affronta la donna con la decisa volontà di colui il quale non vede limiti né ostacoli, pur di far trionfare la sua sacrosanta ragione, pur di spezzare l’infamia e mettere a nudo, di fronte al mondo, la bassezza con cui fu possibile ingannarlo.
[…] A sinistra della stanza, nell’angolo, quasi presso il terrazzo si scorge, in piedi, la mite ed umile figura di donna Rosalia Solimene. Ha settantacinque anni. Il colore dei suoi capelli è incerto.: più deciso per il bianco che per il grigio. Indossa un vestito scuro, «tinta unita». Un po’ curva, ma ancora piena di vitalità.
[…] Nel quarto angolo della stanza si scorge un altro personaggio: Alfredo Amoroso. È un simpatico uomo sui sessant’anni, di struttura solida, nerboruto, vigoroso. Dai compagni gli fu appioppato il nomignolo di «’O cucchieriello». Era bravo, infatti, come guidatore di cavalli, per cui fu assunto da Domenico, ed al suo fianco rimase in seguito, ricoprendo il ruolo di uomo di fatica, capro espiatorio, ruffiano, amico.
La scena d’apertura di Filumena Marturano rispetta i canoni della tragedia greca, con i quattro personaggi disposti sul palcoscenico come maschere immobili.
Anche le aperture per le continue entrate ed uscite dei personaggi, possono essere paragonate a quelle della tragedia: come «Euripide ha disposto le cose in modo che si abbia un continuo andare e venire»,[3] così Eduardo usa le aperture per creare un continuo andirivieni dei personaggi.
In Medea i personaggi collaterali sono la Nutrice e il Pedagogo a cui corrispondono la balia Rosalia e l’attendente Alfredo.
Infine, sempre secondo i canoni della tragedia, in Filumena il Coro viene rappresentato dal pubblico, come Eduardo stesso ha spiegato per tutte le sue commedie.[4] Analogamente, in Medea il coro funge da interlocutore alla protagonista che si rivolge alle donne di Corinto.
Un’altra somiglianza sono i monologhi con cui si esprimono le due eroine, che sono cruciali, sia per lo sviluppo della storia, che per la espressione delle idee che gli autori fanno per bocca delle due donne. La forma più alta di questo meccanismo drammatico è data certamente dal «Grande Monologo» di Medea che ha il suo corrispettivo nel «monologo della Madonna d’ ’e rrose» di Filumena.
Osserviamo come anche le figure maschili presentino straordinarie affinità: sia Domenico che Giasone sono dei perdenti: il primo dovrà accettare la paternità dei figli non suoi, il secondo invece dovrà rinunciare alla paternità, ma entrambi soccomberanno alla «potenza» delle rispettive compagne su cui non potranno esercitare il loro «potere».[5]Inoltre, entrambi mostrano la loro insensibilità e pochezza riducendo il rapporto coniugale ad una questione meramente economica, ignorando completamente l’aspetto etico e morale sottostante che è alla base dell’agire delle due donne.
GIASONE […] Ad ogni modo, se vuoi ricevere dalle mie sostanze un aiuto per i figli e per te in vista dell’esilio, dimmelo: io sono disposto a dare con mano generosa e ad inviare dei contrassegni per gli ospiti, che ti tratteranno bene. Se non accetti questa offerta, stolta sarai, o donna. Cessa dall’ira e otterrai migliori vantaggi.
MEDEA Non ricorrerò ai tuoi ospiti, ne accetterò qualcosa da te, e tu non offrire nemmeno: dono di un uomo infame non ha utilità (vv-610-619)
DOMENICO […] ’E denare! E nun te l’avarrìa date? Secondo te, Domenico Soriano, figlio a Raimondo Soriano (borioso) uno dei più importanti e seri dolcieri di Napoli, non avarrìa penzato a te mettere na casa, e a nun te fà avé cchiù bisogno ’e nisciuno?
FILUMENA […] Ma statte zitto! Ma è possibile ca vuiate uommene nun capite maie niente?… Qua’ denare, Dummi’? Astipatille cu bona salute ’e denare. È n’ata cosa che voglio ’a te… e m’ ’a daie! Tengo tre figlie, Dummì! (I- p. 540)
Entrambi poi, chiamano in aiuto il soprannaturale, ben sapendo di essere nel torto per aver tradito le rispettive compagne:
GIASONE Allora io chiamo a testimoni gli dèi che voglio aiutare in ogni modo te e i figli, ma tu non gradisci questi benefici, anzi per orgoglio respingi gli amici. Così soffrirai di più (vv-620-624)
DOMENICO Ah, te credive d’accuncià a faccenna, ‘e te mettere a posto cu ‘a cuscienza, ‘e te salvà d’ ‘o peccato, purtanno dint’ ‘a casa mia tre estranei? … S’hann’a nzerrà l’uocchie mieie! Nun ce mettarranno pede ccà dinto! (Solenne) Ncopp’ all’anema ‘e pàtemo…(I – p. 552)
Ho detto all’inizio che vorrei proporre per Filumena la caratteristica di Mito. Il termine deriva dal greco mythos che significa racconto. Il requisito del mito secondo Richard Buxton è l’essere «una storia tratta dalla tradizione, trasmessa da generazione a generazione, con un forte significato sociale». È generalmente riconosciuta l’importanza universale del mito che riesce a generare degli «archetipi» di riferimento».[6]
Il mito per i greci si rifaceva a fatti realmente accaduti, esponendoli in forma narrativa, e anche Eduardo dichiarò che fu ispirato a scrivere Filumena Marturano da un fatto di cronaca. In entrambi i testi una «finzione» descrive la realtà generando un archetipo: quello della madre e moglie devota, o della madre infanticida.
Vorrei riflettere sul fatto che Euripide si rivolge al pubblico ateniese del quinto secolo a. C. attraverso Medea che denuncia la discriminazione subita dalle donne a causa di un impianto legislativo e culturale radicato. In particolare, condanna il trattamento discriminatorio subito dalle donne e da chi non è cittadino ateniese. Eduardo fa esattamente la stessa cosa: denuncia l’ingiustizia derivante dalla mancanza di una legge, sulla legittimità dei figli nati fuori dal matrimonio, e rivaluta la figura di una prostituta altrimenti disprezzata dalla società.[7]
Proseguendo nel nostro cammino parallelo tra le due opere, analizziamo i tratti che accomunano le due donne. Innanzi tutto, sono spinte dal desiderio di vendetta verso l’uomo che prima le ha sedotte e poi le ha tradite. Ma a ben guardare, la vendetta non è causata da motivi di gelosia. Medea, a costo di arrecare danno prima di tutto a se stessa, vuole punire la mancanza di fedeltà di Giasone che aveva un obbligo giuridico da rispettare. Vediamo come lamenta Medea la sua posizione di oltraggiata:
MEDEA […] solo questo, dunque, vorrei ottenere da te, se riuscirò a trovare una via, una possibilità per far pagare allo sposo il fio di questi mali: che tu taccia. Una donna, per il resto, è piena di paura e imbelle di fronte alla forza e alla vista di un’arma, ma quando le accade di subire ingiustizia riguardo al suo letto, non vi è altro animo più sanguinario. (vv. 258-266)
Lo stesso discorso vale per Filumena. La sua vendetta, sopita e coltivata per venticinque anni, mira al riconoscimento dei suoi diritti e a punire l’uomo che, con la sua ‘disattenzione’ vorrebbe negarle quanto le spetta. Sembra di sentire Filumena, mentre svela il suo piano:
FILUMENA (ironica) Quanto me faie ridere! E quanto me faie pena! Ma che me ne mporta ’e te, d’ ’a figlióla che t’ha fatto perdere ’a capa, ’e tutto chello ca me dice? Ma tu te cride ovèro ca io ll’aggio fatto pe te? Ma io nun te curo, nun t’aggio maie curato. Na femmena comm’a me, ll’hê ditto tu e m’ ’o stai dicenno ’a vinticinc’anne, se fa ’e cunte. Me sierve… Tu me sierve! Tu te credive ca doppo vinticinc’anne ch’aggiu fatto ’a vaiassa vicino a te, me ne ievo accussì, cu na mano nnanze e n’ata areto? (I, 540-541)
Ma Filumena mostra tutto il suo coraggio nell’accettare la sconfitta quando si rende conto che il suo piano è fallito e che la legge le dà torto. E in effetti è soltanto un’apparente coincidenza il nomen omen che caratterizza le due figure: Medea, «colei che considera, valuta, ordisce», e Filumena, nome di origine greca risultante dalla combinazione di philos, amico e menos, forza, quindi amante della forza, e quindi donna forte.
MEDEA […] Manderò a Giasone uno dei miei servitori e gli chiederò di venire al mio cospetto; a lui, quando sarà giunto, rivolgerò dolci parole, che io concordo con lui e che bene fa lui ad avere le nozze regale, conseguite grazie al tradimento nei miei confronti, e che tutto questo va bene, ed è stato ben deciso. E quanto ai figli miei, chiederò che restino, non già perché io voglia lasciare ai miei nemici i miei figli in una terra ostile, esposti all’insulto, ma perché intendo uccider con l’inganno la figlia del re (vv. 774-784)
FILUMENA […] E io manco! (A Domenico) Io nemmeno te voglio! (A Nocella) Avvoca’, procedete. Nun ’o voglio nemmeno io. Nun è ovèro ca stevo mpunt’ ’e morte. Vulevo fà na truffa! Me vulevo arrubbà nu cugnome! Ma cunuscevo sulo ’a legge mia: chella legge ca fa ridere, no chella ca fa chiagnere! (II, 575)
In secondo luogo, entrambe le eroine sono delle straniere, e quindi delle emarginate. L’una proviene da una regione considerata barbarica perché non greca, e «collocata ai limiti della civiltà greca»;[8] l’altra proviene da una classe sociale, il sottoproletariato, considerata ugualmente barbarica dalla società borghese benpensante. È uno degli elementi più rilevanti e direi la chiave di lettura di queste figure affascinanti. La estraneità le rende pericolose, perché agiscono fuori dai parametri femminili, esercitano un potere maschile, e reclamano i loro diritti, indipendentemente dalla estrazione sociale o provenienza. L’estraneità genera sospetto e repulsione allo stesso tempo, in quanto mina la sicurezza su cui riposa la società che le considera una minaccia ai privilegi custoditi dal mondo maschile.
Non stupisce che entrambe ricevano dai rispettivi partner appellativi dettati da disgusto misto a terrore.
GIASONE […] Poi, sposata con quest’uomo e avendomi generato dei figli, tu a causa del letto e del talamo li hai sterminati. Non c’è donna greca che avrebbe mai tanto osato, e a preferenza di esse pensai bene di sposare te, connubio per me odioso e funesto, te leonessa, non donna, che hai un’indole più selvaggia della tirrenia Scilla. (vv. 1336-1344
GIASONE O abominio, o donna sommamente la più odiosa agli dèi, a me e a tutto il genere umano, tu che hai avuto l’ardire di vibrare la spada contro le creature, che tu hai generato e anche a me hai tolto la vita, privandomi dei figli.
DOMENICO E maie ca t’avesse visto sottomessa, che saccio? Comprensiva, in fondo, della situazione reale che esisteva tra me e te. Sempe cu na faccia storta, strafuttente… ca tu dice: «Ma avesse tuorto io?… Ll’avesse fatto quacche cosa?». Avesse visto maie na lagrima dint’a chill’uocchie! Maie! Quant’anne simmo state nzieme, nun ll’aggio vista maie ’e chiagnere! (I, p. 538)
[…]
DOMENICO […] Un’anima in pena, senza pace, maie. Una donna che non piange, non mangia, non dorme. T’avesse visto maie ’e durmì. N’anema dannata, chesto si’. (I, p. 539)
DOMENICO (suggestionato dalle parole di Filumena, come uscendo di senno) Che ato staie penzanno?… Strega che si’! Ma io nun te temo! Nun me faie paura! (I, p. 552)
È evidente che entrambi gli uomini hanno una reazione violenta generata dal senso di impotenza e dal timore di essere sopraffatti dalle rispettive donne di cui non comprendono l’animo, ed è per questo che inveiscono contro di loro. Filumena Marturano è stata vista da Maurizio Grande come la «commedia della castrazione», nel senso che dal potere materiale esercitato da Domenico resta escluso il segno maggiore: la paternità. È da questo segno che Domenico è inadempiente e vulnerabile. La vittoria di Filumena consisterà nel ricondurre l’uomo alla realtà, insidiandone l’illusoria onnipotenza e facendogli accettare la resa prima della disfatta. Il trofeo di Filumena sarà la castrazione del maître giunto “a fine corsa”, con il ribaltamento delle iniziali posizioni di potere. Il trionfo di Filumena Marturano sarà costituito dalla riunione della famiglia, sposo compreso, sotto l’egida del principio materno.[9]
Possiamo notare una castrazione anche in Giasone al quale viene addirittura sottratta la paternità. Gli viene impedita la continuazione della specie, elemento fondamentale della mascolinità, e Medea vola via alla volta di Atene, portandosi dietro i corpi dei figli a cui Giasone non può nemmeno dare sepoltura. Avendo privato Giasone dei propri discendenti, sia uccidendo Glauce che i due figli, Medea lo ha reso inetto secondo i parametri sociali dell’epoca che consideravano la riproduzione uno degli elementi fondamentali della vita civile, poiché «veniva considerata un servizio prestato alla città».[10] Se è vero che ciò riguardava le donne in primo luogo, cui era dato il compito di fornire cittadini alla polis, rappresentava anche un requisito di mascolinità richiesto al buon cittadino maschio. Ma c’è dell’altro, i due personaggi maschili sono chiaramente dei perdenti e cederanno entrambi, accettando l’uno la paternità di figli non suoi e l’altro la mancata sepoltura dei suoi figli.
Sebbene con modi ed effetti diversi, Medea e Filumena mettono in crisi la famiglia patriarcale che rappresentava l’unità primaria della società sia Ateniese che Italiana. Al posto della moglie/compagna remissiva e pronta ad accettare il tradimento del maschio di casa viene esaltata la donna ribelle. Le due donne hanno qualità ritenute maschili, come il coraggio, la determinazione e, per certi versi, la crudeltà. Ma i due autori vanno oltre, attribuendo alle due protagoniste qualità divine: Medea, figlia di Elios, uscirà di scena come deus ex machina volando via su un carro trainato da draghi; Filumena sarà la portavoce, nientemeno che, della Madonna in persona, che le si manifesterà attraverso la fatidica frase «’e figlie so’ figlie». Queste parole sono cariche di un grosso significato extra-testuale e riassumono un’intera filosofia di vita: bisogno d’amore, dignità, uguaglianza, rispetto, diritti umani.
FINE PRIMA PARTE
continua
[1] “Medea allo specchio. Un mito nella modernità” (2016), in Réécrire le mythe. Réception des mythes anciens dans le théâtre italienne contemporaine, sous la direction de A. Capra et V. Cimmieri, Collection de l’Ecrit, n. 14, Toulouse.
[2] I testi citati sono tratti da: Filumena Marturano, in Eduardo De Filippo Teatro, Volume secondo, Cantata dei giorni dispari, Tomo primo(2005), edizione critica e commento a cura di Nicola De Blasi e Paola Quarenghi, I Meridiani, Milano: Arnoldo Mondadori Editore, pp.529-598.
Vincenzo Di Benedetto, Medea, (1997) Traduzione e appendice metrica di E. Cerbo, Milano BUR Rizzoli.
[3] V. Di Benedetto, «Introduzione», in Euripide, Medea, pp. 8-9.
[4] Se in una commedia vi sono due, cinque, otto personaggi, il nono per me è il pubblico: il coro. È quello a cui do maggiore importanza perché è lui, in definitiva, a darmi le vere risposte ai miei interrogativi. E. De Filippo, «Nota», in I capolavori di Eduardo, Torino, Einaudi, 1973, pp. VII-IX, p. IX.
[5] Si veda M. Grande, (1994), Dodici donne, pp. 119-135.
[6] Citato da J. March in «Introduction», in The Penguin Book of Classical Myths p. 4.
[7] Possiamo dire che la commedia abbia contribuito all’impulso legislativo, in quanto nel 1947 l’Assemblea Costituente approvò quello che sarebbe divenuto l’Articolo 30 della Costituzione italiana promulgata nel 1948, che recita: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio».
La commedia ha anche il merito di aver sollevato la questione spinosa del diritto della donna all’interruzione della gravidanza. Solo trent’anni dopo, il Parlamento emanò la legge sull’Interruzione volontaria della gravidanza del 22-5-1978, n. 194.
[8] Si veda R. Blondell (1999), in Women on the Edge, p. 153.
[9] M. Grande, Dodici donne, p. 120.
[10] Si veda R. Blondell, M. Gamel, N. Sorkin Rabinowitz, B. Zweig, «Introduction», in Women on the Edge, p. 53.
Alessandra De Martino

Alessandra De Martino
Dopo avere conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università Federico II, si è trasferita in Inghilterra dove vive dal 1984. È traduttrice ed è stata docente di lingua e cultura italiane e tecniche di traduzione presso la Facoltà di Lingue moderne dell’Università di Warwick, in Inghilterra, dove ha conseguito un dottorato di ricerca in Traduzione teatrale, con una tesi sulla trasposizione culturale nelle traduzioni dal napoletano all’inglese di alcune delle commedie di Eduardo De Filippo.
Durante la sua docenza universitaria, ha condotto svariati progetti di traduzione e adattamento teatrale di opere di Dacia Maraini, Gianrico Carofiglio, Serena Dandini, Stefano Benni e Giuseppe Catozzella.
Nel 2014 ha fondato l’International Network of Italian Theatre, la prima piattaforma globale di teatro italiano, di cui è anche direttrice (www.newinit.org).
Nel 2019 ha lasciato la docenza per dedicarsi esclusivamente alla regia e scrittura teatrale ed è ora Ricercatrice associata presso la Scuola di Teatro, sempre all’università di Warwick.
Nel 2020 e nel 2022 ha messo in scena a Londra i suoi adattamenti di alcuni monologhi da lei tradotti in inglese tratti da Ferite a morte di Serena Dandini e Maura Misiti, e della commedia Non ti pago, di Eduardo De Filippo. I monologhi fanno anche parte di un testo in inglese dal titolo Class Action, di cui Alessandra è co-autrice.
Nel 2024 ha partecipato ad un progetto sperimentale del Teatro dell’Oppresso del regista brasiliano Augusto Boal, realizzando un adattamento teatrale delle notizie dei giornali e dei media.
Fa parte del Comitato Italiano di Eurodram, la rete europea di traduzione teatrale, che promuove la diffusione di opere teatrali per lo più inedite con particolare attenzione alla diversità linguistica.
È stata invitata come relatrice da università nazionali e internazionali, tra cui l’Università di Studi Internazionali di Shanghai, l’Università di Tolosa Jean Jaurès e L’Università Statale di Milano. Ha scritto numerosi articoli e capitoli pubblicati in riviste e testi accademici ed è co-curatrice di due volumi, in italiano e in inglese, sul teatro dei margini, il titolo italiano è Diversità sulla scena, e al momento sta lavorando a una monografia sull’adattamento teatrale.
Nel luglio 2024 è stata invitata, dalla Associazione Culturale Onlus Effetto Donna, a presiedere la giuria tecnica della XI edizione della Settimana Letteraria, e a presentare il suo lavoro Medea allo specchio, accompagnato da una lettura scenica di brani tratti da Filumena Marturano e Medea eseguita dagli attori Alina di Polito e Paolo Puglia con l’accompagnamento musicale del maestro Mauro Navarra.