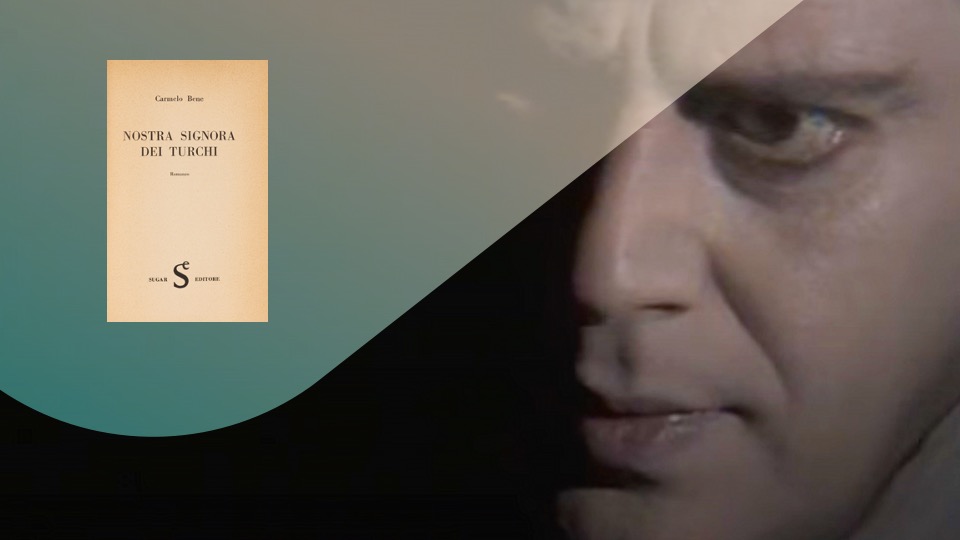Romain Gary avrebbe probabilmente amato molto Silvio Orlando nei panni del piccolo e ribelle Momò, il bambino protagonista del suo romanzo più bello e toccante, La vita davanti a sé. Tanto per cominciare Orlando ha portato in scena il libro quasi alla stessa età nella quale Gary si è sparato un colpo in testa, e cos’è la storia d’amore fra Momò e la vecchia Madame Rosa se non un modo per Gary di tornare all’infanzia da vecchio, all’amore mai sopito per sua madre? Romain Gary pubblicò La vita davanti a sé nel 1975, pochi anni prima di suicidarsi, con lo pseudonimo di Émile Ajar, vincendo quel prestigioso premio Goncourt che aveva già ottenuto con il nome di Romain Gary (un altro pseudonimo) e che notoriamente si può ottenere una sola volta nella vita. Gary, che tutti credevano un romanziere senza più niente da dire, giunto al punto in cui “il biglietto del viaggio non è più valido”, come dice il titolo di uno dei suoi romanzi, fece uno sberleffo a tutto il mondo culturale parigino. Ma questa è una storia nota e non è ciò di cui intendo scrivere qui. Qui si tratta di teatro.
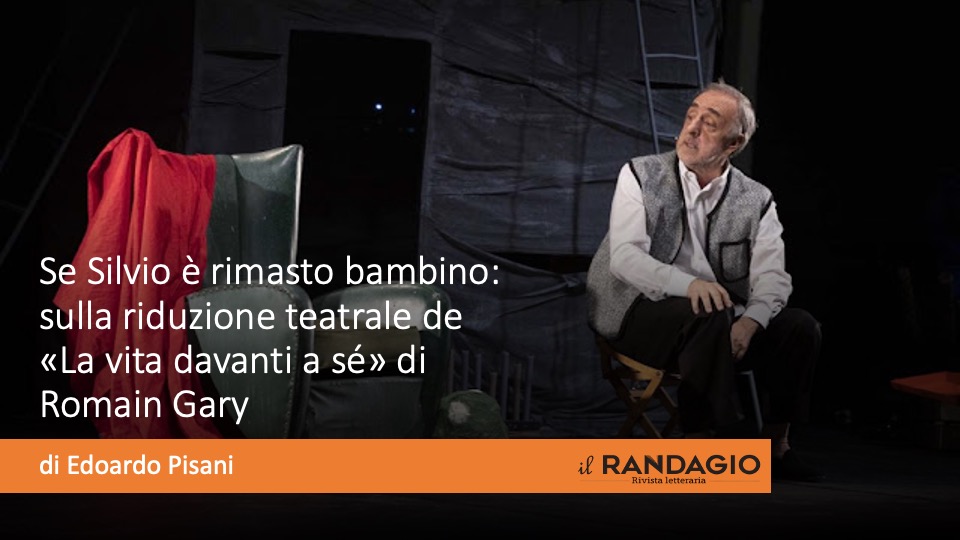
Sono appena rincasato da una delle tante repliche de La vita davanti a sé portate in scena da Silvio Orlando negli ultimi anni, e ne sono entusiasta. Accedendo alla platea del teatro, il Quirino di Roma, a un tratto mi sono trovato davanti la fotografia di un mio vecchio ricordo: il grande e indimenticato Eros Pagni che recita ne Il commesso viaggiatore di Arthur Miller, con la regia di Marco Sciaccaluga. Era il 2005, vent’anni fa: la fotografia è appesa fra la buvette e l’ingresso della sala. Avevo sedici anni ed ero andato a teatro con mia sorella. Eros Pagni ci aveva commossi profondamente. Così cominciò la mia passione per il teatro, che dura tuttora, anche perché è forse l’ultima delle grandi arti in cui gli schermi – i dannati schermi che ci circondano in ogni momento – sono banditi. Il teatro è rispetto per il prossimo, oltre che magia e dignità. È forse uno degli ultimi blasoni romantici rimastici. Lo scriveva bene Ennio Flaiano, nel Diario degli errori: “Lasciate andare avanti il cinema, avido di cose reali, il Teatro deve essere falso e affascinante. Nel teatro si ritrovano i simboli delle cose perdute di vista.”
C’è molto di ciò che crediamo di aver perso ne La vita davanti a sé di Silvio Orlando. Ci sono l’infanzia, l’amore, la tenerezza, ma anche lo spavento della morte e la vecchiaia. C’è senz’altro l’orrore del niente, ma c’è pure Parigi con le sue musiche e la sua vita frenetica e variopinta; c’è la disperata voglia di vivere del piccolo Momò e c’è il coraggio di una vecchia donna malandata – Madame Rosa – che non vuole essere costretta a vivere “come un vegetale” fino alla morte, perché La vita davanti a sé è anche un romanzo sul diritto a una morte dignitosa, all’eutanasia. L’interpretazione di Silvio Orlando è onesta e commossa e mi ha spinto sia alle lacrime che alle risate. E sì che è difficile recitare l’impertinenza di un bambino indomo quale Momò, o la sua innocenza, come dimostra il poco riuscito Pinocchio portato al cinema dal pur bravo Roberto Benigni. Per interpretare un bambino da vecchi bisogna forse essere rimasti bambini per tutta la vita. Bisogna essere non soltanto convincenti ma perfino veri. In pochi ci riescono.
Silvio Orlando è un bambino tenero e pieno di grazia e il romanzo di Romain Gary in scena rimane il capolavoro che è sulla pagina. Occorre fare un plauso all’edizione italiana del libro, cioè alla traduzione di Giovanni Bogliolo (già traduttore di Flaubert per i Meridiani), riportato vent’anni fa nelle librerie dall’editore Neri Pozza. Chi ha letto e amato il romanzo non rimarrà deluso e anzi si sorprenderà, perché la regia di Silvio Orlando porta pure cose proprie al già straordinario Romain Gary: la musica, per esempio, con il refrain di Comment te dire adieu, canzone scritta da Serge Gainsbourg e cantata da Françoise Hardy, ma anche i tamburi africani e altri motivi pieni di nostalgia e di tenerezza, e poi il talento di Silvio Orlando, che balla e si commuove e ride e piange e racconta la vita di Momò e un po’ anche se stesso (e quindi tutti noi) con la delicatezza di un vecchio uomo mai veramente diventato adulto, perché l’infanzia ci riguarda tutti e chi pensa di averle voltato le spalle o di averla superata ha già cominciato a morire o a perdersi nel banale o maligno caos del mondo, e noi vogliamo salvarci.

Oppure, per dare qualche ragguaglio più preciso sullo spettacolo, la riduzione di Silvio Orlando ci offre dei momenti inediti di grande commozione andando anche oltre il romanzo, come la chiusa dell’uovo fracassato a terra, che suggella l’ultima decisiva frase di Momò e che, lo ammetto, mi ha fatto scoppiare in lacrime, e poi dei momenti di grande comicità, certamente dovuti al genio di Gary ma pure, vale la pena ripeterlo, alla regia teatrale, come quando un africano amico di Momò gli si rivolge urlando parole incomprensibili con una gestualità, appunto, teatrale, buffa e colorita e perfino festosa nella sua scanzonata allegria. E tuttavia anche questa è una scena di morte, perché gli amici di Madame Rosa stanno improvvisando una danza tribale per farla uscire da uno stato di catalessi. Il comico e il tragico si uniscono e la scena affascina e spaventa al tempo stesso. La vita davanti a sé è un grande romanzo sulla morte, oltre che sulla vita e sull’amore.
Bisogna voler bene. Il faut aimer. Lo dice Romain Gary e ce lo ripete Silvio Orlando. Lo afferma il piccolo Momò, commuovendoci, e ogni tanto cerchiamo di ripetercelo, di ricordarlo in questa vita che talvolta ci maltratta. Sarà più facile farlo dopo aver visto Silvio Orlando nei panni del piccolo Momò: un bambino, un vecchio, in ogni caso un essere umano che difende il diritto alla tenerezza e alla fragilità in un tempo nel quale la cafonaggine e la forza e la violenza la fanno da padroni ovunque. Bisogna voler bene, sì: bisogna amare. Solo così, forse, ci salveremo dal mondo e potremo salvarlo insieme a noi. Noi o i bambini ribelli che ci sopravvivranno, i tanti Momò del mondo che non devono e non possono essere dimenticati. Grazie a Silvio Orlando per essere rimasto uno di loro. Ne avevamo bisogno.
Edoardo Pisani*

*Edoardo Pisani è nato a Gorizia nel 1988. Ha pubblicato i romanzi E ogni anima su questa terra (Finalista premio Berto, finalista premio Flaiano under 35) e Al mondo prossimo venturo, entrambi con Castelvecchi. Sempre con Castelvecchi ha pubblicato un libro su Rimbaud, E libera sia la tua sventura, Arthur Rimbaud! Nel 2026 Marsilio pubblicherà il suo terzo romanzo.