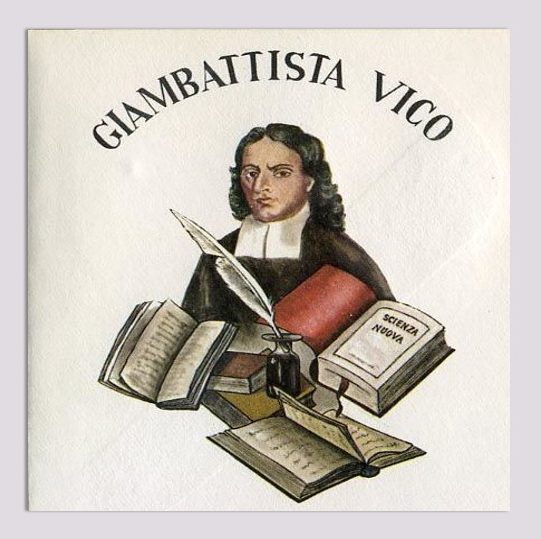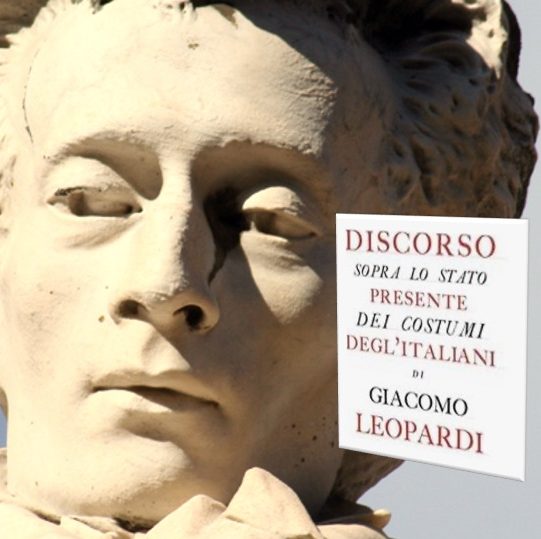Con il Settecento giunge a piena risoluzione la catena di conflitti apertisi nel Seicento, con la crisi sia del sistema e del modello conoscitivo tradizionale, sia delle certezze che a quello erano collegate. Secolo di profonda e generale trasformazione, il Settecento si apre sulla scena politica con il dominio incontrastato del massimo sovrano assoluto, Luigi XIV di Francia, il re Sole, e si chiude sulle prime vittorie italiane del generale Napoleone Bonaparte, destinato a divenire il primo imperatore dei Francesi e a diffondere in tutta Europa i principi della rivoluzione francese ( Liberté, égalité, fraternité), sui quali si fondano oggi direttamente o indirettamente le Costituzioni di tutti gli Stati del mondo. Egemonia francese che, però, cede ben presto il passo al prevalere di quella potenza marinara, l’Inghilterra, che darà il via al processo di trasformazione globale e radicale dell’organizzazione economica e sociale che va sotto il nome di “Rivoluzione industriale” e segna in modo determinante il percorso successivo dell’evoluzione dell’umanità, condizionandone nel bene e nel male ogni forma di organizzazione civile e di esperienza di vita.

Per analizzare e comprendere questi processi, il metodo d’indagine scientifico-matematico, empirico e razionale, derivato dalle scienze naturali, è dal Settecento applicato a tutto lo scibile. Nessun settore dell’esperienza umana è escluso dalla verifica e dal vaglio critico operato dalla ragione che, in questo senso, si sostituisce, come criterio superiore di verifica di ogni affermazione e come principio di ogni azione, alla fede, alla Rivelazione cristiana e alla sua tradizionale interpretazione dogmatica. Nessuna autorità tradizionale, nessun modello istituzionale passa indenne attraverso l’esame cui l’uomo del Settecento sottopone i più minuti aspetti della realtà naturale e umana, ogni settore della conoscenza e della cultura.
In questo sistema di analisi si inserisce il capolavoro di Giambattista Vico “Princìpi di una scienza nuova d’intorno alla natura delle nazioni, per i quali si ritrovano altri princìpi del diritto naturale delle genti”, come recita il titolo della prima edizione del 1725. Si prende qui in considerazione l’edizione “I classici Bur” della Biblioteca Universale Rizzoli, con introduzione e note di Paolo Rossi, quinta edizione del 1994.
Sintesi coraggiosamente innovativa del lavoro erudito dei decenni precedenti, l’opera propone un’interpretazione generale della storia delle attività umane, dei principi fondatori della società e della sua evoluzione dalle origini (desunte dall’autore nel mito e nella realtà delle lingue e delle letterature arcaiche) fino agli esiti moderni. La ricostruzione del passato comporta delle costanti del divenire storico, analizzato in tutte le sue espressioni culturali di fondo (religiose, politiche, giuridiche e istituzionali, linguistiche, filosofiche e letterarie) e spiegato come l’alternarsi progressivo di fasi successive di civiltà umana ( l’<<età degli dei>>, <<degli eroi>> e <<degli uomini>>), alle quali l’autore fa corrispondere una concezione del mondo, una sensibilità attraverso la quale si esprime il grado di sviluppo raggiunto dall’umanità e che informa nel profondo le modalità dell’esperienza e dell’organizzazione sociale.
Poiché la ricerca di Vico si spinge fino alle origini prime dell’umanità, ben oltre il punto in cui l’uomo produsse i primi documenti scritti, buona parte della ricostruzione dei caratteri originari dell’umanità e dell’età primitiva, a cui l’autore dedica la massima attenzione, si fonda sulle tracce non intenzionali trasmesse da quell’età ai tempi successivi. Molto frequente è il ricorso alle spiegazioni etimologiche; indispensabile riferimento e oggetto di studio diviene il patrimonio mitologico e leggendario, i rituali e il folklore, dai quali l’autore ricava i dati utili alla ricostruzione, il più possibile fedele all’originale, della mentalità e delle funzioni interiori dell’uomo primitivo. Da queste infatti Vico fa dipendere lo sviluppo successivo della storia del genere umano.

Un mondo sterminato di <<detriti>> storici, giudicati fino a quel momento inaffidabili dalla tradizione colta, vengono per la prima volta riportati alla luce e interpretati come documenti della massima importanza per risalire alla definizione della psiche umana, colta nella sua fase primitiva, allo stato originale. Vico supera così definitivamente il confine tra la “civiltà” europea moderna e le altre forme dell’organizzazione umana che l’uomo europeo, al primo contatto con le popolazioni indigene del Nuovo Mondo, aveva provveduto a collocare su un piano inferiore o addirittura subumano: si pensi ai dubbi sorti a proposito della loro appartenenza al genere umano, alle discussioni nate tra i teologi per stabilire se quelle popolazioni fossero o no dotate di anima. Nessuna fase dello sviluppo dell’umanità è di per sé, superiore, in senso assoluto, alla precedente; ciascuna è indispensabile allo sviluppo della vicenda umana.
Vico ammette la forza della provvidenza divina nella trasformazione storica, ma le considerazioni relative all’azione creativa dell’uomo suggeriscono implicitamente la visione di un mondo il cui sviluppo è largamente affidato alla sua iniziativa, spinto alla trasformazione dal bisogno di soddisfare il proprio desiderio di conoscenza e di azione. In ogni caso Vico non presenta, nella sua ricostruzione del passato, interventi diretti di Dio nella determinazione del corso della storia umana, poiché il progresso, quale è concepito nella Scienza nuova, non è orientato verso alcuna meta e non esclude la possibilità di un regresso, l’instaurarsi di un processo regressivo (corsi e ricorsi). Inseriti nell’insieme ordinato e oggettivo del corso della storia, anche i regressi storici rispondono comunque a una logica che permette in buona misura di prevedere i risultati dell’azione umana.
La progressione delle linee teoriche generali dell’opera, portarono l’autore a due successive riedizioni (1730; 1744, postuma, con il titolo di “Princìpi di scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni”). In esse, il testo dal 1725 veniva progressivamente ampliato e organizzato, inserendo i risultati di nuove osservazioni e dimostrazioni, accumulatesi via via in gran numero, in un processo continuo di revisione e di crescita.
Il lavoro secolare di indagini dedicate dalla critica alle opere precedenti la “Scienza nuova”, per lo più inedite, ha fatto emergere i motivi che orientano la ricerca di Vico e trovano la loro sintesi nel capolavoro. In questo senso il “De antiquissima italorum sapientia” (L’antichissima sapienza degli italici), del 1710, per alcuni attardato e inadeguato, testimonia nello studioso un’esigenza largamente diffusa nella cultura italiana del tempo, che respinse in buona misura la proposta cartesiana a causa della sua astrattezza intellettualistica.
Rifiutando Cartesio, Vico rifiuta di accettare il predominio incontrastato del metodo matematico e del modello conoscitivo proposto dalle scienze naturali e rivendica la piena dignità, anzi la centralità, delle discipline umanistiche, che avevano perduto negli ultimi decenni il predominio di cui avevano goduto nell’età classica e rinascimentale. Particolarmente significativa è, in questo senso, l’orazione “De nostri temporis studiorum ratione” (Il metodo degli studi del nostro tempo, del 1709). In essa Vico dimostra un’approfondita conoscenza del metodo fisico-matematico usato dai cartesiani, e considerato il metodo universale perfetto di indagine della realtà, ma esprime la preoccupazione che la nuova scienza confidi eccessivamente nell’assolutezza e nell’universalità di applicazione dei propri strumenti conoscitivi e finisca per sottostimare i limiti della ragione umana. Lo studio della scienza finirebbe per distogliere l’attenzione della classe colta dallo studio di tutta una serie di funzioni psichiche non operanti secondo principi matematici, come la fantasia, e di tutta una serie di attività culturali esprimentisi secondo modi di tipo non-logico, l’arte, l’eloquenza, non penetrabili attraverso lo strumento matematico, ma fondamentali nell’orientare il comportamento dell’uomo.
Ma una volta stabilito, con Cartesio, che l’unica conoscenza sicura, <<certa>>, è quella esatta, offerta dall’applicazione del metodo matematico alla realtà fisica, e constatato che non si possono spiegare matematicamente i comportamenti umani, si deve da questi due fatti dedurre che non si può dare conoscenza sistematica e obiettiva di queste sfere dell’esperienza, poiché non possono essere imposte in termini matematici. Vico ha il merito di aver superato questa difficoltà metodologica, che blocca di fatto ogni razionalismo di tipo matematico, recuperando all’osservazione e all’interpretazione coerente e rigorosa dell’intellettuale, il “filosofo”, tutto il vasto terreno dell’incerto, in cui l’uomo da millenni, con soluzioni continuamente nuove, opera la maggior parte delle sue scelte di vita, applica la sua intelligenza ed esercita continuamente la sua creatività.
La soluzione che permette a Vico di superare il dilemma, se sia possibile spiegare razionalmente l’irrazionale, emerge nel famoso principio del <<Verum ipsum factum>> (è accertabile solo ciò che è stato fatto): se a Dio soltanto pertiene, in quanto creatore, la conoscenza piena della natura, all’uomo compete la conoscenza delle proprie creazioni concrete, delle proprie realizzazioni. Compito della filosofia è, allora, mettere a punto strumenti concettuali, altrettanto rigorosamente razionali, quanto quelli messi a punto nel campo fisico-matematico dalla scuola cartesiana, ma specificamente adattati all’oggetto di studio.
Nella ricerca di un collegamento strettissimo tra la formulazione di un’ipotesi teorica che spieghi il meccanismo che guida l’evoluzione della “cultura” umana, nella vita del singolo e della comunità, e i fenomeni particolari in cui la legge dello sviluppo storico si realizza concretamente, Vico si dimostra erede del metodo scientifico inaugurato in Italia da Galilei. Egli lo estende, di fatto, al mondo dell’uomo, di cui come abbiamo detto rivendica il primato. La nova definizione vichiana dell’esperienza umana presenta non poche analogie, per originalità, ampiezza della portata e risultati raggiunti, con la rivoluzione copernicana del secolo precedente. Non a caso, tra gli autori a cui Vico si collega idealmente, egli indica l’inglese Francis Bacon, filosofo empirista, eminente uomo politico e strenuo assertore della rivoluzione scientifica del Seicento.
Non è un caso, inoltre, che Vico approdi alla sua geniale ridefinizione dei meccanismi generali, individuali e sociali, del divenire della società umana, attraverso lo studio del diritto, tanto strettamente collegato alla dimensione politica e di conseguenza alla definizione dei bisogni essenziali dell’uomo. La lezione del giusnaturalismo, della teoria del diritto naturale formulata nei decenni precedenti dall’olandese riformato Huig de Groot e dal tedesco Samuel von Pufendorf, che giungono all’identificazione di principi giuridici comuni a tutta l’umanità, perché basati sulle esigenze e tendenze comuni a tutti gli uomini, offre a Vico il primo esempio di una sintesi teorica generale fondata in concreto sullo studio delle forme che l’umanità ha saputo dare nel tempo alle norme che regolano la convivenza civile.
Il procedimento dei giusnaturalisti viene applicato da Vico a tutte le manifestazioni della socialità dell’uomo, e non solo a quelle formali e coscienti quali il diritto, aprendo così la via alla costruzione delle moderne scienze sociali e dell’antropologia in particolare. La connessione instaurata tra speculazione filosofica ed esperienza storica concreta, il carattere di utilità pratica che Vico attribuisce alla propria indagine e le modalità stesse di questa, collegano lo studioso alle correnti più autorevoli del pensiero italiano ed europeo che tra Sei e Settecento si oppongono ai vincoli tradizionali della cultura espressa dalla Controriforma e ne determinano la crisi irreversibile.
Stabilito che il <<mondo civile egli certamente è stato fatto dagli uomini>>, la vicenda storica che Vico porta alla luce è la storia dell’evoluzione della mentalità umana, delle caratteristiche psichiche profonde che caratterizzano la percezione del mondo e danno forma, creandola, ad ogni aspetto dell’organizzazione sociale e dell’attività umana.
Sostanzialmente ignorata dai contemporanei, che per lo più la rifiutarono per la sua <<oscurità>>, La Scienza nuova circolò ampiamente negli ambienti illuministi napoletani e, conosciuta per il tramite degli esuli napoletani della Repubblica Partenopea (1799), ispirò l’azione della maggior parte degli intellettuali impegnati nel Risorgimento.
I Romantici europei, poi, trovarono in Vico l’anticipazione della loro visione della storia, come progresso civile delle nazioni e della rivalutazione della grandezza umana e civile espressa dalla grande poesia del passato (da Omero a Dante in particolare). Esaltata da Benedetto Croce come fondamento dell’indirizzo storicistico che caratterizzerebbe il pensiero italiano moderno, La Scienza nuova oggi è considerata anche fuori dall’Italia come una tappa fondamentale nella costruzione della moderna concezione dell’uomo e della storia, nonché l’opera con cui ha origine lo studio scientifico della mitologia e, più in generale, della vastissima materia afferente alle scienze umane.
Per chi ne avesse desiderio, oltre che occasione, si suggerisce di andare a visitare la casa natale di Vico, con la sottostante piccola bottega del padre libraio (libreria non più esistente), in cui visse fino all’età di diciassette anni, come precisa la lapide sulla facciata. Si trova in via San Biagio dei Librai a Napoli. Il testo della lapide fu dettato da Benedetto Croce (colui che aveva scritto e pubblicato su Il Mondo, quotidiano politico, il primo maggio 1925 “L’antimanifesto” in risposta al “Manifesto degli intellettuali fascisti” di Giovanni Gentile). Nella domanda presentata al Municipio di Napoli, su suggerimento di Mario Forges Davanzati, per evitare che la domanda stessa venisse respinta dalle autorità fasciste, Fausto Nicolini si dichiarò autore del testo. La domanda fu accolta e lo scoprimento della lapide avvenne il 23 giugno 1941, alla presenza delle autorità e dell’autore fittizio.
Sonia Di Furia

Sonia Di Furia: laureata in lettere ad indirizzo dei beni culturali, docente di ruolo di Lingua e letteratura italiana nella scuola secondaria di secondo grado. Scrittrice di gialli e favolista. Sposata con due figli.