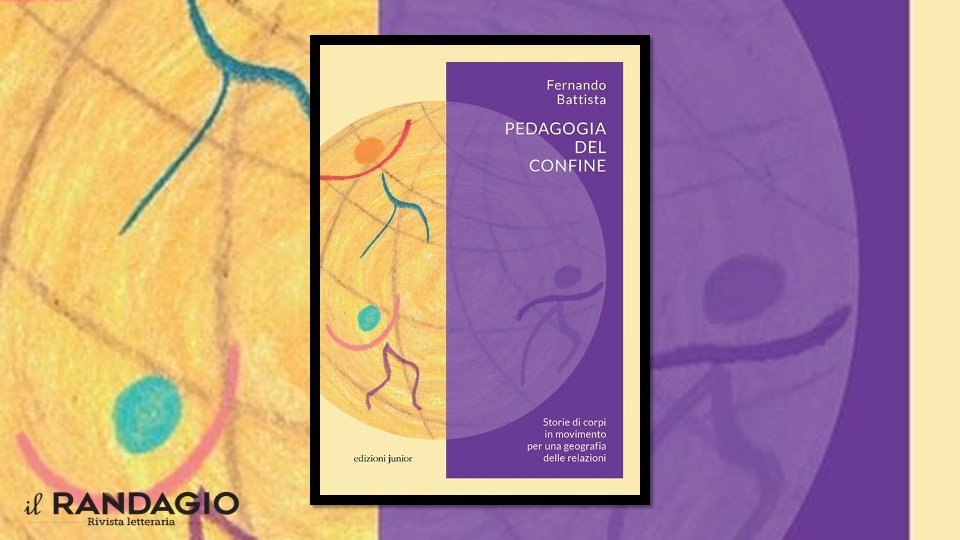Se a noi de Il Randagio fosse dato di accompagnare il titolo del terzo libro di Viktorie Hanišová con una frase d’impatto e un sottotitolo, suonerebbero così: Ricostruzione: la fragilità come forza. Un romanzo che trasforma il trauma in scrittura, esplorando maternità sofferenti, ruoli di genere e memoria familiare. Pubblicato nel 2019 in Cechia, patria dell’autrice, arriva fresco di stampa nella traduzione italiana di Letizia Kostner per i tipi di Voland, nella collana Amazzoni. Ricostruzione si inserisce così nella chiusura, ci auguriamo momentanea, del triangolo letterario in cui Hanišová ha esordito nel 2015, dieci anni in cui la sua voce è stata conosciuta e apprezzata da critica e lettori, nelle dodici lingue in cui i suoi tre libri sono stati tradotti.
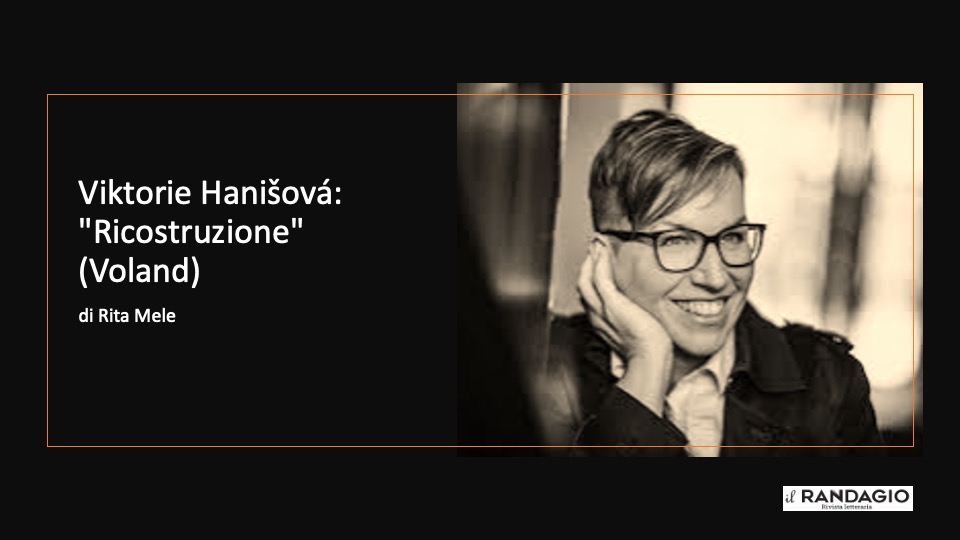
Sebbene l’autrice non dichiari il romanzo come puramente autobiografico, alla lettura emergono in filigrana la sua formazione e il suo background, fonti d’ispirazione evidenti per i temi trattati. Nata a Praga nel 1980 e laureata in lingue e letteratura ceca all’Università Carolina, Hanišová conosce a fondo la società e la storia del suo paese, in particolare il periodo post-comunista, e lo trasmette nella precisione con cui descrive l’atmosfera e le dinamiche sociali che accompagnano il trauma intergenerazionale della protagonista Petra. La narrazione della casa di famiglia e della provincia ceca, che accompagna il lettore lungo le 300 pagine del romanzo, cattura incessantemente mente ed emozioni, esplorando il peso dell’eredità storica e familiare sulla generazione nata a ridosso del crollo del comunismo.
Hanišová, che è più di una scrittrice, si è cimentata con successo anche come traduttrice ed è docente di lingue ed esperta filologa. Tra i suoi interessi si annovera la psicologia, che nei suoi tre romanzi emerge con chiarezza e senza forzature, con dovizia di dettagli appropriati. In Ricostruzione, la vivida analisi del trauma, dell’anoressia e dell’autolesionismo nel percorso della giovane protagonista suggerisce l’attenzione dell’autrice alla psicopatologia e al modo in cui traumi familiari non risolti si manifestano nel corpo e nel comportamento.
«Tutte le famiglie felici sono uguali; ogni famiglia infelice è infelice a modo suo.» Così apre Anna Karenina di Lev Tolstoj, e con questa frase risuona immediatamente l’esperienza raccontata da Hanišová in Ricostruzione, un romanzo scritto da una bambina di nove anni che cresce nello sguardo, nella percezione della realtà e nella qualità della coscienza, più che anagraficamente. La voce è fragile, frammentaria, incapace di nominare il trauma se non attraverso approssimazioni, silenzi e scarti improvvisi. Nel corso del romanzo si vede come il trauma frantumi la memoria e arresti la crescita, costringendo la coscienza a un linguaggio schematico, quasi diagnostico, simile a quello del DSM. Ogni trauma ha un suo linguaggio, e Hanišová lo osserva con lucidità poetica trasformandolo in scrittura narrativa.
La forza del romanzo risiede in questa prospettiva rigorosa: Hanišová rinuncia alla spettacolarizzazione del dolore e affida la narrazione a una lingua essenziale, frammentaria e misurata. Il ritmo della prosa, le pause, le ripetizioni e la precisione dei dettagli trasformano la lettura in un inventario emotivo: la protagonista annota con freddezza la propria “incapacità di concentrazione prolungata”, la tendenza a isolarsi, le oscillazioni emotive, come se compilasse schede cliniche della propria interiorità ferita. Ogni gesto quotidiano — il tremore delle mani, l’ansia che blocca la parola, il senso di colpa — diventa parte di un catalogo emotivo, mostrando con lucidità l’esperienza di una mente segnata dal trauma sin dall’infanzia. Il romanzo ci permette così di seguire Petra nei frammenti della sua esperienza interiore: la narrazione diventa lente attraverso cui osservare il mondo, le relazioni familiari e la memoria, trasformando la lettura in un vero e proprio inventario emotivo della fragilità e della resilienza.
I personaggi emergono attraverso lo sguardo analitico della protagonista: non ci sono antagonisti né figure salvifiche, ma riflessi, ostacoli intermittenti e frammenti di realtà da ricostruire. Il romanzo esplora con delicatezza le maternità sofferenti e le relazioni di genere: figure materne fragili o assenti, figure maschili distanti e legami che attraversano generazioni.
Attraverso il confronto tra presente e passato, Hanišová traccia un ritratto intenso dei ruoli di genere. Il femminile emerge nelle figure materne e femminili, spesso fragili o segnate da dolori profondi, confrontate con situazioni tragiche. Il maschile si manifesta in assenze, distanze emotive o rigidità comportamentale, contribuendo a modellare l’esperienza della protagonista e le dinamiche familiari. In molti casi, le figure parentali appaiono inadeguate o disfunzionali, incapaci di offrire protezione emotiva o stabilità, e diventano strumenti di trasmissione del trauma tra generazioni. Maschile e femminile si intrecciano e si influenzano reciprocamente, rivelando schemi di protezione, incomunicabilità e affetto in tutte le generazioni. In questo senso, la narrazione indaga anche come genere e qualità della genitorialità strutturino esperienze, crescita e relazioni familiari.
La lingua è asciutta, misurata, ogni parola scelta per restituire la sospensione del tempo interiore.

La narrazione procede per accumulo, ritorni e frammenti, restituendo la percezione della memoria traumatica come pressione costante sul presente. Così, Ricostruzione diventa diario, inventario clinico e romanzo psicologico, dove la precisione dell’osservazione intensifica la soggettività.
Non è un caso se il romanzo dialoghi anche con le riflessioni pirandelliane sulla frammentazione della percezione e sull’inafferrabilità dell’altro: ogni sguardo, ogni gesto rivela mondi interiori complessi, come se le persone fossero spesso separate da un velo che solo la protagonista, nel suo osservare, tenta di sollevare. La chiusura del cerchio narrativo lo conferma con un’immagine potente e memorabile, quando Petra guarda come fosse la prima volta la foto della madre alla festa di Černošice:
‘Mia madre non guarda il suo presunto amante né fuori dalla finestra. Nella luce fioca e tremolante vedo che i suoi gelidi occhi celesti guardano diritto i miei.’
Questa frase finale non solo sancisce la presa di coscienza di Petra, ma concentra in un attimo il peso delle generazioni, dei traumi trasmessi e delle relazioni familiari complesse. La memoria familiare non si chiude mai: il passato ritorna, e con esso il carico emotivo di genitorialità spezzate e disfunzionali, rendendo il trauma tanto personale quanto transgenerazionale.
Collocato nella narrativa europea contemporanea, il romanzo dialoga con la tradizione centro-orientale dell’introspezione e della memoria traumatica. Lo stile ricorda, per intensità psicologica e introspezione, La campana di vetro di Sylvia Plath, mentre nel panorama ceco contemporaneo si colloca accanto a figure come Petra Hůlová, che esplorano con intensità la soggettività femminile e le dinamiche familiari e generazionali.
Hanišová valorizza la propria formazione e la storia personale per trasformare la sensibilità verso linguaggio e memoria in riflessione universale sul trauma e sulla ricostruzione di sé. La traduzione italiana, curata da Letizia Kostner, restituisce con cura pause, silenzi e delicatezza della lingua originale.
Pubblicato nella collana Amazzoni dell’editore Voland, Ricostruzione si inserisce perfettamente nella linea editoriale che valorizza voci femminili innovative, capaci di raccontare il trauma e la memoria con intensità poetica.
Leggere Ricostruzione significa confrontarsi con l’intimità della fragilità umana, la complessità delle relazioni familiari e di genere, le genitorialità disfunzionali e la transgenerazionalità del trauma. La parola diventa strumento di ricostruzione, la coscienza impara a sostenere il dolore, e il lettore partecipa a questa esperienza di sopravvivenza e maturazione. Per noi de Il Randagio si tratta di un romanzo indispensabile, che lascia un segno profondo e duraturo. Leggetelo ascoltando la voce narrante e la vostra voce interiore: vi aspetta un’esperienza emotiva e letteraria.
Rita Mele

Rita Mele: barese, ma da molti anni vive a Bolzano. Giornalista, giurista, formatrice, psicologa, insegnante di yoga. Progetti per il futuro: ballare