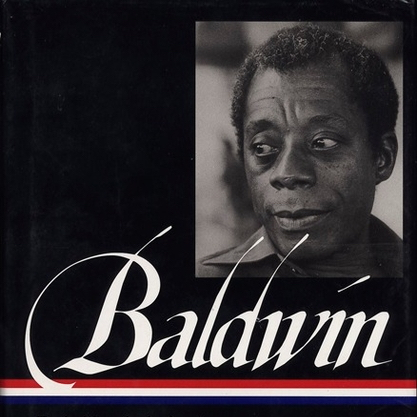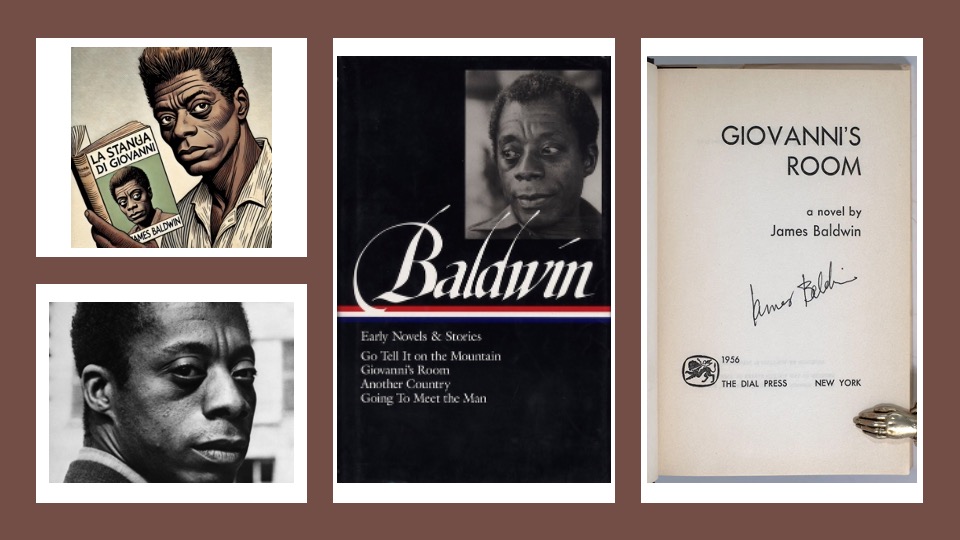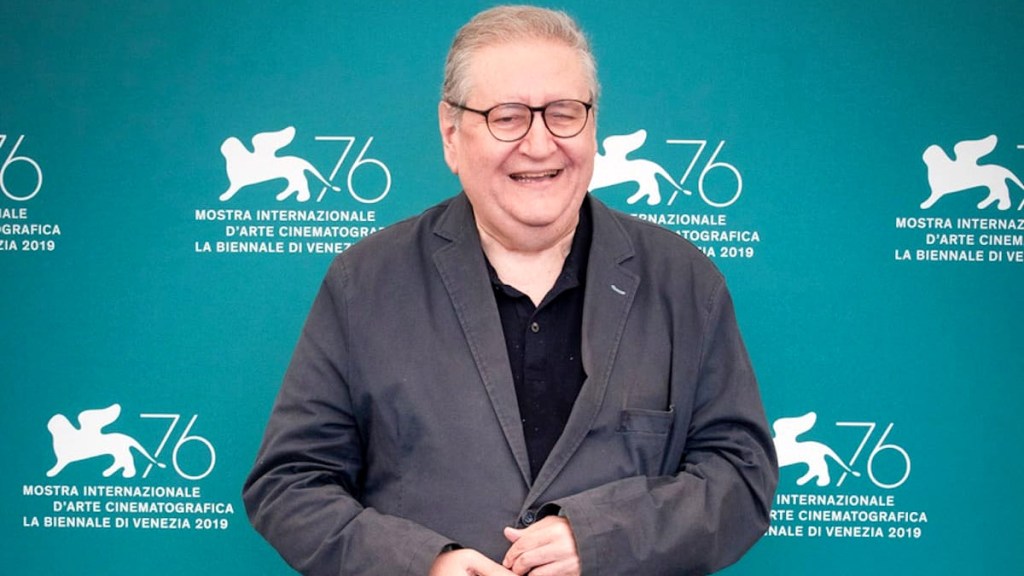“La versione di Mati” è una commedia brillante e acuta che racconta la storia di una famiglia sui generis attraverso gli occhi di Mati, una bambina undicenne cresciuta da una madre psicoterapeuta anticonformista e una nonna che “si fa chiamare Totti e va ai party in tacco 12”. Eva Milella, barese, autrice televisiva, podcaster, stand up comedian, riprende e approfondisce nel romanzo alcune delle tematiche (dinamiche familiari, maternità, rapporti tra generazioni) già trattate nel format YouTube “MALAMAMMA” e nella community “Stappamamma”. L’ha intervistata per gli amici del Randagio il nostro Gabriele Torchetti.

Ciao Eva e benvenuta alla rivista letteraria Il Randagio! Sei diventata celebre sul web con il format YouTube “MALAMAMMA”, con i tuoi video ironici e dissacranti hai spiegato come si sopravvive ai figli. Sono passati un po’ di anni da quell’esperienza e dalla scrittura “teatrale” sei approdata alla narrativa. Com’è avvenuto questo passaggio?
Direi che è stato un passaggio quasi fisiologico. Dopo anni passati a scrivere per la scena, la televisione e storytelling per varie realtà e soprattutto non trascurando mai la predisposizione a pensare con la testa dell’attrice (tempi, battute, pause), ho sentito il bisogno di rallentare e ascoltare meglio le storie che volevo raccontare. La narrativa mi ha permesso di scavare di più, di mollare la necessità della battuta a effetto per concentrarmi su cosa muove davvero i miei personaggi. E poi diciamolo: i figli crescono, dormono (ogni tanto), e a quel punto puoi anche scrivere un romanzo.
La versione di Mati (Fandango libri) è il tuo ultimo libro. Una commedia esilarante e tutta al femminile. Chi sono le protagoniste di questa storia e quanto c’è di biografico nel tratteggio dei personaggi?
Mati è una ragazzina di 11 anni che ha una madre un po’ troppo perfettina e una nonna che si fa chiamare Totti e va ai party in tacco 12. È una commedia, sì, ma con dentro anche tutte le mie domande (e anche qualche risposta parziale) sulla maternità, sull’educazione, sui ruoli che ci costruiamo addosso. C’è del biografico? C’è sempre. Non racconto la mia vita, ma ci metto dentro le mie ossessioni, le mie risate, i miei inciampi. E un po’ di burraco.
Mati a soli 11 anni vive come una piccola guru: pensa sempre prima di parlare, mangia verdure crude, è esperta di yoga, mansplaining, femminismo e tanto altro ancora. Tutti sani insegnamenti ricevuti da sua madre, con un però di fondo: è stata una mia sensazione o l’estate “sbagliata” e meno educativa in qualche modo le restituisce la spensieratezza della sua età?
Assolutamente sì. Mati è cresciuta con un manuale di istruzioni: mangia sano, respira, analizza tutto. Ma è proprio quando finisce in un’estate “scorretta”, dove nessuno la controlla, che comincia davvero a capire chi è. A volte è proprio il caos che ci riporta a noi stessi. E anche i gelati. E le bugie.

Veniamo proprio ad Alba, personaggio che sembra uscito da un film di Woody Allen. Puoi dirci qualcosa in più su questa donna apparentemente rigida e schematica?
Alba è una madre modello, ma anche una donna piena di ansie sotto controllo. È precisa, è performante, è terapeuticamente irreprensibile. Ma dietro la sua compostezza c’è il terrore di sbagliare, di non essere all’altezza. Alba è la madre che vorrebbe sempre fare bene – e questo la rende sia tenera che un po’ esasperante. Come tutte noi, forse.
Non poteva mancare una domanda su Totti, la nonna Antonia che non vuole essere chiamata nonna. Bionda, elegante e leziosa, campionessa di tacchi, passa il suo tempo tra apericena e feste di gala e il Circolo (covo di serpenti). Un personaggio decisamente sopra le righe ma che ha sicuramente delle sorprese in serbo per chi legge
Totti è il mio omaggio a tutte quelle donne che si rifiutano di diventare invisibili. Bionda, elegante, giudicante e un po’ sopra le righe, vive il suo ruolo di “nonna” come una minaccia al suo ego. Ma sotto la superficie c’è una donna ferita, generosa, e molto più in contatto con la realtà di quanto voglia ammettere. È quella che ti sorprende sempre quando pensi di averla incasellata.
Da giocatore accanito ho riso tantissimo su tutte le situazioni rocambolesche che si intersecano con il gioco del burraco.
Fondamentale! È il campo di battaglia delle relazioni. Le partite sono il momento in cui si dicono verità che altrove non uscirebbero. E poi è anche un modo per ridere delle piccole vendette, delle alleanze strane, degli scivoloni comici che succedono quando le carte girano nel modo sbagliato. O giusto.
Ho assistito al SalTo a un incontro appassionato che hai tenuto anche con studentesse e studenti che hanno più o meno l’età di Mati, quanto è difficile avere una scrittura che abbracci generazioni così diverse?
È una sfida bellissima. Mati parla anche a chi ha 11 anni perché non è mai trattata con condiscendenza. Ma parla anche alle madri, alle nonne, a chi è passato per la preadolescenza e se ne porta ancora addosso le cicatrici e le risate. Io credo che se sei sincera e scrivi con empatia, le storie trovano la strada. Anche tra generazioni che sembrano non avere niente in comune – a parte, magari, un’estate sbagliata.
Gabriele Torchetti

Gabriele Torchetti: gattaro per vocazione e libraio per caso. Appassionato di cinema, musica e teatro, divoratore seriale di libri e grande bevitore di Spritz. Vive a Terlizzi (BA) e gestisce insieme al suo compagno l’associazione culturale libreria indipendente ‘Un panda sulla luna‘.