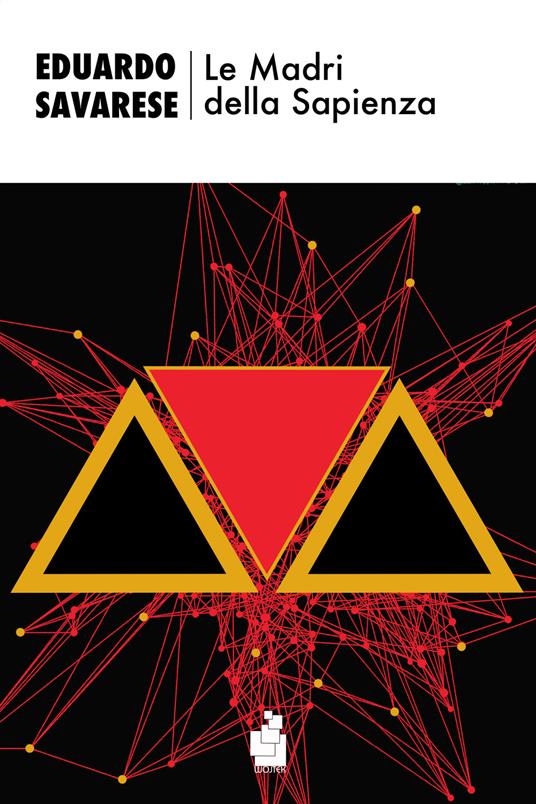Il Salvator Rosa di Daniela Marra.
Cara Daniela,
il ‘tuo’ Salvator Rosa o Salvatoriello è così urgente, potente e vivo che mi è sembrato di poterlo toccare.
Quando chi scrive sceglie oppure è scelto da un essere umano realmente esistito perché freme per essere rimesso al mondo attraverso la scrittura, quando ti immergi nel suo vissuto e ti ispira tenerezza, rimpianto e una sorta di nostalgia indefinibile, quando attraversi la sua unicità umana, questa personalità sono convinta che venga davvero a trovarti. Ti si presenta come una visione sia notte che di giorno mentre sei immersa nella tua quotidianità, può capitare che arrivi verso sera o nelle prime ore del mattino, in certi momenti di vuoto o di silenzio e che ti mormori qualcosa di sé, ti sussurri delle parole in un linguaggio da decifrare, ti consegni senza requie il suo mistero personale da districare, e che arrivi ad urlarti imperiosamente:<< restituiscimi una vita con la tua scrittura!>>.
Come tu stessa scrivi nella nota finale della tua opera: ‘’Il romanzo non vuole essere una biografia perciò in alcuni tratti è la verosimiglianza che fa da traccia narrativa’’, una scelta che condivido e che considero uno dei motivi, ma non l’unico, per il quale il tuo romanzo è prezioso, in quanto in una narrazione storica l’invenzione si mescola sempre alla storia, c’è una licenza romanzesca a cui non si può rinunciare perché fa parte della libertà di poter afferire alla sfera dell’immaginifico, quella forma di libertà e quell’approccio che distingue sempre una romanziera da una saggista (lo dico al femminile volutamente), la quale invece si attiene in maniera esclusiva alle fonti e ai dati documentati. E in questa mescolanza tra il vero, il verosimile e l’immaginifico sei riuscita a catapultarmi, come lettrice, totalmente nel Seicento; ne ho sentito gli odori, i suoni, la bellezza, la ferocia, i fanatismi, l’ingiustizia della giustizia e gli angoli più oscuri, e voglio dirti che trovo tutto questo spaventosamente attuale e per questo motivo mi permetto di definire la tua opera come un romanzo assolutamente moderno di un’autrice che non ha paura, scrivendo, di sporcarsi le mani, di penetrare negli anfratti più tortuosi dell’animo umano.
Non a caso scrivi ancora nella nota finale: ‘’ È emerso prepotente lo smarrimento come sentimento che agitava lo spirito di Salvator Rosa, un sentire non così lontano da quello contemporaneo’’, ed io mi spingo oltre nell’immaginare che in questo senso di spaesamento si possa rinvenire anche un tuo personale interrogarti come scrittrice e come intellettuale sull’aridità, lo svuotamento e il momento tragico del nostro tempo presente.
Le spine del Rosa è quindi un’immersione non solamente nel personaggio di Salvatoriello, ma una reale possibilità di riportare la sua esistenza nella dimensione della Storia, di capire la reciproca influenza fra la mentalità le condizioni di vita e la partecipazione degli esseri umani agli avvenimenti che li sovrastano, come ad esempio quando racconti dell’eruzione del Vesuvio iniziata all’alba del 16 dicembre del 1631 e della barbarie continua della dominazione spagnola.
‘’Fu anche il giorno in cui Napoli uscì dall’Apocalisse dell’eruzione per ripiombare nell’inferno spagnolo.’’

Allo stesso tempo nel romanzo emerge il tuo Salvatore già da bambino e da ragazzino con le sue visioni preromantiche e oniriche che in seguito diventeranno immagini pittoriche di paesaggi, come la visione della prima scena, alla marina, dove il ragazzino è giunto di corsa trafelato dall’Arenella con l’amico Tonino e il fratello Giuseppe.
‘’Il bambino accoglie il bacio del sole già alto, strizzando gli occhi, intanto che i riflessi tra le nuvole punteggiano il cielo di morbide sfumature e contrasti che, disciolti sul paesaggio, ne esaltano le forme. Squarci luminosi infrangono sul mare. Lo stupore blocca il respiro e la contemplazione cancella ogni pensiero nella mente del piccolo Salvator Rosa.’’
Alla stessa maniera avviene la visione quando il tuo Salvatore, già ragazzino al collegio degli Scolopi, prima della cerimonia del noviziato, alla quale lui e Tonino sono in ritardo, intravede scendere da una carrozza una fanciulla di rara bellezza: ‘’Sembra un rosa baciata all’alba’’. E dopo poco dirà a Tonino e al fratello Giuseppe pittore, che lui immagina di dipingerla come una veduta, con parole in cui si rinviene anche la vocazione per la poesia di Salvatoriello.
‘’Una baluginante marina al crepuscolo sotto un cielo di nuvole, gonfie come sbuffi di raso, a incorniciare un roseto toccato da brezza leggera. Con la luce tiranna e regina che attende l’abisso della notte sfiorando le foglie pellegrine…’’
Inoltre procedi nella scrittura dell’opera in maniera al tempo stesso moderna e personale con svariati passaggi cronologici che vanno in avanti e indietro nella vita di Salvator Rosa, e che trascinano chi legge in una dimensione sospesa e vitale che richiama al tempo stesso l’affresco pittorico e il movimento teatrale. Così per esempio quando racconti della notte a Napoli del giovane pittore nella locanda dei Tre Re, quando si ritrova con gli amici Tonino, Marzio e Micco Spadaro (altro importante pittore del Seicento napoletano), e a un certo punto si scatenerà una rissa: allora sarà proprio Salvatoriello a subire una provocazione e ad accendere la miccia, ma il tutto verrà prontamente placato dall’intervento di Aniello Falcone, il grande maestro di pittura, che egli considera come un padre.
‘’Mentre tutto si calma, la furia della colluttazione scema, una lama bastarda si fa strada in direzione della spada di Salvatore. Prontamente viene deviata dalle lame della compagnia di Falcone, all’unisono.’’

C’è poi in questi tuoi passaggi temporali il riferimento romanzato alle lettere che Augusto Rosa, figlio di Salvatore, scrisse all’amico del padre, il commediografo Giovan Battista Ricciardi, durante la sua agonia. Qui si avverte una visione del tuo Salvator Rosa da un altro punto di vista, quello di un figlio che sente la grandezza del padre e la sua difficoltà ad accettare la fine della sua stessa esistenza. Si tratta di una vicenda molto umana che accomuna tutti coloro che in ogni tempo hanno vissuto l’agonia, il lento morire di un proprio genitore o di entrambi.
‘’ Io invece sono consapevole, forse più di tutti, che sta per scomparire. Lo vedo rimpicciolire sempre di più nel suo sudario di lino bianco. A stento ne riconosco la voce, come se provenisse da un altro luogo. (…) È così lui, piccolo di fronte alla potenza della morte, come se provenisse da un altro luogo.’’
Infine c’è la tua lingua, morbida e sensuale, di una qualità sontuosa: c’è un lirismo descrittivo che è in piena armonia con l’elemento emotivo di Salvator Rosa e degli altri personaggi; questa voce d’autrice di grande visività e luminosità è nata silenziosamente negli anni, nello studio accurato e sorretto dalla passione, e questo rende ancora più prezioso questo tuo lavoro narrativo a cui, sono certa, ne seguiranno molti altri.
Grazie di aver condiviso con me i momenti cruciali in cui ti occupavi della stesura del romanzo e di avermi citata per le mie coccole letterarie.
Con stima e affetto
Cristiana
Cristiana Buccarelli

Cristiana Buccarelli è una scrittrice di Vibo Valentia e vive a Napoli. È dottore di ricerca in Storia del diritto romano. Ha vinto nel 2012 la XXXVIII edizione del Premio internazionale di Poesia e letteratura ‘Nuove lettere’ presso l’Istituto italiano di cultura di Napoli. Ha pubblicato la raccolta di racconti Gli spazi invisibili (La Quercia editore) nel 2015, il romanzo Il punto Zenit (La Quercia editore) nel 2017 ed Eco del Mediterraneo (IOD Edizioni) nel 2019. Con Eco del Mediterraneo (IOD Edizioni) ha vinto per la narrativa edita la V edizione del Premio Melissa Cultura 2020 e la IV edizione Premio Internazionale Castrovillari Città Cultura 2020. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo romanzo storico I falò nel bosco (IOD Edizioni), col quale ha vinto per la narrativa edita la XVI edizione del Concorso letterario Internazionale Città di Cosenza 2024. Nel 2023 ha pubblicato il romanzo Un tempo di mezzo secolo (IOD Edizioni), finalista per la narrativa all’XI edizione del Premio L’IGUANA- Anna Maria Ortese 2024. Nel 2025 ha pubblicato Taccuini di viaggio (Cervino Edizioni 2025). Collabora con la rivista letteraria Il Randagio.