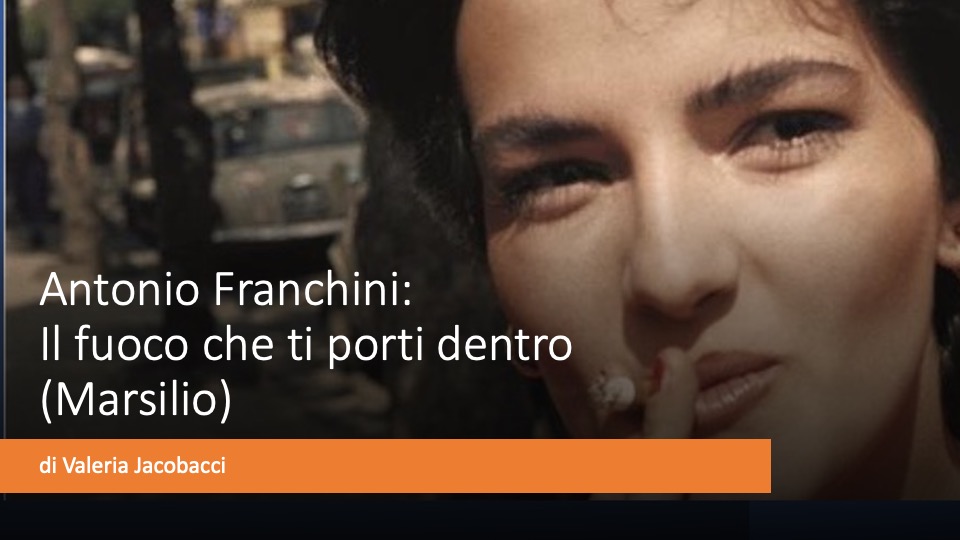Trecentonovantuno pagine di pensieri , sentimenti, emozioni di una giovane donna in un particolare momento della sua vita ma anche della vita del suo paese: ci troviamo nel 1988 a Berlino, lei a Est del muro, lui a Ovest, fra poco il muro crollerà ma nessuno dei due può prevederlo e forse neanche auspicarlo. Infatti nella mente di lei campeggia lui, sono quindi in due nella sua testa ed è lei la protagonista, anche se il romanzo è narrato in terza persona e l’autrice usa sempre il tempo presente, quasi volesse abolire i passaggi temporali per privilegiare il continuum di un flusso di coscienza spiato dall’esterno. Questa tecnica, che fotografa l’istante e lo ferma, potrebbe creare un diaframma fra il racconto e il lettore, lasciando libertà di scelta fra osservazione e immedesimazione ma è subito chiaro che la protagonista resta lei, la ragazza, che un giorno incrocia lo sguardo di uno sconosciuto sull’autobus preso al volo in un pomeriggio di pioggia.

Se la ragazza fosse la Marinella della ballata di Fabrizio de Andrè, “tu lo seguisti senza una ragione…” , il romanzo finirebbe molto prima ma Katharina non è una sprovveduta e non l’attende la morte ma una vicenda amorosa che giunge spesso a fargliela desiderare. In un rapporto asimmetrico nel quale fin dal principio un fascinoso scrittore cinquantenne concede alla bella studentessa universitaria una relazione senza diritti, deve essere soprattutto chiaro che lui si terrà come più gli aggrada una moglie, un figlio, un’amante fissa e molte amiche occasionali. Non le chiarisce che lei non potrà essere libera neanche in parte, del resto alla ragazza non importa. E’ questa la prima chiave d’interpretazione: la manipolazione senza scrupoli del più forte sul più debole, del resto l’autrice chiarisce presto che il professore ha vissuto i primi anni della sua vita durante il nazismo, ha fatto parte della Gioventù Hitleriana.
Sarebbe però troppo facile attribuire a questo la tossicità del rapporto, lui si è allontanato dal modello malefico da molto tempo, è moderno, liberale, simpatico, trasmette da una radio la sua pregevole cultura, ama la musica classica, l’arte e, ovviamente, la letteratura. Gli incontri non sono occupati solo dal sesso, si direbbe che due anime si siano incrociate e che si amino incondizionatamente, al di là del bene e del male, si potrebbe dire. E’ così? Libri, sinfonie e gallerie d’arte sono interessi condivisi, i due bastano a se stessi, sono paghi di sé, si vedono nei caffè e nei ristoranti, la moglie di lui non prova neanche a indagare sulle sue giornate. Fin quando non lo caccia di casa.
Così per un po’ i due stanno insieme nella stanza da studentessa di Katharina, una magnifica Boheme carica di tenerezza. Quando e perché l’idillio finisce? Se solo Katharina fosse capace di approfittare del vantaggio conquistato le cose potrebbero volgere al bene ma, come in tutte le vite, le difficoltà si affacciano a rompere i più miracolosi equilibri. Katharina deve completare gli studi e lui non può perdere la famiglia. Lei si trasferisce per studiare e lui torna a casa. Finisce qui? Troppo facile.
La vita presenta il conto, i due si amano troppo per rinunciare e lasciarsi, bisognerebbe che oltre ad amarsi fossero capaci di volersi bene. Forse non succede quasi mai ma nel caso di questa coppia è davvero impossibile. La città sta cambiando e così accade anche di loro, il crollo del muro non rimette le cose a posto, prima da Ovest si poteva andare a Est e non il contrario, era lui ad andare da lei e non il contrario, una metafora dell’asimmetria del rapporto? La libertà non coincide con i diritti, riconosciuti, per tardi che sia. Così la libertà non è per i due amanti. Katharina vive nonostante, che dovrebbe fare? Ha una storia con un compagno di corso, viene scoperta, pensa di poterne parlare con l’amante come aveva imparato a fare per ogni cosa della sua vita, come se lui fosse una parte non separata di se stessa.

Le conseguenze sono disastrose, lui non è affatto pronto per questo, soffre come mai prima nella vita. La lascia. Lei non accetta, non vuole essere lasciata e dovrà pagarne le durissime conseguenze. L’amore si ammala, come qualunque altra creatura vivente, lei sempre più vittima con colpe da espiare, fino a farsi frustare, a cambiare il sesso in tortura, tradisce ancora, perfino con una donna, non c’è altro da fare. Tutto può finire in un dramma a fosche tinte ma è proprio l’arrendevolezza di Katharina a salvarla, accetta di farsi tormentare anche psicologicamente pur di non essere lasciata. Lui registra cinque cassette della durata di un’ora ciascuna nelle quali elenca le sue colpe alle quali lei dovrà rispondere per iscritto. Sarà mai perdonata? Di cosa deve essere perdonata? Di avere ucciso l’amore.
Alla fine delle cinque cassette tutto è cambiato, la città più di qualunque altra cosa, i locali chiudono, istituzioni, imprese, uffici, vengono chiusi, lui non potrà più lavorare in una radio che non c’è più. Anche questa storia vede la fine, per inedia e disperazione, dopo aver resistito a lungo lei si arrende, e forse anche lui: dopo essersi lasciati e ripresi per tre volte, alla fine l’ultima è la definitiva, forse senza che neanche se ne rendano conto. Un’amara conclusione, in un clima di generale sconfitta. L’ex ragazzino della Gioventù Hitleriana ha avuto una misteriosa vita da spia, della quale lei non ha mai avuto idea. Ora non c’è più niente da spiare. Il muro è caduto. Il crollo è assordante.
Il romanzo ha vinto l’International Booker Prize 2024.
Valeria Jacobacci

Valeria Jacobacci, scrittrice e pubblicista, è appassionata conoscitrice di storia partenopea e di biografie, spesso femminili, di donne che hanno caratterizzato i loro tempi. Si è interessata alla Rivoluzione Napoletana, al passaggio dal Regno borbonico all’Unità, al secolo “breve”, racchiuso fra due guerre. Ha pubblicato numerosi articoli, saggi e romanzi.