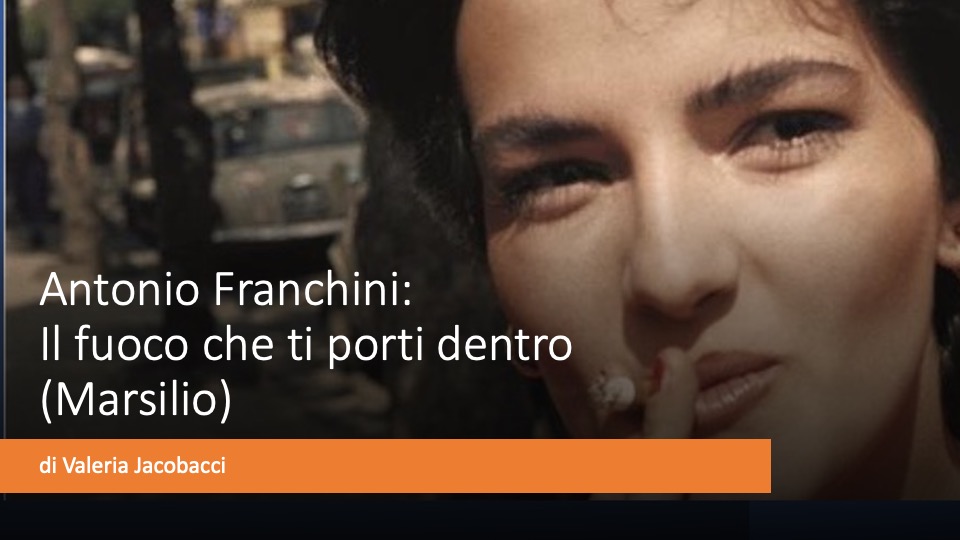IL BITINICCO ARRABBIATO
VITA AGRA DI UNO SCRITTORE IN LIBRERIA
“Datemi il tempo, datemi i mezzi, e io toccherò tutta la tastiera – bianchi e neri – della sensibilità contemporanea. Vi canterò l’indifferenza, la disubbidienza, l’amor coniugale, il conformismo, la sonnolenza, lo spleen, la noia e il rompimento di palle”.
Così scriveva Bianciardi, qualche tempo fa. Io sarò più misurato, mi limiterò a rompervi le palle.
TERZO SBERLEFFO
IL FUOCO CHE TI PORTI DENTRO, ATHOS ZONTINI E ALTRI PARADOSSI DELLA LETTERATURA

Si fa un gran parlare – e a ragione – de Il fuoco che ti porti dentro, l’ultimo romanzo di Antonio Franchini, pubblicato dall’editore Marsilio. Il paradosso che qui s’intende affrontare è che il grosso dei lettori lo considera un nome nuovo – mentre l’autore, classe ’58, una dozzina di libri all’attivo, rappresenta da anni una delle voci più autorevoli del panorama letterario italiano. Gli addetti ai lavori, naturalmente, seguono da tempo il suo percorso, e con crescente interesse – benché, essendo lui un direttore editoriale, non si capisce mai quanto l’interesse sia rivolto allo scrittore e quanto al gigante dell’editoria che in effetti è.
In ogni caso, il fatto che sia poco conosciuto presso il grande pubblico è un fenomeno che desta non poche perplessità. Viene da chiedersi: dov’eravamo noi lettori quando, quasi trent’anni fa, usciva Quando vi ucciderete, maestro? o, poco più tardi, quell’altro capolavoro che ha per titolo L’abusivo? Ve lo dico io. Eravamo occupati a lamentarci. A guardare con nostalgia alla letteratura del passato rimpiangendo, che so, i Buzzati, i Cassola, i Bianciardi dei cosiddetti anni d’oro. Per non dire dei tre imprescindibili nomi – citati spesso congiuntamente, e quasi sempre a sproposito – Pasolini, Sciascia, Calvino. E forse, era solo un alibi di comodo per evitare di misurarci con un nuovo modo di fare letteratura.

Intanto, Franchini, ma anche Albinati, Walter Siti, Emanuele Trevi, Eraldo Affinati sfornavano un gioiello dopo l’altro. A distanza di trent’anni da Istruzioni per l’uso del lupo, Maggio selvaggio, Il contagio, Campo del sangue, Scuola di nudo, questi scrittori sono ormai entrati a far parte del canone letterario, ottenendo perfino riconoscimenti di grande prestigio – per quanto, in alcune circostanze, i libri premiati non fossero i migliori della loro produzione. Insomma, una sorta di elogio alla carriera. Ed è probabile che un domani, paradossalmente, sentiremo ancora ripetere la solita nenia, questa volta dedicata a loro, i venerati maestri del futuro: non ci sono più i Franchini, gli Albinati, i Walter Siti di una volta! Dimenticando di aggiungere che quando pubblicavano le loro migliori opere erano ignorati dai più.
Parallelamente, alcuni giovani ma già solidi autori stanno compiendo un percorso artistico di notevole interesse. Per ora ci limitiamo a ignorarli. Più in là decideremo se dare loro un premio.
Un titolo su tutti? Orfanzia (Bompiani, 2016), di Athos Zontini. Un capolavoro. Dimenticato, ahimè.
Ecco il punto. Ho la sensazione che l’industria culturale abbia talmente concentrato l’attenzione sul presente (sulle vendite, in particolare, da realizzare nell’immediato) da non concedere a uno scrittore la possibilità di trovare il proprio pubblico per dare vita a un dialogo sincero con i lettori. Lo stesso Franchini qualche anno fa scriveva: “Molte opere uscite dal dopoguerra all’inizio degli anni Sessanta hanno avuto tutto il tempo di farsi assorbire, di entrare nelle fibre profonde della società come una pioggia autunnale lenta e nutriente che imbeve il terreno poco alla volta”.
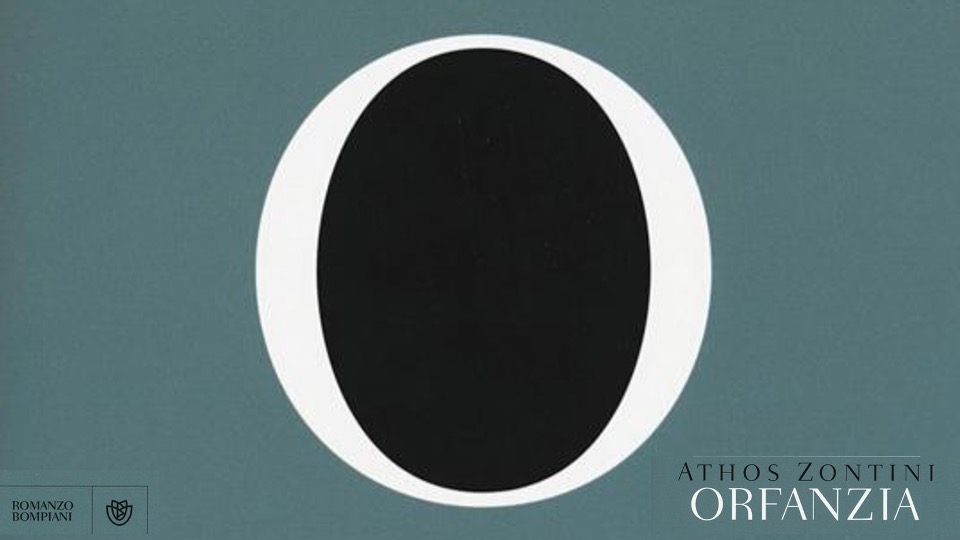
Un libro, oggi, pochi mesi dopo la sua pubblicazione, è già considerato sorpassato. Nessuno più si mostra interessato ai temi che approfondisce, tanto meno all’autore che li affronta: né la critica, subissata di nuove uscite; né i librai, per la medesima ragione; né i lettori, che dalle proposte degli uni e degli altri dipendono. Non a caso si parla di novità del momento, perché sembra che la loro vita duri in effetti il lasso di un momento. Se una novità non fa immediatamente il botto – qualunque cosa voglia dire – è destinata a morire. Come se la letteratura, dopo secoli passati a indagare il Reale, inseguendo una qualche possibile forma di Verità, per quanto dolorosa, si debba oggi accontentare di esprimere un’arte minore, l’incomprensibile arte di fare il botto.
E se cominciassimo a prenderci cura dei giovani autori? Leggendoli senza l’assillo di attenderci l’opera che cambierà il destino della letteratura? Dando non solo a questi scrittori il tempo di maturare, ma anche ai lettori la possibilità di seguirli nel loro percorso, crescendo insieme. Invece di abbandonarli a uno spietato quanto spesso ingiustificato oblio, dopo qualche mese di chiacchiericcio, per dedicarci con altrettanto fervore al nome successivo, e così via, in un circolo vizioso che non fa bene a nessuno. Eccetto ai bottegai dell’editoria, i rabdomanti del botto.
Ed evitando così di lamentarci un domani con il più stucchevole dei piagnistei: non ci sono più gli Zontini di una volta!
Davide D’Urso
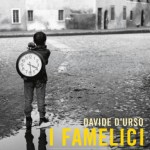
Davide D’Urso. Scrittore, libraio, operatore culturale. Dal 2013 dirige il punto vendita flegreo di Librerie.coop. Ha pubblicato “Il paese che non voleva cambiare” (Manni, 2007). “Incontri notevoli di un libraio militante” (Valtrend, 2012). “Tra le macerie”, (Gaffi – Italo Svevo, 2014). “I famelici” (Bompiani, 2021). “Fuoco sulla città” (Ad Est dell’Equatore, 2013) include il racconto, “Fuocoefiamme”. Nel 2022 viene scelto da Filippo La Porta per l’antologia “Gli occhi di Napoli” (Iod, 2022). I contigui è pubblicato all’interno dell’antologia “Napoli stanca”, a cura di Mirella Armiero (Solferino, 2023).