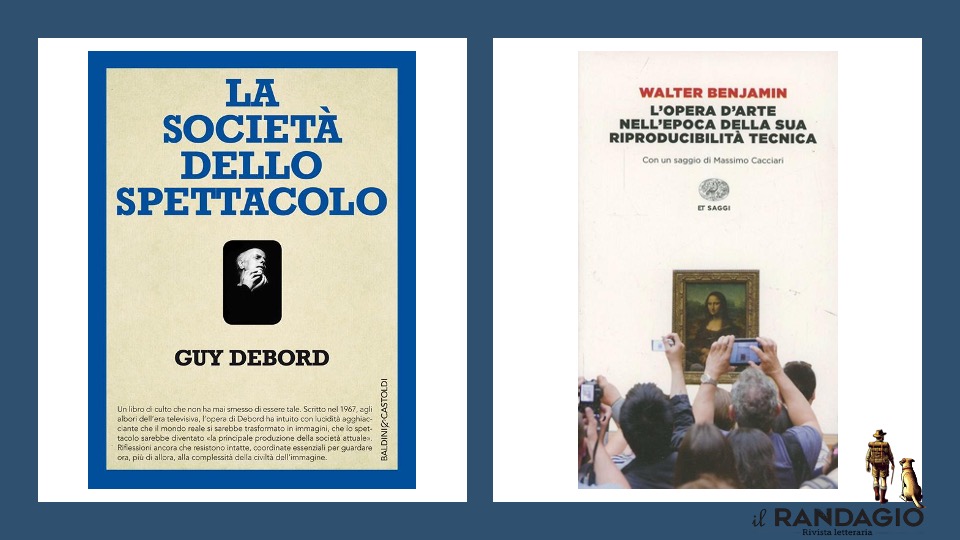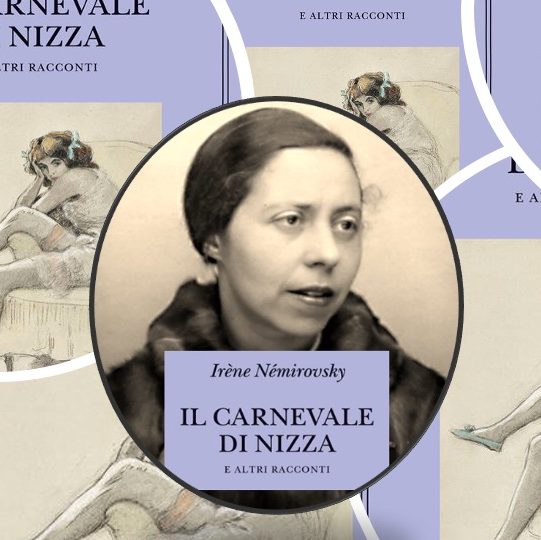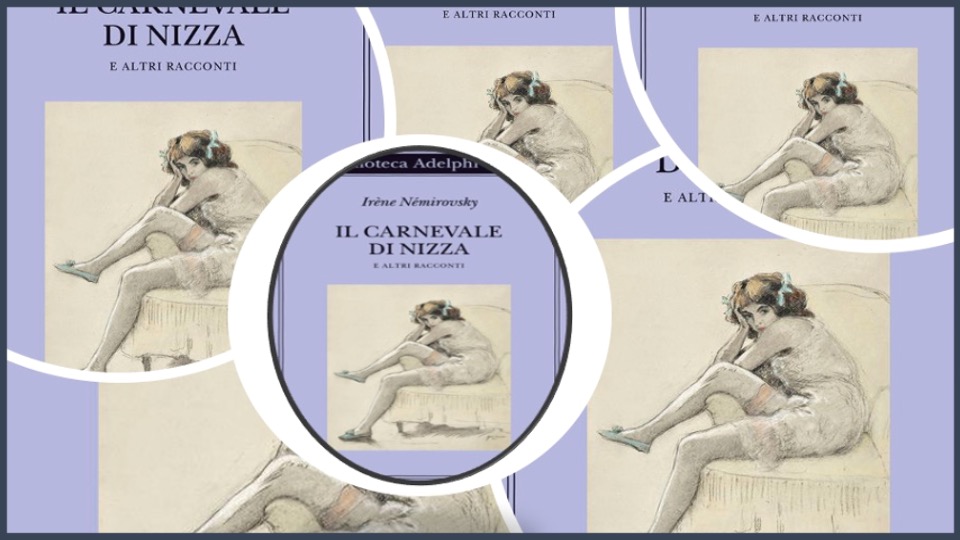the capture
the rapture
the rupture
of a soul
( Sarah Kane)
Il libro, tra i mille esposti sugli scaffali di una libreria, sta lì nascosto e divorato da altri libri che si accasciano l’uno sull’altro, senza tregua, in una babele di colori e dimensioni. Mani distratte a volte lo toccano, lo sfiorano per poi lasciarlo ricadere, attratte da altro. Eppure, quel libro è un piccolo scrigno pieno di gemme fatte di parole e suoni, di alchimie intense come i profumi della lavanda e delle rose.

Lo sa chi ne ha seguito il farsi pagina su pagina, e da allora, passando da sguardo a sguardo, ha deciso di prendersene cura; quel libro pian piano emerge dal buio silenzioso, comincia a girare tra mani pronte a sfogliarlo, a segnarlo con matite variegate, pone domande in cerca di risposte. La sua strada viene protetta dal tam tam delle lettrici (tante) e dei lettori, dagli incontri nelle piccole librerie e da recensioni che si affollano liete di dar vita a un banchetto dove le parole invitano ad addentare i mille strati su cui poggia il romanzo.
Io, da lettrice appassionata, le colleziono, quando, terminato il libro in solitudine, avvolta nel silenzio notturno, desidero riattraversare il testo lasciandomi guidare dagli sguardi di lettrici appassionate con le loro mille sottolineature, angolazioni sghembe, passaggi preziosi, punti di fuga, pennellate di dolore, buio e luce, rosso e bianco, vita e morte. Con loro posso riabitarlo, così come in una nuova casa si prova gioia a legare oggetti della vecchia abitazione con nuovi, scelti con cura, per farla propria e starci comoda.
L’ultima pagina di Padre terra si è chiusa tra le mie mani.
Riordino, veloce, le note appuntate sui fogli volanti, è tempo che io scriva.
È tempo che io fissi il flusso dei miei pensieri, Padre terra aspetta le mie parole (mi piace pensare)
Attende la mia lettura (mi piace pensare).
Sa di avermi travolto di domande (mi piace pensare).
Sa che ho cercato le risposte radicandomi nella mia storia (mi piace pensare)
Sa che tenterò di dar vita a una trama a maglie larghe dove l’arte di tessere fili, riannodandoli, non più scollati tra loro, renda possibile mille e mille riletture preziose, simili ad arazzi in fieri (mi piace pensare).
Primo filo: il luogo dove la storia si dipana
Siamo in un piccolo paese del Polesine, lungo le sponde del fiume Adige; un mondo contadino, con i suoi riti legati alla campagna, i lunghi inverni freddi e le estati torride, lo abita. Giovani e vecchi si muovono attraversando la piazza del paese vociferando notizie liete e brutte, animando chiacchiericci malevoli e benevoli, piangendo i morti e festeggiando matrimoni. Tra questi quello di Rosalba e Primo, due giovani, simili a tanti altri, ligi ai comandamenti e alle usanze della comunità. Ma, perché ci sia una storia da raccontare, un evento deve cambiare il lento scorrere uguale della vita: la disperazione in cui cade Rosalba, per l’attesa spasmodica di un figlio che sembra non voler mai arrivare, fermerà la ruota ciclica del tempo invertendone la direzione.

Secondo filo: Rosalba, la Botanica
Una donna è al mondo per generare figli, nutrirli e farli crescere da buoni cristiani: lo dice il parroco dal suo pulpito domenicale, lo ripetono tra loro le donne del paese che aspettano, cianciando, la notizia che Rosalba non poteva dare. Il suo utero si ribellava ogni mese alla legge che lo voleva gravido, continuando ad espellere sangue rosso e vivido, a bagnare, in segno di sconfitta, i panni che volevano restare bianchi a festeggiare l’impianto di una vita; più il tempo passava, più il suo essere infertile “era ancora peggio di una gamba storta o di un braccio monco”.
Inutile provare preghiere, digiuni e riti, visitare chiese e cattedrali, far dire messa, seguire i precetti della liturgia agreste, dal rito del Corpus Domini alla preghiera dell’Erbo divino. Il miracolo non arrivava, mentre, crudeli, si affacciavano i bisbiglii del paese, le voci maligne rimbalzavano, schiacciando i due sposi sotto il peso di un giudizio che li crocifiggeva all’infertilità.
La linearità della storia, ancora una volta si interrompe, un punto di fuga spalanca una prospettiva altra: la ribellione imprevista di Rosalba al destino che la vuole non madre. Andando contro i dettami della Chiesa e le paure di Primo, la giovane sposa si affida alle pratiche della Botanica, accusata dal paese di essere una stria e, condannata per questo a girare raminga nel paese in cerca di cibo e alloggio. Sarà lei a rivelarle che è il sangue mestruale, quel flusso rosso, interpretato stoltamente come radice di prodigi negativi, a generare la vita, una volta innestato nel grembo materno, insieme a una mistura di erbe sapientemente mescolate. Prima di agire sull’umano è necessario, però, saggiarne la forza attraverso un rituale con regole precise da seguire: piantare intorno alla casa dei gerani rossi e testare su di essi la vitalità del sangue. “Se il sangue mestruale fosse stato buono, fertile, le talee nuove avrebbero attecchito gerani… gerani regali, gerani parigino, gerani odorosi con le piccole foglie frastagliate e aromatiche, ma tutti i fiori dovevano essere rossi come il sangue”.
La forza oscura della natura risponde, Rosalba resta incinta. Il paese si rallegra “non ravvedendo più stranezze in quel matrimonio che finalmente stava portando frutti”.
Non si aspetta altro che il momento del parto.
Ed è qui che Barbara Buoso ci colpisce violentemente, non grida di gioia, non fiori al Signore per celebrare la nascita, non fiocchi colorati sulle porte del paese ma scene cruente dove il corpo della madre si sgretola, si spacca, si contorce, maciullato in un’oasi di dolore senza fine. L’umano si fa animale, la bocca si storce in “un barrito strozzato e perdurante che negli acuti somigliava a quello del falco che suo padre, quando lei era bambina, teneva prigioniero, legandogli una zampa, e che si era dimenato fino a strapparsela”.
Il rosso si riprende la scena; quel rosso, cancellato dagli scampoli dei panni issati al sole ogni mese come una sconfitta, splendente nei gerani che incendiano anche in pieno inverno la casa, ora svuota il corpo materno, bagna le candide lenzuola stese sul letto per accogliere la vita. “Talvolta si nasce nel sangue, quando il sudario di una donna che mette al mondo un altro essere umano diviene il suo ultimo giaciglio”. (Alessandra Pigliaru)
Rosalba e la Botanica fluiscono via dal racconto lasciando visibili le loro tracce nella parete rosso fuoco che cinge la casa. Primo e, con lo scorrere del tempo, il figlio Giovanni, la proteggeranno dai venti, dal caldo, dalla neve perché possa raccontare di un incantesimo nato tra due donne lontane, per la loro storia, l’una dall’altra.
Entrambe hanno saputo porsi in ascolto, tessendo una relazione silenziosa fatta di gesti e pratiche millenarie affondanti le loro radici nel linguaggio segreto della natura. Entrambe, nella tensione di potersi dire, una come madre, l’altra come guaritrice, hanno agito senza arretrare, abbattendo ogni tradizione.
La Botanica, stando salda nel suo sapere che affonda le radici in lontani culti trasmessi da donna a donna, lungo un matriarcato di cui si sono perse le tracce, non si è sottratta alla richiesta di aiutare a mettere al mondo una vita. In questo “maneggio di ardimentosa complicanza” il grembo femminile è posto al centro, in continuo dialogo con la natura che lo irrora e nutre. Rosalba ne accoglie la forza, il suo corpo si lascia spossessare, diventa ventre gravido e mammelle turgide, destinate a dare nutrimento.
Ma le due donne sono destinate a non pacificarsi con il loro desiderio; Rosalba scivolerà nella morte e la Botanica, sottraendosi alla furia del paese che la riteneva unica responsabile, riprenderà la sua vita randagia.

Terzo filo: Primo e Giovanni.
La morte di Rosalba, la scomparsa della Botanica consegnano definitivamente il bambino alle braccia di Primo, rimasto solo ad allevare Giovanni, dopo che il paese e anche la nonna materna lo hanno rifiutato ritenendolo frutto di un sortilegio diabolico.
Primo sarà padre ma anche madre. Affettività, cura, accudimento, tenerezza, tutta la sfera del materno sarà accolta da lui; imparerà ad allattarlo “con le maniche della camicia arrotolate, prendeva un asciugamano pulito, se lo metteva sulla gamba e poggiava il piccolino nell’incavo ulnare, quell’ansa naturale che pareva la curva dell’Adige… poi prendeva in bocca il ciuccio del biberon per scaldarlo prima di darlo al piccolino”; a sussurrare nenie, ricamando “sillabazioni onomatopeiche buffe” suggeritegli dal borbottio della pancia, satura di cibo, del piccolo. Saprà pian piano come e cosa insegnargli cercando nella natura la grammatica da trasmettere al figlio riconnettendosi a quel sapere trasmessogli da un padre silenzioso e severo “in quell’incessante discorso che il creato fa ad ogni uomo e che spesso, presi dalla foga della vita, in molti non percepiscono più”. Seguire l’alternanza delle stagioni, curare la terra e i suoi frutti, rispettare i cicli della vita, ascoltare le voci che animano il paesaggio, i richiami e il cicaleccio degli uccelli, lo strisciare degli animali sull’erba, la pazienza e la fatica dell’aratro che avanza rivoltando le zolle, diventa il modo in cui, giocando, Giovanni conosce il mondo. Se il padre gli insegna presto a usare la lingua “legata ai bisogni primari dello stare al mondo come mangiare, dormire e lavorare la terra”, lui tiene per sé l’altra lingua quella con cui dialoga con la madre, ritrovandola nel gorgheggiare delle anatre, nel lamento delle lepri, nel fruscio del vento. “Gli era stato dato in sorte di continuare a percepire l’amore di sua madre attraverso la terra, avvertendo ad ogni istante la gratitudine di essere lì, al mondo”. La madre, però, ha scelto di abitare “in alto molto più in alto dell’ultimo piolo della scala” e Giovanni è certo che lassù, da sola, si annoiava. Come raggiungerla per strapparle un sorriso? Forse basta alimentare un boato tanto forte da salire in cielo e farle visita. Così, in segreto, ogni sera, Giovanni si esercita a far esplodere bombolette spray e aspettare il giorno dopo, per scavare, tra le carcasse annerite, una traccia.
Un rito consolatorio e salvifico, una corda tesa tra cielo e terra.
Quarto filo: la violenza dei bulli, l’uccisione del maiale, Michele.
Nell’assumere simbolicamente la funzione materna, Primo ha impedito a Giovanni di assumere una virilità prevaricatrice e violenta, coltivandone la tenerezza e l’ascolto. Scelta che destina entrambi all’esser strano, folle e straniero per la comunità di uomini e donne del suo paese: un padre che è madre al contempo, un bimbo che parla con le piante, il vento, gli animali, due creature mosse e animate dalla cura verso ogni cosa che li circonda.
Ma la violenza del mondo degli uomini bussa presto, non fa sconti.
Barbara Buoso declina le stazioni del dolore, ricordandomi quelle che Cristo scala nella sua salita al Golgota o gli intoppi dei grani del rosario cantati in maggio; ogni scalino, ogni pausa cantata, la scuola, l’uccisione del maiale, la tenera amicizia con Michele le saliremo, le canteremo con lui.
Ogni tappa ci rimanderà un mondo stupido che parla la lingua dell’ignoranza e della brutalità. Un mondo impermeabile che resta sbigottito ogniqualvolta padre e figlio sapranno agire scoprendo una possibilità altra di esserci.
Le stazioni del dolore muovono dalla scuola: un luogo dove Giovanni non verrà mai accolto per il suo essere fuori da ogni schema di mascolinità tradizionale, per il suo amore per la scrittura, capace di volare oltre le parole consumate dall’uso, per librarsi, alla ricerca delle corrispondenze, nelle creature che abitano il mondo umano, vegetale, animale.
Quando, in palestra, giunto alla scuola superiore, Giovanni, come Cristo in croce, verrà picchiato e denudato, non si difenderà ma ergerà il suo corpo fragile e nudo come unico scudo ai colpi violenti che cadono a pioggia su di lui “«Su, datemene ancora». Giovanni scoppiò a ridere, di un riso che gli partiva dal profondo, dai gerani piantati davanti a casa, dal maiale che urlava disperato prima di morire, dal mistero attorno alla fine di sua madre una risata i ragazzi si fermarono stupiti: quindi era vero che era matto. Non serviva opporsi agli eventi la sopraffazione era nell’ordine naturale delle cose”.
I compagni, incapaci di schiodarsi da una mascolinità tarata, che li rende forti solo se raccolti in gruppo, lo tacceranno di esser matto perché la follia, si sa, non fa male, non smuove domande, basta solo tenersene alla larga.
La seconda stazione arriva ancora più dolorosa. Giovanni deve uccidere un maiale secondo un rito di iniziazione che ogni ragazzo del paese, compiuti i 13 anni, era spinto ad affrontare per diventare uomo e guadagnarsi un nome tra gli adulti.
Primo, stavolta, si muove lungo il tracciato disegnato dalla comunità; troppo forte risuonava in lui la memoria dei gesti tracciati dal padre, appresi da piccolo, seguendo una pratica collettiva dove ogni movenza rinviava ad un sapere antico, dove ci si riuniva “per condividere anche solo un osso, parte della cotenna, una zampa”. Si faceva festa, si cantava tutti insieme e si celebrava la morte che donava la vita. Giovanni, Primo ne era certo, non poteva sottrarsi alla prova, doveva mettere a tacere una volta per tutte le voci sulla sua strana nascita ed entrare a far parte del mondo degli adulti
E Giovanni? “Non voleva dargli un dispiacere, si rendeva conto di quanto avesse sofferto per le malevoci sulla sua nascita […] e, di quanto lo ferisse, in chiesa, trovarsi davanti a persone che si facevano il segno della croce vedendoli”.
I giorni che precedono il rito passano in una quiete irreale materiata degli oggetti e delle pratiche necessarie per dare la morte:
La meticolosità degli atti da compiere per uccidere il maiale ricordano a Giovanni quelli del parto: “il riscaldamento dell’acqua, la predisposizione della pila di panni bianchi immacolati, le bende da marchese stirate. Al posto della levatrice un norcino”. Una similitudine dolorosa con cui riporta se stesso a quel momento preciso in cui, lanciando il suo primo vagito, portava alla morte la madre. Chissà “se sua madre sul letto di morte, all’idea di poter salvare almeno il bambino, si era sentita come il maiale, pronta a morire sapendo che quel suo gesto le avrebbe garantito il paradiso”. Una delle tante domande senza risposta che si agitano nella mente di chi attraversa la vita da orfano e portatore di morte insieme.
Quando il sangue che svuota la vita rioccupa, prepotente, la scena e l’accoratoio lungo e appuntito sarà stretto tra le sue mani, Giovanni si ritrarrà, rifiutandosi di compiere un sacrilegio. “Le fronde degli alberi piangenti non gli avrebbero più sussurrato parole, si sarebbero ammutinate, le spighe del grano maturo non avrebbero più palpitato, al calar della sera”.
Ancora un punto di fuga, ancora una prospettiva imprevista, una rottura silenziosa contro la violenza degli uomini, una nuova nascita. “Lì, il seme della cura di Primo si spacca e Giovanni assieme alla storia inizia a cercare la sua fioritura: lì Giovanni si rivela e di lì si rinnova, irradiandosi in ogni direzione”. (Silvia Belcastro)
La terza stazione si srotola seguendo l’amicizia nata sui banchi della scuola media tra Giovanni e Michele, un ragazzino isolato da tutti, perché fratello di un poco di buono, finito in carcere per spaccio di droga e lì ammazzato in modo misterioso. “I due si capirono subito nei reciproci silenzi… a vederli sembravano due fratelli, come fossero nati da una nassa in mezzo all’acqua, e, come pescigatto con le pance rosolate dal sole guizzavano lesti verso la giovinezza, che pareva essere il loro unico destino”.
Gli sguardi degli uomini del paese cominciano a seguirli mentre leggeri, sfiorandosi appena, si lanciano spensierati a correre nei campi, in una infanzia che vibra verso l’adolescenza, “coi loro volti color miele, coi piedi liberi da lacci e impedimenti, le mani a raccoglier foglie come fossero coriandoli”.
Gli sguardi diventano bocche che vomitano parole tremende “quei due cueatìna si nascondevano nei campi per fare balletti da femmine in calor”.
L’abbracciarsi, il mettersi le mani addosso nella lotta affannosa dei corpi, il correre nei campi lì dove, invece, doveva aver spazio solo la fatica del vivere era una stranezza da condannare. Toccava al padre di Michele raddrizzare ciò che andava raddrizzato: con la stessa violenza con cui, con l’incudine e il martello, si mettono a posto i chiodi storti, andava estirpata quella amicizia fuori natura, andava tagliata ogni relazione mandando la feminèa a lavorare in Grecia sotto padrone: lì, lavorando fino allo sfinimento, si tornava uomini.
Michele, prima di partire, saluterà il suo unico amico con parole impetuose e cariche di sogni, quasi a rassicurare se stesso, lanciato ragazzino in un mondo di adulti, sconosciuto: la loro amicizia non avrà mai fine, dirà, accumulerà tanto denaro da poter comprare in Grecia una casa dove accogliere le persone a lui care, una casa come porto sicuro, lontano da ogni mareggiata, dove accudire, dar da mangiare e vivere felici.
A Giovanni le parole suoneranno, invece, come “il vento cattivo di tramontana, o le nuvole minacciose che portano la grandine… però quelle di Michele erano parole umane, uscite dall’alfabeto… parole imparate per poter fare del bene, per esprimere amore, amicizia, bellezza, e che ora gli stavano portando dolore: erano parole che non capiva e non avrebbe mai compreso”.
Michele tornerà.
Ma, vuoto di parole e con un gesto da portare avanti: chiudere la vita dell’uomo che pretendeva di esser chiamato padre.
Su quella famiglia c’è davvero la maledizione del diavolo, commenterà sbigottito il paese, incapace di dare un nome altro all’accaduto.
Ma era maledizione o violenza perpetrata in silenzio? Bastava alzare lo sguardo e soffermarsi sul corpo di Michele per trovare una risposta.
La sua pelle, non più color del miele ma incendiata dal sole, raccontava l’orrore dello sfinimento nei campi, la solitudine di una adolescenza bruciata lontano da casa, sotto il segno di una sofferenza continua. E il padre, di quei segni, ne era stato fiero: di quelle stigmate doveva ringraziarlo, aveva detto, perché solo spaccandosi la schiena si imparava a stare al mondo.
Quando Michele lo colpirà al cuore e alla gola, muovendosi in un silenzio assordante, come in una placenta lattiginosa, pronta a nutrire la sua ribellione, il sangue del padre schizzerà impetuoso, gorgogliando sulle pareti della cucina, come il sangue del maiale che esce, impetuoso, nel rito che porta alla vita adulta. Perché i ragazzi, diventati adulti, sanno uccidere senza un briciolo di tremore, quando la violenza di chi ti ha messo al mondo e dovrebbe proteggerti, ha bruciato ogni sogno di vita futura.
“Caro Michele, sono il tuo amico Giovanni. Come stai?”.
Così scriverà a Michele, rinchiuso in carcere, ricucendo il filo strappato.
Sono il tuo amico: una rete di connessioni di consonanti e vocali che sanno di gioco, di corse, di capriole infinite, di attesa, di fiducia, di gelati guadagnati dopo un giorno di lavoro nei campi.
E poi, ancora quasi a voler rompere le sbarre che lo inchiodano per sempre all’impotenza del movimento, — la meraviglia dei suoni, quelli condivisi nella loro estate, “i suoni non si possono imprigionare… se ti metti all’ascolto puoi sentirli. Strisciano sotto le porte, si infilano negli ingranaggi delle serrature, più sottili della sabbia del mare, e ti portano ciò che non puoi raggiungere. Pensa che meraviglia. Frush, frush, frush, frush, frush. (Ti lascio qui il rumore del vento)”: parole salvifiche parole àncora a cui legarsi per risalire a quella luce, che simile a un puntino luminoso fa capolino dal buio profondo.
Quinto filo: la struttura musicale
Sui suoi quaderni che si allineano preziosi, Giovanni racconta di sé e del suo mondo. Scrivere, ha scoperto nei suoi primi passi scolastici, è incidere segni sulla pagina bianca, intaccare la superfice scura della lavagna con il gessetto. “Alla mattina le lavagne erano bellissime, nere immacolate, con tutti i segni ancora da scrivere, tutte le parole ancora da dire; erano come i galleggianti che progettava per comunicare con sua madre, erano le lenze che avrebbero percorso i cieli permettendo alla voce di rendersi udibile all’orecchio umano”.
Una volta catturata, Giovanni la muove su terreni inesplorati; tradurre i suoni che la natura produce e che l’uomo non sa più udire, travolto dal travaglio, dalla fatica dura e inclemente che la terra richiede per sfamare e sfamarsi dalla terra.
Nel dialogo incessante tra sé e i suoi fogli, annota suoni, onomatopee di lingue sconosciute e, come Pollicino seminava le briciole di pane per ritrovare la strada giusta verso casa, noi seguiremo l’alfabeto creato da Giovanni per non smarrirsi nel nido sicuro della voce del vento, delle foglie che si muovono, degli innumerevoli richiami degli animali. “Fruscio del vento tra i rami di un albero in piena estate quando lei mi vuol fare una carezza: frush, frush, fruuuush, fruuuuusf. Frustata di vento che, improvviso, chiude una porta: stonk. Gioia di una porta che si apre: iupp! Ululare del vento quando la sera si è a letto e c’è un po’ di paura: swoosh, swoooooh, swoooooosch …”.
Una partitura musicale, in cui tutto ciò che fluisce, rimbomba producendo meraviglia.
Una lingua che restituisce l’ascolto, prima ancora del nominare.
Una lingua faticosa da scovare, senza la quale il creato non avrebbe più parola.
Una lingua dell’infanzia, aurorale, capace di volare, di entrare profondamente in noi, di creare un incontro, di riportarci a quella matrice antica, la cui origine dimenticata riaffiora a chi sa prestare ascolto.
Sesto filo: la morte di Primo, la scoperta dell’amore
“Papà non riesco nemmeno a descrivere lo sfacelo della mia vita senza di te”.
Affiora la prima grande smagliatura tra il dover essere – il mondo delle cose, dei doveri, dei progetti da portare avanti – e il bisogno di essere appallottolato, accartocciato, raggomitolato su di sé, senza voler trovare il bandolo da cui iniziare a srotolarsi e vivere.
La condizione di orfano lo ha reso privo della voce rassicurante del padre, dei suoi sguardi protettivi, della comunione delle mani che travagliano, delle abitudini che scaldano il cuore. Giovanni è smarrito, non riesce più a rientrare nelle voci del padre e della madre, diventate silenti. Si sente colpevole, inadeguato, incapace di salvaguardare l’immenso lascito del padre. La natura gli appare ostile, quasi matrigna.
Barbara Buoso dà all’amore il compito di arginare il dolore.
Elisa, che coltiva fiori nel suo piccolo negozio, componendoli in organature volte a dar loro un ordine e una geometria fatta di colori e profumi, riporterà in equilibrio la sua esistenza, lo aiuterà a scoprire la gioia dei corpi che si cercano, delle lunghe camminate, tenendosi per mano, del potersi raccontare senza tema di esser giudicato, del parlare della propria nascita, ritenuta sortilegio. Le bastò dire “che la natura offre le sue magie solo a chi è capace di accoglierle”. Con lei e attraverso lei Giovanni accetterà il suo andare verso la vita adulta, attraversando il dolore della perdita, perché la vita è nutrirsi di sentimenti mai gridati eppure profondi come la radici che si piantano nel terreno e alimentano la crescita, e accettare che pazzia e lucidità, buio e luce, si danno la mano.
Barbara Buoso, Padre terra, Fernandel, Ravenna, 2024
Giovanna Senatore

Giovanna Senatore: laureata in Filosofia, ha insegnato Storia e Filosofia nei licei classici; formatrice in corsi di aggiornamento per i docenti lungo due tematiche: la letteratura attraverso lo sguardo del pensiero femminista, l’uso dello spazio e del linguaggio teatrale. Ha guidato laboratori teatrali in qualità di esperta in vari istituti scolastici. Fonda l’associazione culturale “Le macchine desideranti” curando la regia di tredici spettacoli dove corpi e parole possano colpire nella loro nuda e secca forza. Ha curato laboratori di scrittura a partire da testi incrociati di scrittrici che hanno ricamato tessiture preziose. Venerdì 23 maggio, al teatro Bolivar di Napoli, va in scena il suo ultimo spettacolo “mai SUPPLICI”.