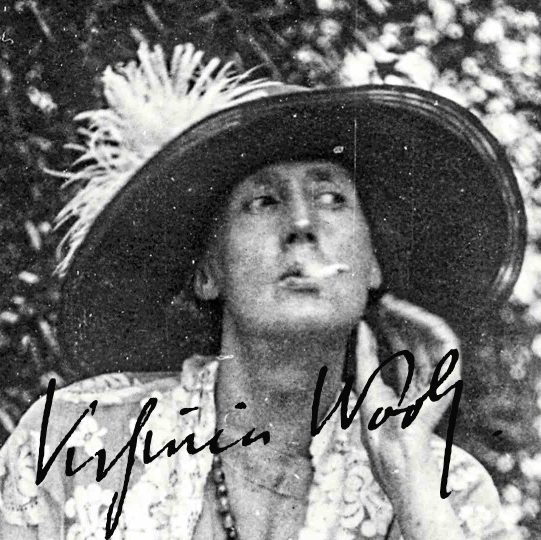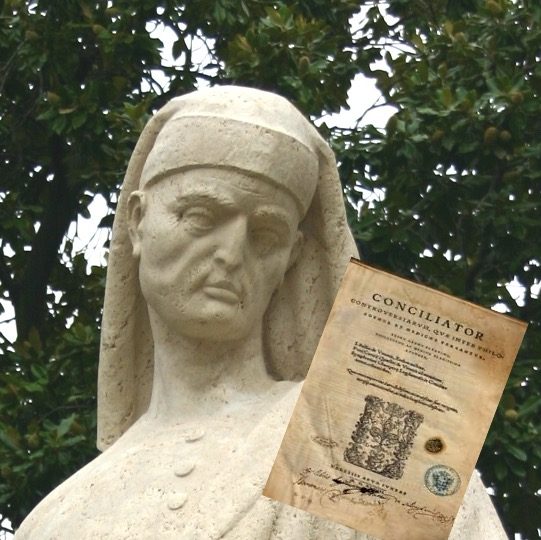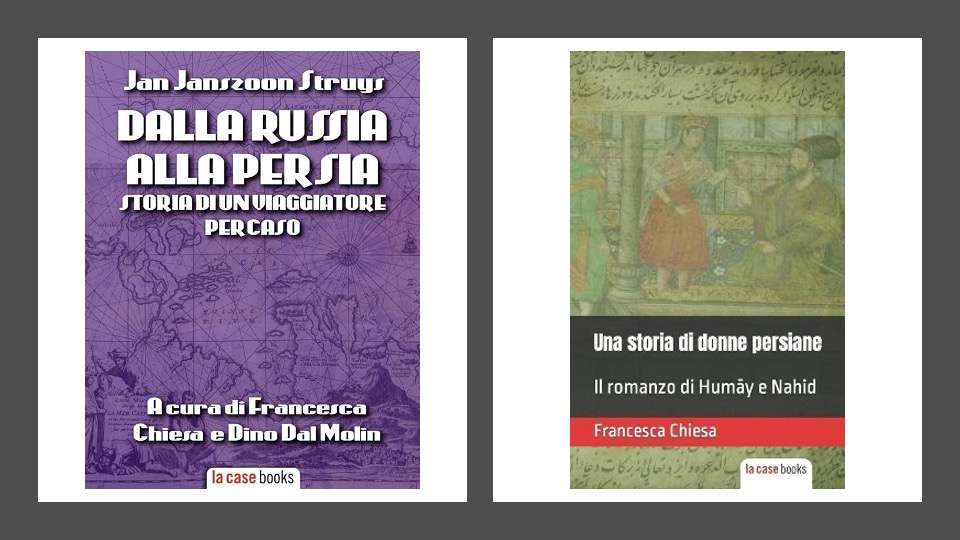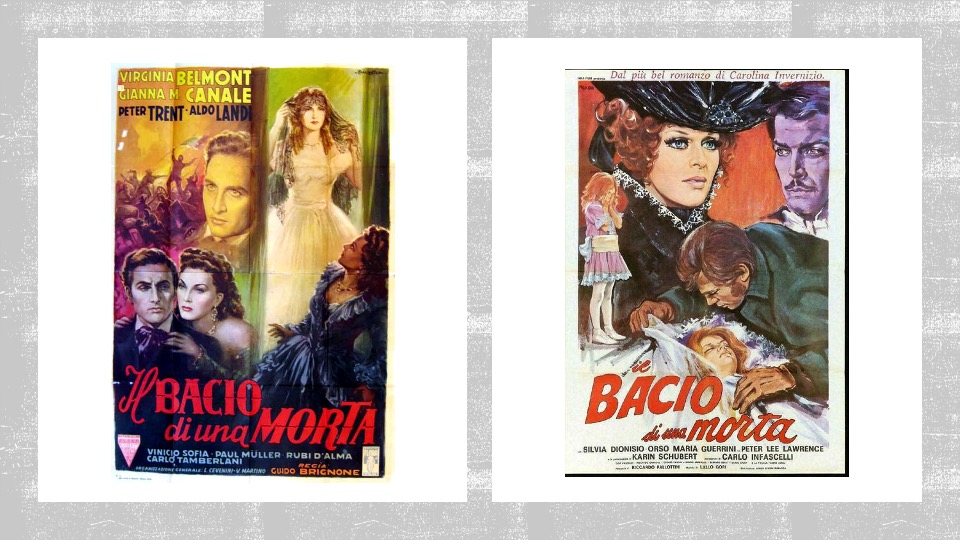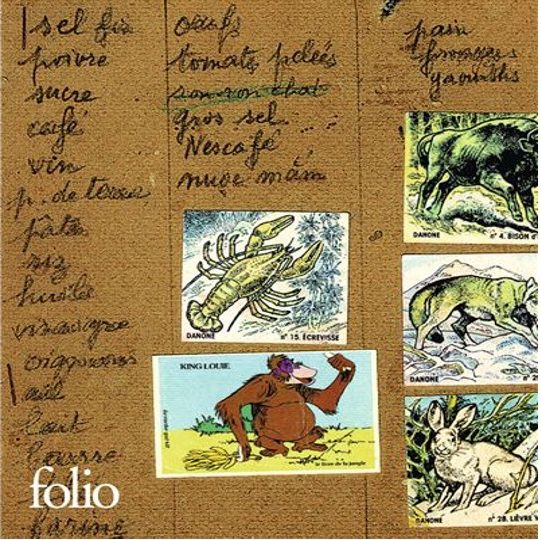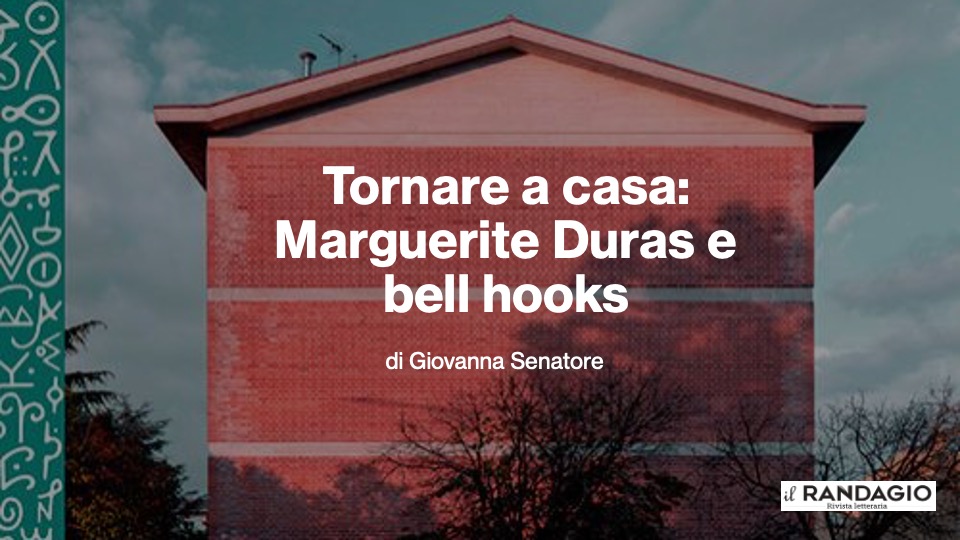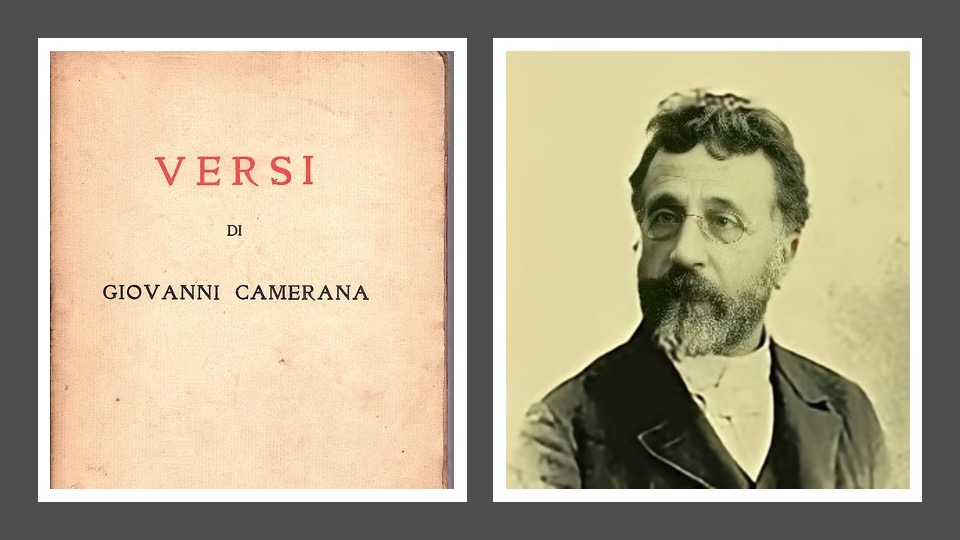Nel 1915 una giovane scrittrice inglese esordiva nel mondo letterario con un romanzo “La crociera” (The Voyage Out). Aveva 33 anni e si chiamava Virginia Stephen. Sul libro appariva il suo nome da sposata, Virginia Woolf.
“La crociera” era un buon romanzo ma nessuno avrebbe potuto immaginare che Virginia (come la chiameremo da qui in poi) avrebbe, pochi anni dopo, rivoluzionato la letteratura inglese e mondiale.
Era piuttosto bella, con occhi tra il verde e il castano, capelli castani, alta (1,75), slanciata, pallida, esile, con uno sguardo gentile e perspicace.

Suo padre Sir Leslie Stephen era un noto studioso che da solo aveva redatto centinaia di voci della prestigiosa enciclopedia Oxford Dictionary of National Biography nonché saggi biografici e opere filosofiche. Si era sposato con la figlia del celebre scrittore Thackeray, l’autore di “La fiera delle vanità”, e avevano avuto una figlia disabile, Laura.
La prima moglie morì giovane e tempo dopo Sir Leslie fece una proposta di matrimonio a Julia Prinsep Jackson.
Anche lei era vedova, aveva perduto il marito da giovane e si era chiusa in un grande dolore. Aveva già tre figli.
Era famosa per la sua bellezza e discendeva da un Chevalier L’Etang che a fine Settecento era stato amico di Maria Antonietta.
Sua zia era stata una pioniera della fotografia, Julia Margaret Cameron.
Ebbero quattro figli di cui la terza fu Virginia. Julia si ritrovò così, tra suoi e gli altri, con otto figli da accudire. Si dedicava a numerose opere di bene, si prese anche cura di numerosi parenti ammalati ma soprattutto del marito, un uomo inquieto, con un viso interessante con una lunga barba, egocentrico ed eccessivamente preoccupato della situazione economica nonostante fosse agiato e che prese la discutibile decisione di far studiare fuori casa solo i figli maschi e diventare precettore delle figlie femmine. Il padre si innervosiva se lei e Vanessa non capivano subito gli esercizi di matematica e di greco.
Virginia era vicina emotivamente alla sorella maggiore Vanessa, un legame che si sarebbe mantenuto per tutta la vita. Purtroppo entrambe furono vittime di molestie sessuali da parte dei due fratellastri di Virginia, in particolare George.
Nel 1895, quando Virginia aveva 13 anni, sua madre morì a soli 49 anni. Fu l’evento più tragico della sua vita e l’inizio di un notevole disagio psicologico che l’avrebbe, tra alti e bassi, accompagnata tutta la vita (e a cui sarebbe disonesto dare un nome come invece molti hanno fatto).
Durante l’adolescenza Virginia si innamorò del tutto platonicamente di due giovani donne, Madge Symonds e poi Violet Dickinson. Come avrebbe raccontato Quentin Bell, nipote della scrittrice, nella bella biografia che le avrebbe dedicato, quando Madge si recava a trovare la famiglia lei pensava: “Madge è qui” e sentiva il cuore battere a mille. Non esistono forse amori più forti di quelli dell’adolescenza.
Nel 1904, dopo il decesso del padre, Virginia fece un primo tentativo di suicidio.
A 30 anni, nel 1912, accettò la proposta di matrimonio che le aveva fatto un anno prima il trentaduenne Leonard Woolf.
L’anno seguente tentò nuovamente il suicidio e fu a un passo dalla morte.
Leonard Woolf rimane una figura controversa nonostante abbia scritto ben sei libri autobiografici e un romanzo ambientato in Sri Lanka (allora Ceylon).
Magro, con occhi blu scuri, capelli neri era nato a Londra nel 1880 in una famiglia ebrea (ma era ateo) e aveva studiato all’università di Cambridge.
Conobbe Virginia casualmente quando lei si era recata un giorno a Cambridge.
Rimase colpito dalla sua aria gentile e dal suo aspetto. Poi, nel 1904, era partito per Ceylon come funzionario dell’impero britannico, il più esteso del mondo. Sarebbe tornato solo nel 1911.
Nel frattempo lei aveva ricevuto alcune proposte di matrimonio che aveva rifiutato, eccetto una: quella dello scrittore gay Lytton Strachey.
Il giorno dopo lui, assai imbarazzato, aveva ritirato la proposta.
Leonard Woolf, tornato a Londra, si era innamorato di Virginia. Avevano interessi in comune: entrambi facevano parte del gruppo letterario di Bloomsbury (dal nome di un quartiere di Londra) che ebbe un grande peso nella nascita della corrente letteraria del Modernismo. Erano giovani artisti che si riunivano a casa di Virginia e Vanessa sfidando i tabù della società britannica parlando di tutto a ruota libera e di cui faceva parte anche il futuro grande economista John Maynard Keynes.
Entrambi avrebbero poi aderito ad una nota organizzazione socialista britannica, la Fabian Society svolgendo attività sociale, in certi periodi, per la working class.
Leonard Woolf ebbe anche un’intensa attività di giornalista e politica anche se avrebbe voluto essere uno scrittore famoso.
Sempre nel 1912 lui aveva scritto di sé a Virginia (esagerando?) che era “egoista, geloso, crudele, lussurioso, bugiardo e probabilmente anche peggio. Mi ero ripetuto più volte che non avrei mai sposato nessuno” e invece fece di tutto per sposarla.
Aveva un tremito alle mani che lo tormentò per tutta la vita, nelle foto appare spesso cupo o distratto.
Lei voleva bene a Leonard e desiderava avere dei figli e sposarsi.
Fu molto sincera con lui prima di accettare la proposta di matrimonio.
Nel 1912 gli scrisse: “Come ti ho detto un po’ brutalmente l’altro giorno, non provo attrazione fisica per te. Ci sono momenti, come quando mi hai baciata l’altro giorno, in cui non provo nulla, sono come una pietra eppure la tua premura nei miei confronti mi travolge. È così reale e così strana”.
Si sposarono e sembra che rimase un matrimonio bianco ma molto importante a livello affettivo ed intellettuale.
Lui era il primo a leggere i romanzi della moglie quando erano ancora manoscritti.
Fondarono insieme la piccola ma coraggiosa casa editrice Hogarth Press che pubblicò autori come il poeta Eliot, Forster, Katherine Mansfield, le opere di Sigmund Freud (che avrebbero poi incontrato nel 1939).
Tutti i libri di Virginia, eccetto i primi due, vennero pubblicati dalla loro casa editrice il che la liberò dalla tirannide degli editori. Vanessa disegnava delle bellissime copertine e i libri ebbero successo, furono presto tradotti in altre lingue.
Nel 1937 si recò a trovarla a Londra una giovane donna belga che voleva tradurre “Le onde” in francese. Virginia le dette carta bianca. Era Marguerite Yourcenar.
Tornando a Leonard, egli si prese grande cura della moglie quando lei ebbe dei momenti molto difficili psicologicamente. Consultò vari medici, l’assisteva personalmente, assunse delle infermiere. Teneva un quaderno in cui scriveva in tamil e singalese (le lingue di Ceylon) come procedeva lo stato psichico e fisico di lei.
Lei rimpianse sempre di non aver potuto avere figli e adorava i nipoti, figli di Vanessa.
Molti dicono che Virginia non sarebbe potuta sopravvivere senza Leonard e senza la scrittura.
Quentin Bell, nipote di Virginia, scrisse che sposare Leonard era stata la migliore decisione che lei avesse mai preso.
Tuttavia nel 1998 venne pubblicato un saggio scritto da Irene Coates, una commediografa inglese nata nel 1925, che sosteneva che Virginia fosse stata invece manipolata, controllata, dominata dal marito per decenni e che infine si era sentita di troppo nella vita di lui.
Il libro ha suscitato grandi polemiche in Inghilterra e ha avuto estimatori e detrattori.
Pochi mesi dopo il suicidio di Virginia nel 1941 lui, 61 anni, per quanto disperato, si innamorò di un’altra donna, Trekkie Ritchie Parsons, pittrice, 39 anni (che aveva già conosciuto prima) con la quale ebbe una relazione che durò fino alla sua morte nel 1969 a 88 anni.
Tra il 1922 e il 1931, cioè dai 40 ai 49 anni, fu il decennio più creativo di Virginia nel quale pubblicò romanzi come “La stanza di Jacob” (Jacob’s Room – 1922), “Mrs Dalloway” (1925), “Gita al faro” (To the Lighthouse – 1927), “Orlando” (Orlando: A Biography – 1928) e “Le Onde” (The Waves – 1931).
“La stanza di Jacob” fu il primo romanzo in cui abbandonò uno stile classico per un altro in cui erano essenziali gli stati d’animo, le sensazioni, i pensieri, i dettagli più che la trama e le azioni.
Questo stile o modo, che Virginia stessa saggiamente non definì mai un “metodo”, in quanto era scaturito spontaneamente da lei dopo una lunga, estenuante ricerca, venne così denominato dallo psicologo e critico letterario William James, fratello del celebre scrittore anglo americano Henry James, che lo chiamò “stream of consciousness” (flusso di coscienza).
Anche Marcel Proust, “recluso” a causa dell’allora ingestibile asma nel suo appartamento parigino, aveva scoperto qualcosa di affine seppure diverso nel suo capolavoro “Alla ricerca del tempo perduto”, edito tra l’inizio del Novecento e gli anni Venti, ed altrettanto il dublinese James Joyce in “Ulisse” (1922) dove non vi era una trama e una connessione logica tra le frasi.
Kafka aveva invece descritto l’assurdità esistenziale.
Detto per inciso, Virginia adorava l’opera di Proust ma non accettò l’Ulisse per la Hogarth Press in quanto non le era piaciuto.
In “Le Onde” portò lo “stream of consciousness” alle estreme conseguenze: vi sono solo i pensieri dei personaggi.
In “Mrs Dalloway” c’era invece il contrappunto, assai forte emotivamente, tra due personaggi completamente diversi che si muovono in una serena giornata di giugno londinese senza mai incontrarsi: la serena Clarissa Dalloway e il profondamente inquieto Septimius Warren Smith, traumatizzato dalla prima guerra mondiale.
In “Gita al faro” ella rievocava invece la sua infanzia e i genitori in un’atmosfera evanescente. E anche se Virginia non aveva studiato musica il libro assomiglia ad un brano musicale: ogni personaggio contribuisce con il suo timbro particolare, i suoi stati d’animo, i suoi pensieri ad una sinfonia d’insieme: il tirannico signor Ramsey, la sacrificata e bellissima signora Ramsey, la maldestra pittrice Lilly e gli altri.
Non si può non ammirare il fatto che mentre combatteva con una seria malattia Virginia riuscì a scrivere queste grandi opere letterarie
Ella apprezzava ed era “gelosa” al tempo stesso soltanto del talento di Katherine Mansfield con la quale nacque un rapporto d’amicizia (2).
In quel tempo Virginia incominciò anche a guadagnare molto con i suoi libri.
Prima aveva vissuto grazie ad una piccola eredità del padre ma ora poteva spendere liberamente anche se continuò a vivere in modo molto sobrio.

Nel 1922, a 40 anni, Virginia conobbe una scrittrice di successo, Vita Sackville – West.
Vita, 30 anni, proveniva da una delle più aristocratiche famiglie inglesi (una sua discendente, anche se non diretta, sarebbe stata Lady Diana). La sua famiglia possedeva la tenuta di Knole, quasi 400 stanze, che Vita non poté ereditare in quanto la successione era solo per via maschile.
Vita scriveva romanzi con titoli come “Seduttori in Ecuador”, “La signora scostumata”, “La Grande Mademoiselle”, romanzi assai gradevoli ma più che altro rappresentativi di un mondo. Amava viaggiare in Oriente, i cani – come ogni buon inglese che si rispetti – e coltivò e creò splendidi incroci di rose nel giardino del suo castello di Sissinghurst nel Kent.
Era sposata con un noto diplomatico conservatore (che non avrebbe mai lasciato) e avevano due figli.
Apparentemente sembravano due persone lontane. Virginia era riservata nel modo di vivere, Vita brillante e mondana.
Nel 1925 la loro amicizia si trasformò in un amore di cui ci sono rimaste le lettere.
Virginia seppe guardare oltre le apparenze della lady aristocratica e Vita colse la delicatezza di Virginia.
Leonardo Woolf sostenne discretamente Virginia e altrettanto fece Vanessa.
Sia Leonard sia Vita sapevano che non avrebbe mai lasciato Leonard.
Quando l’amore finì nel 1929 (sembra a causa delle infedeltà di Vita) l’amicizia continuò. Per Vita, Virginia scrisse “Orlando”, la storia di un malinconico poeta inglese del 1500 che vive ancora nel 1700 in Persia, che da uomo diventa donna e che ha splendide parti come la descrizione del grande gelo di Londra.
Le donò anche il manoscritto.
Sulla forza vitale dell’amore compose poi un altro bel romanzo meno conosciuto, “Flush”, dove descrisse, dalla deliziosa prospettiva del fedele cocker spaniel Flush, il grande amore tra i poeti Elizabeth Barrett e Robert Browning.
Nel 1928 Virginia tenne due conferenze di rilievo per studentesse all’università di Cambridge. Da qui nacque un saggio intitolato “Una stanza tutta per sé”. È un testo fondamentale nella storia delle donne e del femminismo perché individua alcuni elementi della loro oppressione e come superarli: l’indipendenza economica e un proprio spazio privato. Vent’anni dopo anche Simone de Beauvoir nel suo saggio “Il secondo sesso” avrebbe individuato nell’indipendenza economica il nucleo della liberazione femminile.
“Una stanza tutta per sé” è molto bello oltre che per l’analisi sociale per come è scritto.
Gli anni ’30 furono più difficili per Virginia. Alcuni suoi amici morirono e anche un nipote, Julian, figlio di Vanessa, che era andato volontario nella guerra di Spagna contro i franchisti. Fu lei a dare grande supporto emotivo alla sorella.
Nel 1940/41 la guerra fu molto violenta in Inghilterra: Londra venne bombardata tutte le notti per due mesi e l’Inghilterra per otto.
Anche l’ultima casa di Virginia, chiamata Monk’s House nell’East Sussex a circa un paio d’ore a sud di Londra (un cottage semplice e dagli interni bellissimi, oggi museo) venne bombardata ma non colpita.
Fu un inverno freddissimo.
Il cibo era assai scarso e la probabilità di un’invasione tedesca molto alta anche se poi, fortunatamente, non si verificò.
Anche se i Woolf non lo sapevano erano nella lista (che è rimasta) degli inglesi famosi da arrestare ed eliminare da parte delle SS tedesche.
Nel marzo del 1941 Virginia ebbe un forte crollo emotivo. Vide un medico ma il 28 marzo lasciò la sua casa di campagna dopo aver scritto una lettera per il marito e una per Vanessa. Sono lettere struggenti.
I giornali pubblicarono la notizia della sua scomparsa.
Leonard rimase sconvolto e fu tra i sospettati dalla polizia.
Tre mesi dopo dei ragazzi videro il suo corpo in un piccolo fiume chiamato Ouse.
Grazie alle lettere si determinò che era stato un suicidio. Aveva 59 anni.
Molti scrissero che Virginia Woolf era una donna affascinante con una bellissima voce, per niente presuntuosa ma che anzi tendeva a sottovalutarsi, qualcuno l’ha definita egocentrica come il padre, altri timida e spiritosa.
Lei è sempre stata criticata dai reazionari per le sue idee politiche e la storia con Vita – una storia cristallina, alla luce del sole e per questo irritante per gli omofobi ma al tempo stesso è sempre stata molto amata dagli appassionati della buona letteratura e dalle donne perché lei aveva preso la parola per loro: “For most of history, anonymous was a woman”.
………
Nota 1) Lavinia Capogna “Virginia Woolf e la forza rivoluzionaria dell’amore” in “Pagine Sparse – studi letterari” (2024)
Nota 2) Lavinia Capogna “Katherine Mansfield. Una neozelandese a Londra”, articolo su Il Randagio.
Bibliografia:
Tutte le opere di Virginia Woolf
Quentin Bell Virginia Woolf (Garzanti 1996) e nella versione originale inglese (1972 e poi 2017).
Hermione Hill Virginia Woolf. Biografia
Phyllis Rose Virginia Woolf. Biografia
Angelica Garnett Deceived with kindness
Quentin Bell Bloomsbury (1968)
Jane Dunn Virginia Woolf and Vanessa Bell. A Very Close Conspiracy.
Leonard Woolf La mia vita con Virginia
Love Letters: Leonard Woolf and Trekkie Ritchie Parsons
Irene Coates Who’s Afraid of Leonard Woolf? A Case for the Sanity of Virginia Woolf (1998)
Adorata creatura. Le lettere di Vita Sackville-West a Virginia Woolf
Virginia Woolf – Vita Sackville-West
Scrivi sempre a mezzanotte. Lettere d’amore e desiderio.
Alcuni romanzi di Vita Sackville – West
Nigel Nicolson Portrait Of A Marriage: Vita Sackville-West and Harold Nicolson
Nadia Fusini Posseggo la mia anima
Nadia Fusini Un anno con Virginia Woolf
Sara De Simone Nessuna come lei: Katherine Mansfield e Virginia Woolf: storia di un’amicizia.
Nota: da qualche tempo circola spesso sui social una poesia attribuita a Virginia Woolf che non è sua.
Vanessa Redgrave ha magistralmente interpretato in un film Mrs Dalloway e Nicole Kidman Virginia Woolf nel film “The Hours”.
Patti Smith le ha dedicato una lettura pubblica.
Lavinia Capogna*

*Lavinia Capogna è una scrittrice, poeta e regista. È figlia del regista Sergio Capogna. Ha pubblicato finora otto libri: “Un navigante senza bussola e senza stelle” (poesie); “Pensieri cristallini” (poesie); “La nostalgia delle 6 del mattino” (poesie); “In questi giorni UFO volano sul New Jersey” (poesie), “Storie fatte di niente” , (racconti), che è stato tradotto e pubblicato anche in Francia con il titolo “Histoires pour rien” ; il romanzo “Il giovane senza nome” e il saggio “Pagine sparse – Studi letterari” .
E molto recentemente “Poesie 1982 – 2025”.
Ha scritto circa 150 articoli su temi letterari e cinematografici e fatto traduzioni dal francese, inglese e tedesco. Ha studiato sceneggiatura con Ugo Pirro e scritto tre sceneggiature cinematografiche e realizzato come regista il film “La lampada di Wood” che ha partecipato al premio David di Donatello, il mediometraggio “Ciao, Francesca” e alcuni documentari.
Collabora con le riviste letterarie online Il Randagio e Insula Europea.
Da circa vent’anni ha una malattia che le ha procurato invalidità.