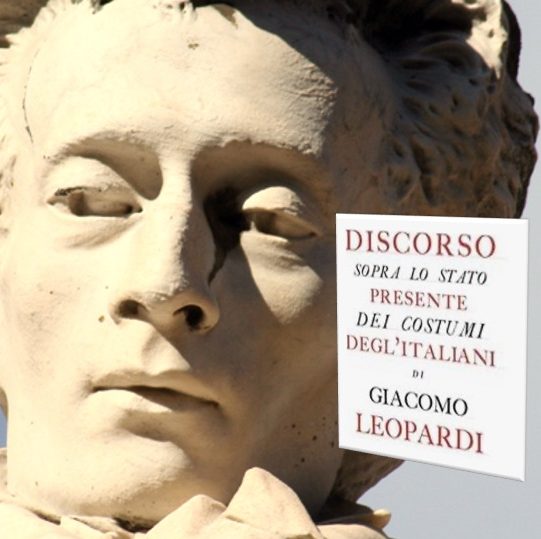Narratore, drammaturgo, saggista, traduttore dal giapponese e dall’italiano, René de Ceccatty – che ha pubblicato una trentina di opere, tra cui i romanzi, tradotti in italiano, “La parola amore“, “L’accompagnamento“, e “Amicizia e passione. Giacomo Leopardi a Napoli“, e nel 2021 ha ricevuto il Premio De Sanctis per la letteratura – si racconta ai nostri lettori.

Lei è nato a Tunisi, da madre di origini franco-tunisine e da padre francese. Quanto ha influito, sulla sua vita, questa bi-culturalità?
Più che di bi-culturalità, parlerei di multiculturalità, anzi di assenza di appartenenza. Il nascere in un Paese colonizzato dà la consapevolezza della relatività, e dell’abuso di una presenza non desiderata. Ma i miei genitori avevano rispetto alle proprie origini degli sguardi diversi. Mia madre aveva perduto suo padre quando era bambina (decenne). Dai francesi “puro sangue” lei e le sue sorelle erano considerate “bicote”, una parola gergale razzista usata dai francesi per designare i tunisini e più genericamente “i musulmani”, “gli arabi”. Ha sofferto di questo razzismo che raddoppiava il dolore della perdita, del lutto. Mia nonna sposando un tunisino è stata molto coraggiosa, perché si opponeva al razzismo e al disprezzo che caratterizzava la maggioranza dei francesi, e più precisamente la propria madre (la mia bisnonna). Mamma è stata educata nella cultura francese. È rimasta una donna sempre conscia delle ingiustizie e sempre combattiva. Era convinta che i francesi dovevano andarsene dalla Tunisia. Mio padre era nato in una famiglia borghese, anzi aristocratica, ma rovinata da tre generazioni. Però faceva parte di una certa borghesia. La diversità delle classi sociali delle due famiglie era molto chiara per me e per mio fratello. Era soprattutto questo che ci colpiva, e non la “bi-culturalità”. Ma ho imparato l’arabo in prima elementare, insieme al francese. E a casa, mentre mia madre lavorava (era maestra), rimanevo, prima di andare alle elementari, solo con la mia bambinaia, siciliana, che mi parlava italiano. Ero quindi immerso in tre lingue, arabo, francese e italiano, e imparavo due modalità di scrittura: la latina e l’araba. Nelle strade, sentivo sempre le tre lingue (a scuola c’erano anche dei bambini italiani). Un’infanzia passata durante la guerra d’indipendenza influisce molto anche sulla vita, sul modo di pensare la politica. La violenza era quotidiana in Algeria, non in Tunisia. Ma c’era una minaccia costante, una paura.
Perché si è avvicinato alla traduzione?
Per motivi biografici molto naturali. Ci samo trasferiti in Francia, quando avevo sei anni, alla fine della prima elementare. Ero lacerato perché avrei dovuto abbandonare la mia tata siciliana in Tunisia. La pensavo con una grandissima nostalgia. A dieci anni, ho cominciato a imparare delle lingue straniere a scuola (inglese e latino poi greco) e ho cominciato a voler scrivere: raccontini, delle poesie e ho provato durante due o tre anni a tradurre l’inglese in francese (pagine intere di “Jane Eyre”!), poi il latino in greco o il greco in latino. Era un gioco che mi permetteva di capire meglio quel che leggevo e di impossessarmi di storie scritte da altri e appartenenti a altre culture. Poi ho avuto un motivo intimo e privato per conoscere la lingua italiana, o meglio per ricordarla, perché mi era già familiare. Ho voluto scrivere alla mia tata siciliana. Ho comprato una grammatica italiana e un vocabolario. Ho imparato con molta disciplina la lingua, come facevo a scuola con i miei compagni, ma per l’italiano ero assolutamente solo, senza compagni, senza professore, ma col pensiero nostalgico di Ignazina la bambinaia. Le volevo scrivere nella sua lingua per esprimere il mio amore. Ho capito che in questa lingua sua avrebbe compreso meglio il mio affetto. Mi ha risposto, molto commossa. Quindi la traduzione era per me all’inizio qualcosa di legato alla mia vita sentimentale, familiare, affettiva, e l’espressione di un bisogno di creatività. Se avessi scritto solo in francese, avrei avuto l’impressione di utilizzare una lingua impersonale, perché lo usavano i miei compagni e tutti i francesi, mentre l’italiano era solo per me e per la mia tata. Come una lingua segreta. La traduzione è diventata una cosa più seria e intellettuale poco dopo. Quando ho visto “Teorema” di Pasolini, ho saputo che questo regista era anche uno scrittore e ho ordinato in una libreria il romanzo che aveva lo stesso titolo del film che avevo visto. L’ho letto e ho cominciato a tradurlo, perché mi ero accorto che assomigliava molto a un romanzo che avevo appena scritto… e che mandai a Pasolini, dopo avergli chiesto l’autorizzazione di farlo… Lui mi aveva risposto che potevo tranquillamente mandargli il testo, anche se era scritto in francese… Tutto questo l’ho raccontato spessissimo perché fu un’esperienza fondamentale per spiegare il mio rapporto con Pasolini, con l’Italia, con la letteratura, con le culture, con la creazione, con la traduzione e anche con l’omosessualità.

È traduttore dall’italiano e dal giapponese. Quant’è difficile trasportare parole, trame, idee e sensazioni – un mondo intero, una cultura diversa, un “altro” da sé – da una lingua all’altra?
Come avrà capito, non consideravo la cultura e la lingua italiane come “altre”, ma al contrario come intime e quindi “mie”. Era come un continente segreto all’interno del mio cervello e del mio cuore. La lingua italiana era anche molto legata a una religiosità segreta, o spiritualità che dir si voglia, che avevo scoperto in un viaggio-pellegrinaggio a Torino, qualche anno prima con un prete. Avevamo celebrato la messa in italiano nel duomo di Torino (io come chierichetto…). E nel mio romanzo, mandato a Pasolini, c’erano delle battute in italiano che ripetevano delle preghiere o delle formule della messa… Quando ho cominciato a tradurre libri interi, ho scelto quelli che sentivo più naturali e vicini alla mia sensibilità. Il primo fu “Un po’ di febbre” di Sandro Penna. Avevo già scritto parecchio (commedie, poesie, romanzi) e lo stile di Penna era un ideale di semplicità, di forza, di eleganza, di mistero e di evidenza. L’ho fatto senza contratto e l’ho pubblicato molti anni dopo. Dopo i miei studi di filosofia ho fatto il consulente editoriale per una casa editrice dove lavorava un famoso traduttore dell’italiano (Georges Piroué) che mi aveva affidato due libri da tradurre che avevo molto amato (“La gloria” di Giuseppe Berto e “Il cimitero cinese” di Mario Pomilio), che corrispondevano alla mia sensibilità. Poi ho cominciato a tradurre Pasolini (“L’odore dell’India“, “Descrizioni di descrizioni“, “Amado mio” ecc. fino a “Petrolio“). Lo scrittore argentino Héctor Bianciotti ha avuto anche lui una grande importanza per la mia attività di traduttore e di scrittore. Nel frattempo avevo scoperto la cultura e la lingua giapponese (essendo professore di filosofia a Tokyo, dove ero stato mandato per il servizio civile) che furono un’altra scoperta “interiore” più che linguistica. E devo dire che anche con il giapponese (che negli anni ho tradotto con un amico giapponese con cui ho vissuto, in Giappone, in Inghilterra e in Francia) tradurre era un modo di appropriarmi di un mondo. Adesso traduco il giapponese da solo. E prima di tradurre ogni frase la scrivo attentamente in kanji, per darmi l’illusione di scrivere in giapponese. La mia esperienza di traduttore è molto varia. Mi è difficile riassumere in poche parole il lavoro, i tentativi e le rinunce, che conoscono tutti i traduttori. Perché tradurre è scegliere, prima di trasmettere. Un traduttore non traduce da una lingua in un’altra lingua (che, di solito, è la sua madrelingua), ma traduce dalla lingua di uno scrittore in una lingua che è la lingua molto particolare e soggettiva che è quella del traduttore. Non si può tradurre qualsiasi testo: ci sono dei testi che resistono, perché fanno parte di un mondo (non solo linguistico, ma umano) troppo lontano dal traduttore. Ho così rinunciato a tradurre Manganelli, e “Horcynus Orca” di Stefano D’Arrigo (anche se avevo tradotto “Cima delle nobildonne“). Sono incapace di usare delle parole e di costruire delle frasi che non mi siano naturali. Con Moravia, di cui ho tradotto tante cose (racconti, drammi, poesie, saggi, diari di viaggio, e ovviamente romanzi), mi sentivo a mio agio anche se il suo mondo è incredibilmente diverso del mio. La sua intelligenza permette l’incontro con il diverso e con il simile (per riprendere le parole che ha impiegato nel suo discorso di Campo de’ fiori sulla bara di Pasolini). Ma il mio incontro più forte, intimo e naturale fu con Pasolini. Poi con Dante, Petrarca e Leopardi. Anche con il meraviglioso Giuseppe Bonaviri. E in giapponese con Natsumé Sôseki e Fumiko Hayashi, e con gli autori classici dei “nikki” (diari di corte del medioevo). Lo ripeto, bisogna avere la sensazione (l’illusione…) di scrivere quel che si traduce. Si tratta meno di entrare in una cultura o di trasmettere questa cultura che di penetrare un pensiero, una sensibilità e di condividerle intimamente. Mi ricordo con tanta nostalgia le traduzioni che facevo di Kenzaburô Ôé, di Kôbô Abé, di Yukio Mishima col mio amico giapponese, perché oltre a capire una lingua diversa, facevamo nostri le loro invenzioni, la loro libertà nell’uso della lingua, il loro modo di aprire e chiudere una specie di “camera interiore”.
Ha tradotto molti scrittori italiani (penso a Dante, Petrarca, ma anche di più vicini a noi, come Moravia e Saba). Che rapporto ha la Francia con la letteratura italiana?
La letteratura italiana ha sempre avuto un’enorme influenza sulla letteratura francese (basta pensare al dolce stil novo, poi al petrarchismo rispetto ai poeti della Pléiade, due secoli dopo, o alla Divina Commedia ovviamente – ma Dante rimase poco letto prima dell’Ottocento). Il Settecento fu il regno del teatro con Goldoni. L’Ottocento italiano è quasi ignorato o lo fu a lungo dalla Francia (Manzoni e anche Leopardi), perché in questo periodo, ci fu in Francia l’esplosione del romanzo e della poesia. Ma per il Novecento è molto diverso. Pirandello, Svevo, Moravia, Pavese, Vittorini, Montale, Pasolini, Calvino, Sciascia, Elsa Morante, Umberto Eco, Claudio Magris hanno invaso le librerie francesi e sono stati letti dai francesi con grande ammirazione e entusiasmo. Era un dialogo abbastanza equilibrato. Un’ammirazione reciproca. Con certi limiti dovuti alla difficoltà di tradurre le lingue regionali, i dialetti, così importanti per Pasolini, Saba, Zanzotto, Gadda, Camilleri e per tanti altri. Ma questo è un altro discorso che riguarda il problema della traduzione della poesia. Si perde sempre qualcosa. Per tradurre la poesia, ci vuole un po’ di incoscienza. Ho tradotto Dante in ottenari perché ho avuto il coraggio degli incoscienti. C’è sempre, nell’atto di tradurre, un momento in cui il traduttore deve osare qualcosa che si dovrebbe vietare, come un salto nel vuoto. Bisogna che dimentichi la lingua tradotta, perché altrimenti vedrebbe intorno a sé soli occhi severi che gli proibirebbero di andare avanti. “Cosa fai? Come osi? Perché hai scelto questa parola? Ma non senti la musica che sei incapace di riprodurre? Ecc.”
Si divide tra saggistica, narrativa e teatro. Tre modi diversi di esprimersi. Perché questa pluralità?
Certo, sono le circostanze della vita che mi hanno spinto a scrivere romanzi, biografie, teatro, saggi. Ma è il caso comune di ogni scrittore che ha bisogno di esprimersi in vari modi. La narrativa è la mossa più spontanea. Raccontare, spiegare, capire, descrivere, approfondire le sensazioni, i ricordi, le pulsioni, le attrazioni, le incomprensioni. Nei momenti di crisi (amore e lutto, per farla breve) ho sentito la necessità di scrivere (“L’accompagnement”, “Aimer”, “Une fin”, “L’Hôte invisible”). Ma anche per creare un misto di esperienza vissuta e d’immaginario (“La sentinelle du rêve”, “Babel des mers”, “L’étoile rubis”). La saggistica ha sempre una dimensione autobiografica. Non sono un teorico secco, arido. Non mi piace l’astrazione staccata. Non a caso, ho lasciato la filosofia che mi sembrava artificiale nell’uso di concetti generali e nel rifiuto dell’io. L’io è assolutamente necessario alla ricerca della verità. Ho tradotto “Il convito” di Dante che ha delle pagine sublimi sull’uso dell’io e dell’autobiografia nella saggistica. Questo testo geniale è poco letto e capito male. “La vita nuova” di Dante è per me un modello. Quando ho scritto la mia tesi di dottorato (di filosofia, ma su un argomento letterario, l’opera di Violette Leduc) ho usato un io molto soggettivo che ha scandalizzato i vecchi professori, ma che aveva un significato molto profondo per me, di rifiuto di un’astrazione gratuita. Cerco, nei miei saggi (anche nelle mie recensioni critiche di opere letterarie nei quotidiani o mensili, come nelle mie conferenze e nelle interviste come questa), di essere molto personale e autobiografico. Il teatro era quasi il mio primo modo di esprimermi. Ho anche fatto l’attore, quando ero studente. Poi quando conosciuto l’argentino Alfredo Arias, che mi ha chiesto di aiutarlo a scrivere le sue commedie, poi mi ha proposto di mettere in scene le mie (“La Dame aux Camélias”, “Pallido oggetto del desiderio”), sono stato molto felice. Lavorare con gli attori, conoscere i segreti dell’incarnazione della parola in scena è sempre stato meraviglioso. Ho lavorato anche con attrici straordinarie (Claudia Cardinale, Anouk Aimée, Isabelle Adjani, Adriana Asti, Marilú Marini), condividendo con loro i misteri della timidezza e della violenza dell’esposizione al pubblico. Lavorare con musicisti (Nicola Piovani, Arturo Annecchino, Silvia Colasanti e tanti altri) è un’esperienza indimenticabile. Lavoro anche adesso con il cantante italo-brasiliano Antonio Interlandi, per spettacoli su Pasolini. Giorgio Ferrara mi ha commissionato dei dialoghi per sua moglie Adriana Asti (purtroppo mancati entrambi da poco) e ho avuto la fortuna di accompagnarli a Spoleto, per vari spettacoli (anche con la coreografa americana Lucinda Childs). Giorgio si fidava molto di me e mi ha chiesto di aiutarlo nella regia del suo “Don Giovanni”, e di scrivere libretti con lui. Per uno scrittore, è una consolazione contro la solitudine che sempre lo minaccia.
Lei è apertamente gay. In che modo il suo orientamento sessuale ha influenzato la sua scrittura?
Sono stato fortunato con miei genitori, intelligenti ed empatici, che mi hanno lasciato esprimermi liberamente con, da parte loro, meraviglia, tolleranza e rispetto. Ho saputo il mio orientamento da ragazzo (già a dieci/dodici anni) senza il minimo dubbio e senza la minima colpevolezza. Ciò spiega il mio entusiasmo quando ho visto “Teorema”, “Fellini Satyricon” e quando ho letto Sandro Penna. Ho scritto molto presto poesie e commedie con tematica esplicitamente omosessuale, talvolta con ironia o umorismo. La malinconia e la disperazione, l’ho conosciuta ed espressa più tardi. Ho raccontato in “Mes années japonaises”, le mie esitazioni, che sono state un errore. Ma i miei primi romanzi e racconti (“Personnes et personnages”, “Jardins et rues des capitales”, “Esther”) erano molto chiari sui miei desideri ed infatuazioni. Faccio parte della generazione AIDS, cioè dei ragazzi colpiti, spesso uccisi da questa orribile malattia. Sono stato testimone della loro morte precoce. Nell’”Accompagnement” (tradotto in italiano dalla casa editrice sarda Inschibboleth), ho descritto la malattia e la morte di un amico scrittore ed editore che mi ha chiesto di documentare il suo martirio. Questo libro è stato determinante nel mio rapporto con la letteratura perché avevo paura di sbagliare, di non scegliere le parole giuste. Poi ho scritto “Aimer“, racconto autobiografico, anche se in parte immaginario, nel quale parlo di una passione per un medico eterosessuale che si è innamorato di me, che ha invaso la mia vita e che si è perso in una mescolanza di rifiuti, di ritorni, di fughe. La mia vita sentimentale era diventata molto complicata. Nei vari libri che ho scritti poi, ho provato a seguire il labirinto delle contraddizioni di questo tipo di situazione. Ma ormai ho una vita più equilibrata. Vivo in coppia, sono sposato con un uomo che ha avuto, prima di conoscermi, tre figli. Ho partecipato alle lotte per la libertà di orientamento sessuale. Ho scritto nei primi settimanali e mensili omosessuali. Tra cui quello che ha fondato Michel Foucault, che conoscevo bene (avevo seguito le sue lezioni del Collège de France, poi ci siamo rivisti in Giappone). Jean Genet, Violette Leduc, Michel Foucault, Pier Paolo Pasolini, ma anche Alfredo Arias con cui ho lavorato più di trenta anni, in Francia, in Italia, in Argentina, sono stati tutti molto importanti per la mia coscienza omosessuale. La mia omosessualità segna molto il mio lavoro. Ho molti amici omosessuali (uomini e donne). In quanto editore, ho pubblicato molti scrittori omosessuali (Edouard Louis, Olivier Charneux, Jean-Michel Iribarren, Marie-Claire Blais, Silvia Baron Supervielle, Patrick Drevet, Arthur Cahn, Jean-Baptiste Niel), e ho tradotto scrittori omosessuali (ho già citato Sandro Penna, Pier Paolo Pasolini). Ho anche tradotto dall’inglese il primo bestseller americano, “The Front runner“, sull’omofobia e la passione tra un atleta e il suo coach, scritto da una donna (Patricia Nell Warren), sul modello dei popolari romance novels. Ma le mie scelte sono molto più aperte ovviamente. Però resto convinto che l’eterosessualità esclusiva per un uomo è un mancanza, un difetto, un’esperienza povera e incompiuta (quel che pensava probabilmente anche Moravia, amico di omosessuali). Nella varie biografie che ho scritto (di Pasolini, di Moravia, di Elsa Morante, della Callas, di Greta Garbo, di Sibilla Aleramo, di Giacomo Leopardi, di Serge Tamagnot e prossimamente di Héctor Bianciotti) ne parlo molto e anche in altri libri come “Objet d’amour” (su Stendhal, Michelangelo et Xavier Sigalon, un pittore francese, copista del Giudizio universale). La mia editrice attuale Colette Lambrichs vorrebbe ristampare “”L’étoile rubis” (tradotto 30 anni fa da Costa & Nolan): in questo romanzo-metafora, descrivo la vita in una casa editrice come quella di un bordello giapponese, in cui tutti gli editori sono delle prostitute (maschi travestiti) e gli autori i loro clienti.
Credevo fosse finita qui. Un’intervista densa e interessante e, almeno per me, un motivo per ammirare l’uomo che c’è dietro allo scrittore.
Ma ieri sera, controllando la posta per l’ennesima volta ho ricevuto un’email che mi chiedeva come avessi avuto l’idea di intervistarlo.
La mia risposta è stata letteralmente: “Ho letto il suo bellissimo libro su Leopardi a Napoli (“Amicizia e passione. Giacomo Leopardi a Napoli“) e ho deciso di saperne di più”.
Al che il nostro dialogo è continuato.
Se avessi saputo che tutto era partito dalla sua lettura di “Amicizia e passione”, avrei risposto più a lungo sulla storia della relazione di Giacomo Leopardi e di Antonio Ranieri. Hanno avuto un rapporto di un’intensità che pochi cosiddetti “omosessuali” (in un periodo in cui la parola non esisteva) hanno conosciuto. Michel Foucault diceva che l’omosessualità è diventata un problema sociale, presentato come tale, quando la gente si è chiesta cosa potessero fare due uomini insieme, all’insaputa di tutti. Poi è nata l’idea di una malattia mentale e sociale, e i medici hanno cercato di curare questi nuovi “malati”. Nel Settecento, secolo molto sentimentale, in Italia e soprattutto in Francia e in Inghilterra, l’amicizia prendeva delle forme veramente passionali. Me ne ero accorto scrivendo su Horace Walpole per esempio (in un libro intitolato “L’or et la poussière“). Horace Walpole sarebbe adesso il tipo stesso dell’omosessuale dandy, una sorta di antenato di Oscar Wilde. Ma la sua sessualità (non detta) non era un problema sociale o mentale. Leopardi ha con Ranieri un’intimità totale di affetto, di vita quotidiana. Ma molto brutto e malato, non può pensare se stesso come oggetto di desiderio da parte dal suo giovane amico, lui sano e bellissimo. E vive la propria sessualità (era probabilmente casto e anche vergine) attraverso la vita sentimentale di Ranieri, poi attraverso le proprie fantasticherie amorose che descrive nelle sue poesie o nelle sue meravigliose lettere con donne inaccessibili, ma lusingate dall’amore di un grande poeta. Alberto Arbasino ironizza molto su Ranieri e penso che sia un’ingiustizia bella e buona. Alberto Arbasino, molto “camp”, molto ironico e snob, anche se molto intelligente e colto, fa parte degli intellettuali omosessuali la cui ironia non mi piace, anche se si tratta di autoderisione. Ho voluto restituire a Ranieri quel che gli spettava. Un rispetto e una gratitudine per quel che ha fatto per la memoria del suo geniale amico. A proposito del rapporto della letteratura italiana con l’omosessualità, devo dire che secondo me i libri più belli e profondi sono stati scritti da eterosessuali raffinati, sensibili e compassionevoli, come Giorgio Bassani (“Gli occhiali d’oro“) o come Alberto Moravia (“Il conformista“, “Agostino” e anche il suo ultimissimo racconto “Palocco“, che ho tradotto di recente per una raccolta di suoi inediti, poi ovviamente il discorso fatto in omaggio di Pasolini dopo la sua morte) o come Elsa Morante (“L’isola di Arturo” e “Aracoeli“). Anche nei libri di Edith Bruck (scrittrice di cui ha tradotto molti libri), deportata ebrea ungherese che ha scelto la lingua italiana, ci sono delle pagine meravigliose sull’omosessualità, maschile e femminile, di un’intelligenza e di una sensibilità unica (“L’amica tedesca“, ma anche “Lettera di Francoforte“). Ed “Ernesto” di Umberto Saba che, dopo l’opera intera di Sandro Penna, è probabilmente il libro più grande sulle esitazioni dell’orientamento sessuale nell’adolescenza e sono d’accordo con Elsa Morante nel dire che sia uno dei più grandi libri sull’amore (come “L’isola di Arturo” della stessa Morante). Tra gli autori italiani omosessuali del novecento, sono stato molto colpito da Mario Mieli (“Elementi di critica omosessuale“, tradotto in francese da poco, ma l’avevo letto quando era uscito in Italia), da Gilberto Severini (che ho prefatto), da Mario Fortunato, da Pier Vittorio Tondelli, da Ivan Teobaldelli e dal cugino di Pasolini, Nico Naldini che ho tradotto in francese e prefatto in italiano. E sono molto amico di uno scrittore italiano che scrive in francese, Carlo Jansiti, che ha scritto le biografie di Violette Leduc e di Jacques Guérin – famoso collezionista e mecenate di scrittori.
Così si chiude un’intervista che mi ha dato un immenso piacere e la voglia di saperne di più sull’opera di quest’uomo che ha fatto della cultura la sua vita e che, nei miei confronti, si è dimostrato un gentleman di altri tempi.
Silvia Lanzi

Silvia Lanzi: Ho conseguito la maturità magistrale, e mi sono laureata in materie letterarie presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con tesi riguardante l’alto medioevo. Ho collaborato per anni con il settimanale “Nuovo Torrazzo” di Crema occupandomi della stesura articoli di vario genere (soprattutto critica letteraria e teatrale e cronaca di eventi quali vernissage et similia). Collaboro con il sito gionata.org in qualità di traduttrice dall’inglese e scrivendo articoli. Sono autrice di due libri: “Libera di volare” (Kimerik, 2006) e “Coincidenze” (Boopen, 2010). Lettrice onnivora – alterno saggi (psicologia, storia, filosofia e arte) e narrativa (soprattutto anglo-americana e scandinava).