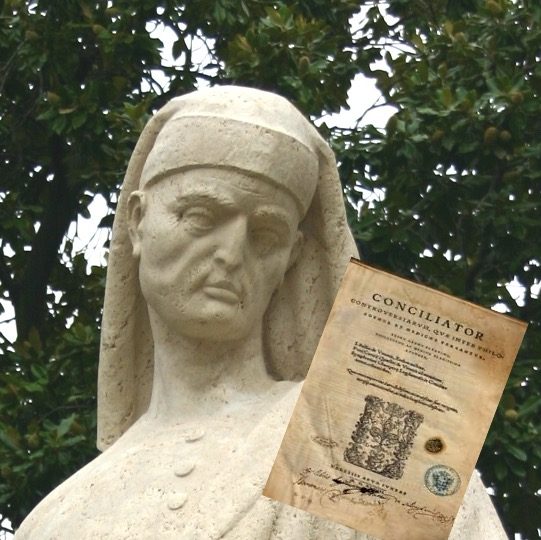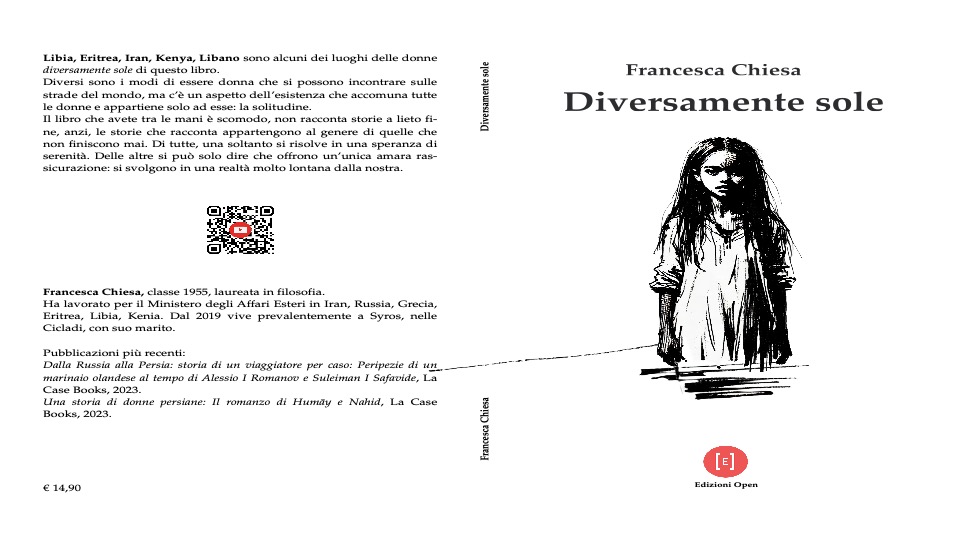Ultimamente stiamo assistendo a un crescendo di tensione tra Stati Uniti e Iran. Atmosfera che mi fa ricordare una affermazione di Giles Deleuze, uno tra i padri dello strutturalismo francese: “Compie atto meritorio, chi individua una struttura”.
In questi mesi di sovvertimento di tutti i consolanti luoghi comuni in cui il mondo occidentale si è crogiolato dalla seconda guerra mondiale in poi, forse non è senza significato sforzarsi di capire quanto ci sia di antico nella storia contemporanea.
I fatti che seguono possono contribuire a chiarirci le idee sulla supposta rusticità dei nostri cugini d’oltre oceano. Partiamo da un modello di riferimento, astratto, come si conviene.
Lo Stato X vuole colpire lo Stato Y e per farlo distrugge il suo edificio più rappresentativo; a distanza di qualche anno Y organizza una spedizione punitiva nei confronti di X; il capo di Y, insieme ai suoi strateghi più abili e affidabili, cura l’aspetto organizzativo e poi sparisce dalla scena, sostituito dal figlio che porterà a termine l’impresa.
E ora lo applichiamo.

Filippo e Alessandro
Atene, 480 a.C., settembre. Serse, ha invaso la Grecia in aprile e in agosto ha subito lo scacco delle Termopili. In settembre prende Atene e si vendica, o forse scarica la sua rabbia, dando fuoco all’Acropoli. Il luogo più sacro, dove verrà successivamente costruito il Partenone.
Trascorrono 154 anni. Nel 336 a.C. Filippo di Macedonia, che si è ormai assicurato il controllo della Grecia, proclama di voler vendicare l’insulto di Serse ad Atene e annuncia che guiderà una spedizione punitiva in Persia. Filippo lavora insieme ai suoi uomini più fidati: Attalo, suo cognato, Parmenione e Filota figlio di Parmenione. Quando è tutto pronto, Filippo viene assassinato. Da un sicario? Da un rivale? A guidare la spedizione. – vittoriosa come ben sappiamo – fu il figlio Alessandro accompagnato e assistito da Attalo, Parmenione e Filota.
Bush, padre e figlio
New York, 2001, 11 settembre. Storia più che nota. Aerei di linea americani vengono dirottati e portati a schiantarsi contro le cosiddette “Torri Gemelle”, sede del Word Trade Center, e il Pentagono ad Arlington, in Virginia. Simboli del potere statunitense: controllo dei commerci e delle guerre. È il primo anno di presidenza di George W. Bush, il Figlio.
Della vendetta si occupa George H.W.Bush, il Vecchio. Nel suo periodo di presidenza (1989-1993) ha vagliato e testato a uno a uno gli uomini di cui c’è bisogno: i generali Norman Schwarzkopf e Colin Powell, al suo fianco durante la Prima Guerra del Golfo del 1991. Gli stessi uomini saranno a fianco del figlio nel 2003, in occasione della Seconda Guerra del Golfo. Accanto a loro Donald Rumsfeld, Segretario della Difesa, che nel 1997 aveva creato il Centro di Ricerca “Project for the New American Century”, per la messa a punto di un progetto di guerra lampo in Iraq. Insieme a lui Dick Cheney, già Segretario della Difesa di Bush Sr., vicepresidente con Bush Jr.
Tutti gli uomini del primo Presidente Bush, per far vincere la guerra al secondo Presidente Bush. La quale guerra inizia il 20 marzo 2003 e termina il 18 dicembre 2011, con l’insediamento di autorità irachene gradite al Governo statunitense.
Padri e figli, un successo di accoppiamenti a specchio, tra Pella e Washington. Storie complesse, allora come ora. A noi conviene rimanere tra XX e XXI secolo, per dare conto di pochi altri fatti.
Un amore, un film, un modello di insurrezione popolare
Chiediamoci, per cominciare, perché le due Guerre del Golfo non hanno interessato in alcun modo l’Iran, paese in cui dall’undici febbraio 1979 è al potere un regime che ha come parola d’ordine Morg bar Amrikā/Morte all’America.
Dunque. Pochi mesi dopo l’instaurazione del regime islamico, il 4 novembre 1979 gli studenti islamici incitati da Khomeini assaltano l’ambasciata statunitense e prendono in ostaggio 52 persone. Il momento sembra scelto con la massima accuratezza. Un anno esatto dopo, le elezioni presidenziali negli Stati Uniti registrano un risultato non comune: il presidente democratico uscente, Jimmy Carter, non ottiene la riconferma. Vince il repubblicano Ronald Reagan, ex attore. Il giorno del suo insediamento, 20 gennaio 1981, Khomeini rilascia i prigionieri americani che l’amministrazione Carter ha cercato invano di liberare.
È amore. Che si consolida tra il 1985 e il 1986 con l’affair Iran-Contra. In sintesi: sette ostaggi statunitensi sono nella mani di Hezbollah che, come ben sappiamo, è legato all’Iran; gli USA vendono armi all’Iran, su cui vige un embargo; il ricavato della vendita finanzia l’opposizione violenta dei Contras in Nicaragua.
Detto questo, il film.
Nel 2004 esce nelle sale Alexander di Oliver Stone. Il film narra la campagna di Alessandro, dalla Grecia all’Asia, e il suo culmine con la sconfitta di Dario III a Gaugamela, oggi Gomel nel Kurdistan iracheno. Dopodiché Alessandro torna a Babilonia e muore. In tutto il film l’Eroe non ha mai messo piede nella Persia vera e propria.
Ovvero: l’Iran non si tocca, è un Paese amico. A questa fa seguito una storia che potremmo chiamare Il Bazar e le sue rivoluzioni.
Il Bazar, in Iran, rappresenta storicamente il cuore dell’economia, della società e quindi anche della politica. È il bastione, la garanzia, la radice da cui trae linfa il Paese.
Detto in soldoni: ogni volta che nella storia moderna dell’Iran la situazione politica ed economica è apparsa senza via d’uscita, i Signori del Bazar si alleano con le fazioni più determinate del clero, e cambiano il regime. Con un aiuto esterno.
È accaduto nel 1953, quando fu necessario far cessare il governo Mossadeq. Ricordate, quello che aveva nazionalizzato il petrolio, con l’unico appoggio dell’ENI di Mattei. Fu rovesciato dai bazarì, con l’aiuto del clero e degli USA. Inviato speciale per la cosiddetta Operazione Aiax fu Kermit Roosvelt Jr., nipote di Theodore Roosvelt.
La scintilla che ha fatto divampare la rivoluzione di Khomeini fu probabilmente la decisione dello Shah di prendere il controllo del commercio, favorendo tra l’altro l’apertura di supermercati e centri commerciali. Il Bazar, manco a dirlo, si ribellò e l’Ayatollah dovette lasciare il suo confortevole rifugio in Francia. Arrivato all’aeroporto Mehrabad, alla domanda “Cosa provi tornando in Iran?”, rispose “Ic-ci/Niente”.
Le manifestazioni sempre più violente e insanguinate che sono ora in corso in Iran, hanno avuto origine nel Bazar di Teheran, come c’informano i nostri notiziari.
Letture consigliate: Vite parallele di Plutarco e Mossadeq di Stefano Beltrame
Francesca Chiesa*

*Francesca Chiesa, classe 1955, laureata in filosofia.
Ha lavorato per il Ministero degli Affari Esteri in Iran, Russia, Grecia, Eritrea, Libia, Kenia. Dal 2019 vive col marito prevalentemente a Syros, nelle Cicladi.
Pubblicazioni recenti:
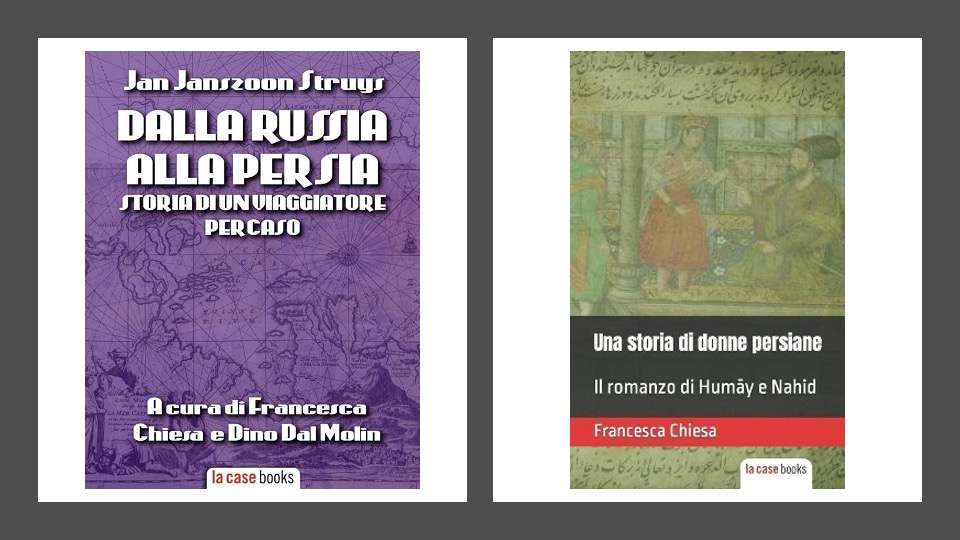
Dalla Russia alla Persia – storia di un viaggiatore per caso: Peripezie di un marinaio olandese al tempo di Alessio I Romanov e Suleiman I Safavide, La Case Books, 2023
Una storia di donne persiane: Il romanzo di Humāy e Nahid, La Case Books, 2023.
Il suo ultimo lavoro è Diversamente sole, Edizioni Open, 2025.