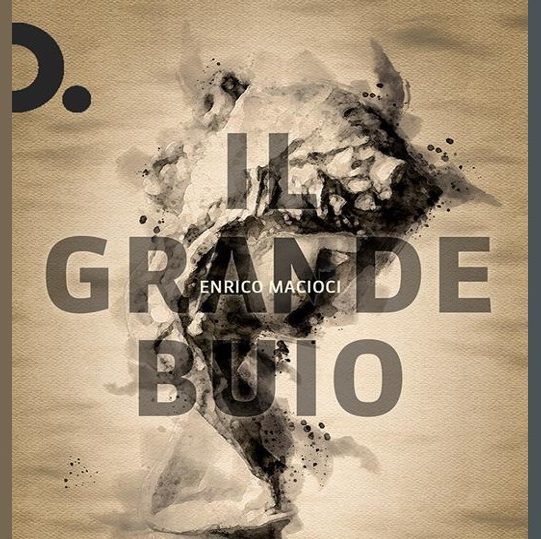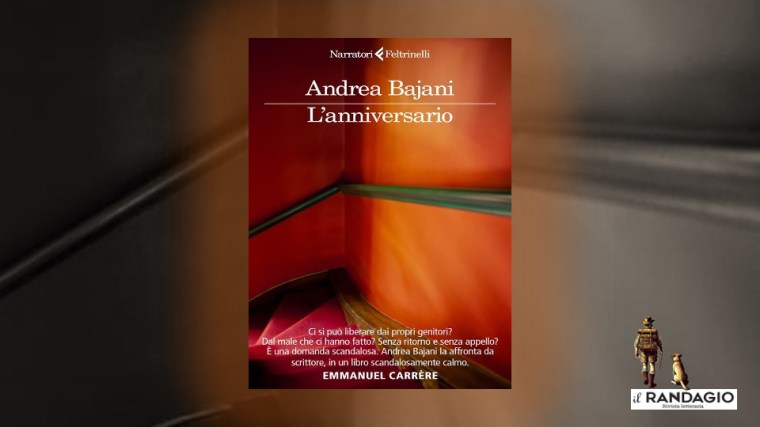Una raccolta di racconti noir, thriller fra polizieschi e introspettivi? Senza dubbio questo ed altro ancora rappresenta “Il grande buio” di Enrico Macioci, edizioni NEO. Dello stesso autore avevamo apprezzato “L’estate breve”per TerraRossa, “Lettera d’amore allo Yeti” con Mondadori, “Terremoto” per Terre di mezzo. Peculiare di questo nuovo lavoro è un distopico sguardo all’anima nera di un anti mondo, somigliante a un anti Cristo, destinato, tranne forse in un caso o due, a restare senza riscatto, senza redenzione e, soprattutto, senza spiegazione. Abituati come siamo agli enigmi, continuamente presenti nel mondo attuale, leggiamo spesso senza scomporci di orribili morti, crudeli delitti, malsane fissazioni, ma questa volta sicuramente non è tutto qui: in questo libro un inquisitore ostinato e un osservatore nascosto pongono domande, sembra non si accontentino del mistero. Qui, prima del macabro e prima dell’assurdo, è la semplicità delle vite comuni che non convince, quasi un teorema messo a dimostrare che è proprio l’idea di normalità a risultare assurda, a sollevare i dubbi più disparati. Se il contrario di vita è morte, il contrario di luce è buio, un “grande” buio, recitato nel titolo e teorizzato in alcuni passaggi. Il concetto non è nuovo, era in ogni letteratura ancora prima che le lingue ne lasciassero traccia, nuova è una diversa prospettiva, né distaccata o indifferente, né eroica o patetica, piuttosto presentata da un occhio strabico profondamente dissociato, una spia dentro il cervello umano, una spia disturbante come un pensiero rimosso. L’orrore condominiale maciullato in piscina esordisce senza equivoci nel primo racconto, apocalittico senza appello come la scena di un film, così come filmico sembra l’ultimo racconto con la sua chiusura ad anello, nel mezzo il tema viene declinato in più modi, tutti riconducibili alla paura del buco nero, più che cosmico e divoratore di universi, luttuoso e disorientato, come appare di notte una stanza da letto senza il chiarore proveniente da abatjour, imposte o finestre.

Macioci, che è nato nel ’75, sono certa conosca la serie di telefilm di Hitchcock, uscita nel ’55: l’atmosfera è la stessa, la fine di ogni episodio lascia lo stesso ironico stupore, con l’impressione di essere stati garbatamente presi in giro, oppure provocati nei sentimenti e nel buon senso comune, e magari portati a chiederci che cosa sia il buon senso comune. “La puzza” è il secondo racconto, invaso dal pestifero odore di cadavere, a ricordare che il marcio non è solo in Danimarca. Ormai abbiamo notizia di femminicidi quasi ogni giorno, non c’è bisogno di ricorrere alla fantasia, la realtà supera l’immaginazione, come recita un abusato luogo comune: “Proprio come in Barbablù” osserva nella narrazione uno dei personaggi. L’attenzione si sposta quindi su quanto accade dopo, quando l’assassino incontra un’altra donna, del tutto ignara e affascinata dall’avventura di una notte, per lei l’avventura non si concluderà in orrore, per sua fortuna non è lei l’oggetto dell’ “amore” e perciò del possesso, la vendetta non è sulle donne in genere ma su “quella” donna, considerata unica.
In ogni storia il lettore è attratto dalla descrizione minuziosa di ambienti, stati d’animo, sensazioni e particolari , la natura parla ma parlano anche gli oggetti, le strade, i condomini e i marciapiedi, un’osservazione pregnante che ricorda l’oggettivismo denso di significato di Robbe-Grillet. Il tema poliziesco di certi intrecci, caro allo stesso Robbe-Grillet, e ricorrente in questo libro, rafforza l’impressione che in letteratura niente va perso; il filo conduttore entra ed esce dalla realtà come l’ago di un ricamo a tombolo. Un tema ricorrente è quello del disgusto, una sensazione rivoltante d’insofferenza per la brutale volgarità dell’animale umano, incapace di prescindere da umori, eiezioni, sudiciume, dai quali invece sembra a volte attratto, incapace com’è di osservarli scientificamente per quello che sono, o di sublimarli con la pietà. Ambiguo è lo stupro, ambigua è la vita di coppie o famiglie borghesi, perbene, normali. Presente, e forse dominante, è la contrapposizione dei ruoli e dei caratteri nelle coppie, all’interno delle quali le posizioni si ribaltano alternativamente, l’uomo è fragile, inconcludente ed esile, la donna a volte una virago, amante in segreto di una preistorica clava, a volte spezzata, esasperata e pericolosa, il conflitto non ha soluzione, o così sembra. Fra le storie si può intravedere un filo conduttore: il personaggio dell’ispettore e del suo aiuto (tributo a Sherlock Holmes e a Watson, mai dimenticati nell’immaginario, ridimensionati e adattati alla disillusione) può essere il fil rouge, se vediamo in loro, personaggi marginali e forse inessenziali, una ipotetica coscienza, che osserva e arretra, quasi con rispetto, di fronte all’imperscrutabile buio. Il lettore va avanti fino alla fine , attratto e partecipe, assorbito dalla narrazione, che è poi il principale merito di un buon libro.
Valeria Jacobacci

Valeria Jacobacci, scrittrice e pubblicista, è appassionata conoscitrice di storia partenopea e di biografie, spesso femminili, di donne che hanno caratterizzato i loro tempi. Si è interessata alla Rivoluzione Napoletana, al passaggio dal Regno borbonico all’Unità, al secolo “breve”, racchiuso fra due guerre. Ha pubblicato numerosi articoli, saggi e romanzi.