Avevo Conosciuto Bohumil Hrabal attraverso il suo romanzo “Ho servito il re d’Inghilterra” in cui un piccolo cameriere di un famoso hotel si trova ad attraversare, nella capitale dell’allora Cecoslovacchia, da spettatore prima e da protagonista poi, tutte le stagioni sociali e politiche che la storia del primo novecento aveva in serbo per Praga.
Dalla caotica eredità dell’Impero Austroungarico all’infatuazione capitalista, dalla repubblica nata dopo il primo conflitto mondiale all’occupazione nazista, dalla liberazione sovietica all’avvento del regime comunista che dileguò le attese di ogni ritorno liberal borghese.

Fu Felice Mortillaro, un economista che non aveva rinunciato ai piaceri della letteratura, nonostante la sua fede nello sviluppo capitalistico che non poteva che venire dal meraviglioso incedere dell’industria metalmeccanica occidentale nel mondo, a parlarmi per primo di Bohumil Hrabal e del suo “Ho servito il re d’Inghilterra”.
Eravamo a pranzo ed allora anch’io ero schierato dalla parte industriale, sia pure senza il suo entusiasmo, anzi con più di qualche riserva per un mondo capitalistico che in Italia badava a capitalizzare relazioni, politiche e sociali, lecite o meno, più che investimenti ed innovazioni.
Rimasi assai colpito da quel riferimento letterario in un contesto assolutamente refrattario che comportava l’ostracismo per tutto quanto non fosse oggetto di proficua, se non proprio tronfia, esibizione.
Dal disinteresse dei commensali rimasti silenti e imbarazzati era evidente che a nessuno interessava nulla del Re d’Inghilterra e di Hrabal, a parte me.
Corsi in libreria e mi divorai quel romanzo.

L’ironia di Hrabal nel raccontare le vicende storiche europee filtrate dallo sguardo di un piccolo cameriere che era diventato capitalista con la repubblica post bellica ed era tornato cameriere con il regime comunista era davvero esilarante. E mi innamorai di Bohumil Hrabal o meglio del suo cameriere che aveva servito il re d’Inghilterra e che proprio non gli riusciva di andare in depressione nonostante umiliazioni e rovesci ne mettessero a dura prova la resistenza. Egli trovava comunque nella vita il piacere dell’esistenza. Nel sesso, nell’amicizia, nell’amore, nella lotta, nelle sfide, nel gioco a mettere a nudo i potenti, mai cedendo alla rassegnazione, alla depressione o alla lamentazione gratuita.
Era davvero una grande metafora dello spirito di un popolo che resta libero e padrone del suo destino a dispetto della storia, di ogni storia.
E questa metafora la ritrovai in tutti i suoi libri, nessuno escluso.
Il mio interesse per Bohumil Hrabal si rinnovò, e questa volta per non venir mai più meno, allorché ebbi modo di conoscere Eva, un’intellettuale praghese trapiantata in Italia, comunista convinta ma con il vizio insopprimibile dell’aspirazione alla libertà, lo stesso di Bohumil.
Fu lei a far tornare in superficie il mondo di Bohumil, allorché mi parlò di uno scrittore praghese controcorrente che non aveva mai voluto lasciare Praga nonostante le limitazioni cui egli era sottoposto dal regime che mal sopportava la sua indisciplina intellettuale e che difendeva la sua libertà facendo ogni tipo di lavoro manuale cui era costretto per vivere non essendo riconosciuto come scrittore di regime.
“Stai parlando di Bohumil Hrabal” le dissi, travolto da un rigurgito di emozioni emerse dalla mia antica lettura del Re d’Inghilterra e sollecitate dalla più recente lettura de “L’uragano di Novembre” in cui Hrabal, con un ragionamento pacato ma inflessibile che nasceva dal suo spirito profondamente ancorato alla dimensione primordiale della vita ed ai suoi valori ancestrali, affermava per sé il dovere di restare nel luogo dove la gente, il popolo, amici e conoscenti, colleghi di lavoro e familiari, erano costretti a rimanere non potendo beneficiare dei privilegi dell’intellettuale, chiamato e addirittura invocato dall’estero e volentieri lasciato partire dal regime.
Per parte mia io avevo fatto in tempo ad avvertire i profumi di libertà che arrivavano dalla primavera di Praga ed avevo avvertito anche i brucianti riverberi del rogo cui si immolò lo studente Jan Palak su piazza San Venceslao per urlare il suo rifiuto alla normalizzazione sovietica.

Era logico per gli europei dell’Occidente contrapposti agli Europei dell’Est, stare dalla parte di chi fuggiva, soprattutto se chi fuggiva era un mostro sacro della letteratura praghese come Mikan Kundera.
Kundera aveva raccontato la sua fuga in uno con la sua nostalgia e l’amore per la terra lasciata, in quel monumento letterario dal titolo “L’insostenibile leggerezza dell’essere”. Roba da lasciarci gli occhi ed il cervello insieme all’anima.
Poi lessi “L’uragano di Novembre” e rimasi fulminato dalla prosa, questa volta impastata di rabbia, di dolore e di fatica, di Bohumil Hrabal.
Una prosa che poteva nascere solo da un profondo, insopprimibile, sentimento di appartenenza, che come un fiume impetuoso, trovava origine nelle vette della dimensione primordiale e che si nutriva dei valori ancestrali radicati nelle viscere più profonde dei popoli oltre che degli individui.
Per Hrabal partire significava ostruire quella sorgente, prosciugarne il flusso vitale e sancire il tradimento verso sé stessi, la propria terra ed il proprio popolo.
Decidere di andare alla deriva senza alcuna possibilità di ritorno e lasciare anche che il tuo Paese vi andasse per suo conto.

Quell’intellettuale praghese che mi parlava di Praga e della sua nostalgia che teneva insieme, senza risolverle, le contraddizioni comuniste e l’amore per la libertà, mi riportò a Hrabal.
Quelle contraddizioni andavano sciolte in casa, aveva sostenuto Hrabal, patendo l’emarginazione e la fatica di vivere se necessario e adoperando la propria vita perché ciò succedesse.
Come dargli torto.
Un gigante della letteratura del secondo novecento per me ed un testimone dei presupposti irrinunciabili dell’identità dell’Umanità in qualsiasi luogo del pianeta.
Bohumil Hrabal aveva lavorato come ferroviere all’epoca dell’occupazione nazista ed aveva insieme ai suoi colleghi sabotato i “Treni strettamente sorvegliati” diretti al fronte con armi e munizioni, come raccontò nel suo intenso libro da cui fu ricavata la sceneggiatura per un film che nel 1966 ad Hollywood vinse l’Oscar come miglio film straniero. In seguito aveva lavorato come addetto al macero dei libri di cui salvava l’anima mandando a memoria dei frammenti di ciascuno volume che veniva ridotto in inermi striscioline, come raccontò in quel piccolo capolavoro dal titolo “ Una solitudine troppo rumorosa” ed aveva lavorato nelle fabbriche di birra di Praga ed aveva bevuto quella birra presso la birreria “ Svoboda” parola che tradotta significa libertà, ed aveva continuato a coltivare patate e ogni altro ortaggio possibile nel suo orto, in un impegno etico e morale per affermare il suo essere salvaguardando, magari, anche qualche spicchio dell’anima degli altri.
E tutto questo non poteva essere barattato con l’espatrio.

Da ultimo avevo letto il suo romanzo “Le nozze in casa”. Una lunga storia dedicata all’amore della sua vita, la moglie troppo presto scomparsa, ed alla rievocazione del mondo in cui quell’amore era nato, tra la fatica e la gioia di vivere che animavano il tempo riempiendolo di allegria, di solidarietà, di gusto per l’esistenza, di appartenenza e identità che proprio nella forza della quotidianità trovava la sua ragione di essere.
Hrabal era consapevole che quel mondo andava a morire.
Moriva nella omologazione che sarebbe sopravvissuta al comunismo, nella fine della cultura e della civiltà della solidarietà che sopravviveva nelle campagne e nella gente di città legata al mondo del lavoro operaio e che rimaneva strettamente legata a quanti la vita dovevano costruirsela e difenderla ogni santo giorno con l’aggravante di dover conservare in fondo al cuore anche il desiderio di essere liberi ed essere sé stessi.
Ma Bohumil Hrabal aveva la certezza che non vi fosse salvezza al di fuori di quel mondo. Certo la deriva andava in direzione opposta. E non era questione di comunismo o capitalismo. Era la rinuncia al mondo primordiale, era la cancellazione dei valori ancestrali che stavano condannando il mondo verso il degrado ma egli era convinto che se il mondo avesse voluto salvarsi, se un giorno avesse voluto tornare sui suoi passi era lì che doveva guardare.
Come il suo cameriere che aveva servito il re d’Inghilterra ed aveva attraversato la storia senza mai perdere il gusto di ricominciare.
Per questo Bohumil non partì e all’indomani della fine della primavera praghese, del crollo di ogni speranza, rimase al suo posto. Perché bisognava ricominciare, aspettare il tempo per ricominciare. E questo vale per tutti i tempi e per tutti i luoghi, per tutti gli individui e tutti i popoli. A condizione che da qualche parte qualcuno mantenga viva la memoria da tirar su come una cima cui, seppur invisibili, sono legati, come reti copiose, i valori primordiali custoditi in fondo al mare o al cuore.
Questo pensiero mi invase allorché in un pomeriggio estivo di settembre di qualche anno fa, entrammo in Altilia, la città romana costruita sui luoghi, sui tratturi e sui ricoveri per le mandrie e le greggi dei Sanniti Pentri ormai sconfitti.

Eravamo partiti da Boiano, una delle antiche capitali dei Sanniti Pentri, senza fretta. Il tratto Boiano-Altilia non era particolarmente lungo e nemmeno duro. Avevamo camminato lungo i tratturi della transumanza ed avevamo attraversato un lungo falsopiano ricoperto di macchia mediterranea, di boschi e ricco di fonti. Avevamo incrociato famiglie di cinghiali ed in lontananza qualche cerbiatto curioso. Poi il tratturo aveva preso a disegnare una curva assai ampia al termine della quale ci apparve, come un visione mitologica, una città cinta da mura rese leggiadre dall’opus reticulatum.
In esse si apriva una grande porta che aveva tutta l’aria voler essere anche un arco di trionfo tanta era la grandiosa bellezza dei bassorilievi, delle iscrizioni e dei telamoni dalle fattezze di prigionieri germanici che la ornavano.
Era Altilia.
La attraversammo con stupore e religioso silenzio.
Oltre le mura si disponeva il tessuto urbano con i decumani ed i cardini, il teatro, il foro e la basilica, il mercato e le terme, le domus e le botteghe.
Era una visione fuori dal tempo.
La attraversammo tutta, in preda ad un rapimento.
Era deserta.
In fondo al decumano principale un’altra porta maestosa immetteva sull’antico tratturo della transumanza in direzione di Sepino, l’antico Saipinz sannitico, divenuto Saepinum con i Romani ed, oggi, rimasto un piccolo, delizioso, quanto spopolato, borgo sulle montagne del Matese, in Molise.
A metà strada, in corrispondenza dell’incrocio con il cardine che intersecava il decumano, ci giunsero dei suoni e dei canti che arrivavano da Porta Tammaro, dal nome del fiume che segna l’intera vallata intorno ad Altilia.

Un organetto, di quelli che usavano i contadini intorno alle aie nei momenti di riposo o di festa, ed un tamburello, dettavano i ritmi e le melodie delle danze in cui erano impegnati uomini e donne, ragazzi e ragazze, bimbi e bimbe, lì riuniti per festeggiare un matrimonio.
Eravamo capitati nel bel mezzo di una festa popolare e familiare che magicamente era sopravvissuta alla debordante smania consumistica del villaggio globale che tutto aveva omologato ed appiattito, comprese le più intime espressioni di sé, un tempo legate alla vita stessa di uomini e donne, famiglie e comunità e gelosamente custodite proprio in quanto tali.
Per un miracolo imprevisto, ad Altilia, il tempo sembrava essersi fermato.
La dimensione primordiale ed i valori ancestrali attraversavano l’anima di quella gente che danzava e festeggiava lì davanti a noi.
Ci sedemmo in un tavolo appartato e ci gustammo quello spicchio di umanità sopravvissuta.
Fu in quel momento che mi venne in mente Bohumil Hrabal e presi a raccontare del suo libro “Le nozze in casa”.
Antonio Corvino

Antonio Corvino, di origini pugliesi, napoletano di formazione è un saggista ed economista di lungo corso, di cultura classica, specializzato in scenari macro economici ed economia dei territori.
Direttore generale dell’Osservatorio di Economia e Finanza, specializzato nell’analisi dell’economia del mezzogiorno e del Mediterraneo oltre che nella costruzione degli scenari macroeconomici in cui Mezzogiorno e Mediterraneo sono inseriti.
In tale veste ha organizzato dal 2011 al 2015 il “Sorrento Meeting” che ha affrontato, grazie al concorso di intellettuali, studiosi, rappresentanti economici e politici, controcorrente, dell’intero Mediterraneo e di altri Paesi asiatici ed americani, con largo anticipo e visioni non scontate, le questioni esplose in maniera virulenta, negli anni più recenti: dai nodi gordiani del sottosviluppo alle migrazioni, dai giovani nuovi argonauti in cerca del futuro da qualche parte, all’effetto macigno dell’Euro sull’economia Mediterranea ed al negativo condizionamento del paradigma nord-atlantico su di essa, dall’energia alla logistica, al destino del Mediterraneo che ahimè appare sempre più compromesso.
Già Direttore nel Sistema Confindustria ha ricoperto diversi incarichi a livello nazionale, regionale e, da ultimo, anche a livello territoriale.
Appassionato delle antiche vie nelle “terre di mezzo” ha percorso numerosi cammini nel cuore del Mezzogiorno continentale coprendo oltre 1500 chilometri e traendone una serie di appunti di viaggio che han dato vita a diversi volumi e romanzi di cui “Cammini a Sud” è il primo ad essere stato pubblicato.
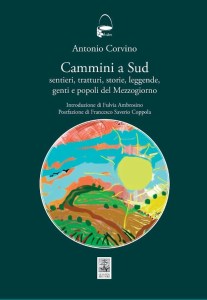
Cultore di arte ha frequentato molti artisti, talora legandosi di profonda amicizia con essi. E’ il caso di Pino Settanni, scomparso nel 2010, artista e fotografo di straordinaria sensibilità e levatura, presente nei musei internazionali, il cui archivio è stato acquisito dall’Istituto Luce-Cinecittà.
Dedito da sempre alla scrittura, questa è divenuta da ultimo la sua principale occupazione, spaziando dal romanzo di introspezione intima e personale sino all’ osservazione lucida quanto preoccupata delle derive antropologiche destinate a scivolare verso una visione distopica che solo nella memoria può trovare l’antidoto.
Nel dicembre 2019 ha curato per Rubbettino il volume “Mezzogiorno in Progress”. Un volume-summa sulla questione del Sud cui hanno collaborato trenta tra studiosi economisti ed intellettuali e trenta imprenditori fuori dagli schemi.
Sin dalla più giovane età ha collaborato con riviste di economia, tra cui “Nord e Sud” che annoverava, essendo egli un giovane apprendista, le migliori menti del Mezzogiorno. Ha collaborato, in qualità di esperto opinionista, con diversi quotidiani meridionali. Tuttora scrive su riviste specializzate in scenari economici e problematiche dello sviluppo.
Da ultimo, per l’Università Partenope, il CEHAM, e l’Ordine dei biologi, ha realizzato un corso monografico video sul Mediterraneo della durata di 15 ore destinato ad un master.
Sulla rivista Bio’s, Organo dell’Ordine nazionale dei Biologi, ha pubblicato tre saggi sulle prospettive del Mediterraneo alla luce dell’implosione della globalizzazione, indicando un nuovo paradigma policentrico dello sviluppo e proponendo la suggestione del Mediterraneo come Continente; nell’ultimo saggio si è soffermato sul ruolo del Mediterraneo nella crisi alimentare ipotizzando il ritorno della agricoltura familiare e del recupero della biodiversità quali strade maestre per una nuova visione di sviluppo legata alla valorizzazione dei territori e della agricoltura meridionale.
Sulla rivista Politica Meridionalista ha pubblicato e continua a pubblicare numerosi saggi sul Mezzogiorno indicando i Cammini e le Terre di Mezzo quali orizzonti per combattere lo spopolamento e l’abbandono dei territori interni.

