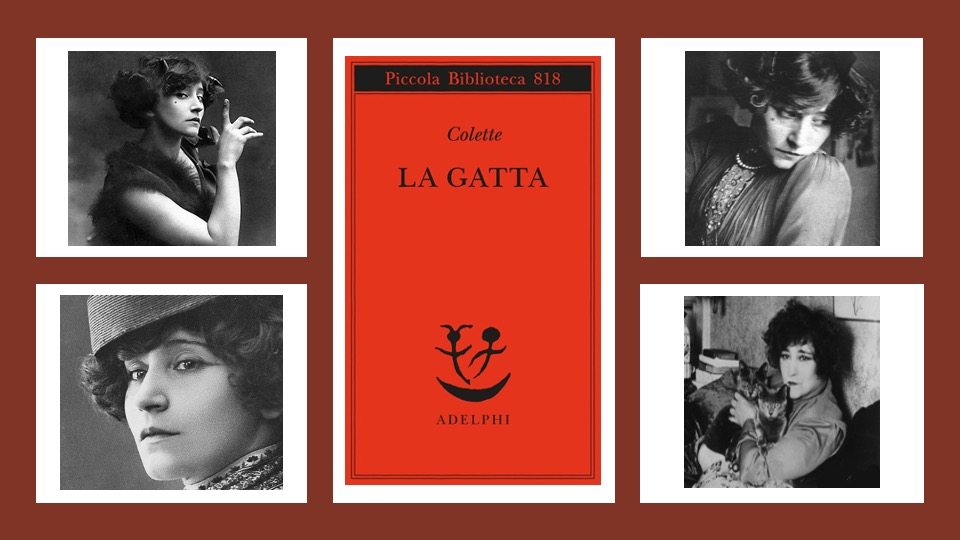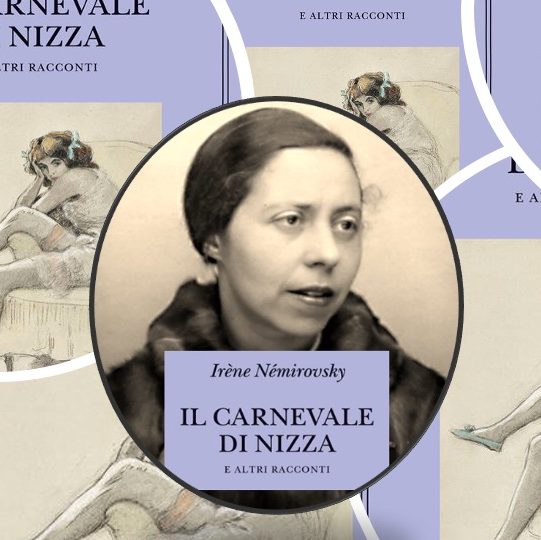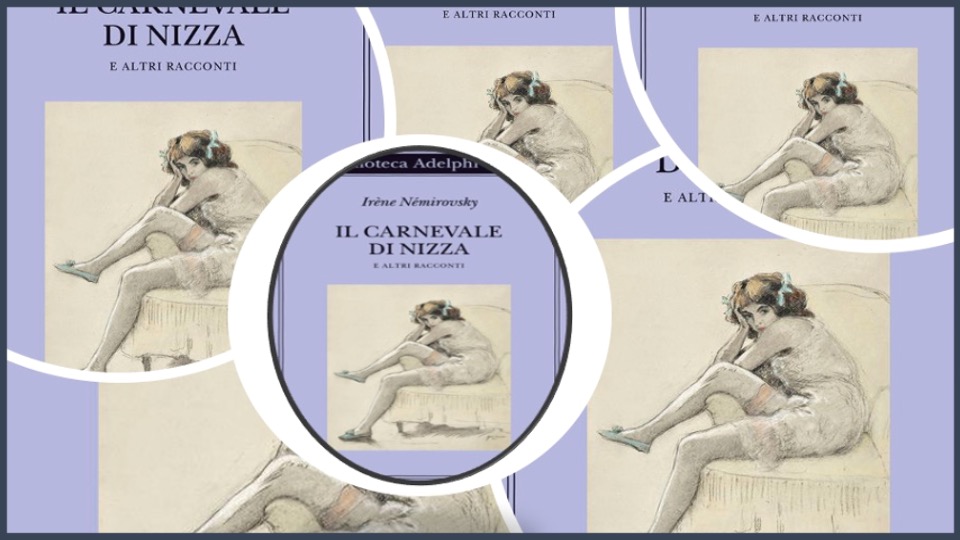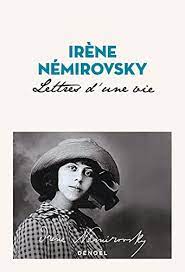«Mia madre è un romanzo»
Dopo Papà (Edizioni Clichy, 2020), Régis Jauffret prosegue le sue incursioni nella memoria familiare con Maman, appena uscito in Francia. L’intervista rivela uno scrittore alle prese al tempo stesso con i segreti familiari e con gli sconvolgimenti tecnologici che rimettono in discussione l’atto stesso di scrivere. Tra rivelazioni postume su una madre dal doppio volto e interrogativi sul futuro della letteratura di fronte all’intelligenza artificiale, Jauffret esplora territori in cui l’autenticità umana resiste ancora agli algoritmi.

In Maman, lei costruisce un’architettura temporale complessa: la narrazione procede per ritorni a spirale su eventi fondativi, rivelando dettagli contraddittori, e sovrappone sei temporalità distinte (memoria, scrittura, storia, mito, genealogia, anacronismo). Questa struttura è incarnata da una forma frammentaria, fatta di sequenze brevi separate da spazi bianchi. Come ha concepito e assemblato questa tessitura narrativa? Era una cornice prestabilita, o si è imposta progressivamente nel corso della scrittura?
Régis Jauffret: La genesi è stata meno metodica di quanto la vostra domanda potrebbe lasciar supporre. Il libro si è formato come una conchiglia attorno a un nucleo inatteso. Nel gennaio 2020, sul modello del dry January, avevo deciso di tenermi a distanza dai social per un mese e di tenere un diario su questa presunta astinenza. Tre giorni dopo, mia moglie mi ha svegliato all’alba per annunciarmi la morte di mia madre. D’un tratto, quel diario ha cambiato natura. Ho abbandonato ogni riflessione sulla dipendenza digitale, che peraltro era immaginaria, per annotare quotidianamente le reazioni, le incombenze, il dolore, ma anche quella constatazione quasi glaciale: non ero così sconvolto come avrei creduto. Per tre mesi ho scritto ogni sera, poi in modo più sporadico, fino a costituire un quaderno che è servito da base al libro. Vi si è innestata l’esperienza centrale: quella del tradimento, scoperta a piccole dosi, grazie alla serie di aneddoti e indizi, fino al momento in cui l’immagine che avevo di mia madre si è incrinata.
Nel romanzo, questo momento di svolta è evocato come una rivelazione determinante. Può descriverlo?
RJ: Si riduce a un ritaglio di giornale ritrovato in fondo a uno scatolone. Prima di allora avevo messo insieme racconti in cui mia madre era una salvatrice: diceva di aver accolto suo nipote, cacciato a quattordici anni da sua sorella a causa della sua omosessualità, mentre in realtà fino ai ventisette anni era rimasto a casa dei genitori, i quali non lo avevano mai allontanato. Questo genere di storia legava la sua malvagità a una sorta di gusto per la finzione morbosa. Ma quel ritaglio di giornale ritrovato in fondo a uno scatolone provava che mi aveva tradito fin dalla mia infanzia. Preferisco lasciarne il contenuto al mistero del libro. Mi limito a dire che mi ha colpito come un atto di doppiezza impossibile da giustificare.
L’ammissione esplicita – «Sembra che ne faccia un personaggio utilitaristico. Lo chiamo quando ho sete del suo amore e lo ripongo in una scatola per il resto del tempo» (p. 45) – testimonia una piena coscienza delle poste in gioco etiche che attengono alla scrittura cosiddetta “autobiografica”. Come ha bilanciato questa tensione tra fedeltà memoriale e necessità romanzesca, in particolare in un’opera che espone la sua intimità familiare al pubblico?
RJ: – Si trattava di un dilemma, sì: lasciare questo quaderno ai miei figli, sapendo che avrebbero potuto pubblicarlo dopo la mia morte, oppure chiedere loro di distruggerlo, cosa che probabilmente non avrebbero fatto. Ho scelto di trasformarlo in libro, il che mi permetteva di padroneggiarne la forma. Col tempo, il mio risentimento si è attenuato. Pur avendo la prova del suo tradimento, una parte di me voleva scusarla, trovare in quella menzogna un gesto d’amore. So che è illusorio, ma preferirei ricordarla come la madre amorevole che avevo creduto di conoscere per sessantaquattro anni. Anche al prezzo di una bugia che direi a me stesso. Credo, del resto, che sia così.
Lei insiste spesso sulla necessità di non dare l’impressione di un’infanzia infelice.
RJ: – Esattamente. Diffido della “sindrome Vipera in pugno”: far passare un’infanzia protetta per un inferno. Molti bambini, ancora oggi, conoscono la fame, l’abbandono, la violenza. Anche in Francia, alcuni vivono in una tale precarietà da avere accesso a un pasto completo solo durante i periodi scolastici, alla mensa. Nel mio caso, sono cresciuto al riparo dalle privazioni e dalle guerre. Sarebbe indecente travestire questo in un dramma fondativo.
Quali sono secondo lei i veri ingredienti del successo letterario oggi? Bisogna ormai adeguare i propri soggetti alle preoccupazioni immediate dei lettori per sperare di raggiungere un pubblico?
RJ: Il successo è qualcosa di più sottile, per esempio in Europa si è convinti che un soggetto letterario possa interessare solo se accomodante. Ho letto recentemente il libro di un giovane autore italiano in cui si parlava dell’acquisto di un appartamento da una vecchia signora con un prezzo inferiore a quello di mercato. Il soggetto mi è parso finemente adattato a un giovane pubblico in cerca di un acquisto immobiliare. L’autore ha notato che le giovani coppie hanno un progetto immobiliare comune prima ancora di avere il desiderio di avere figli o di sposarsi. La coppia del romanzo riuscirà nell’impresa di trovare allo stesso tempo un alloggio gradevole, alla propria portata, facendo più soldi di quelli necessari per pagare il mutuo? Ecco un elemento di suspense adatto a un pubblico giovane.
D’altronde, un pubblico giovane avrà lunga vita, si prenderà il tempo di diventare maturo, adulto, vecchio, completamente smorzato prima di morire e rivelarsi ormai incapace di comprare il minimo libro. Non posso dirvi se nel romanzo questa coppia riesca nel suo intento o se la proprietaria abbia un nipote capace di metterle la pulce nell’orecchio, perché ho perso l’opera all’aeroporto di Milano prima di averla terminata (risate). Ormai non ricordo più nomi e titoli e non posso ricomprarlo ma poco importa, dato che parlavamo di formato, ecco un formato adatto al giovane pubblico d’oggi. Nella mia giovinezza non avremmo potuto provare la minima empatia per questi giovani che ci sarebbero sembrati una vera schifezza.

Di fronte a questo desiderio universale di «formato» che descrive, non stiamo forse assistendo all’emergere di un concorrente temibile, le tecnologie dell’IA, che potrebbero padroneggiare questi codici meglio di quanto facciamo noi stessi?
RJ: In realtà, l’IA ci ha messi con le spalle al muro. Sa già raccontare meglio di molti scrittori. Ho certo la vanità di pensare di scrivere un po’ meglio di CHATGPT-4, ma nel momento in cui vi parlo, la quinta versione non è ancora disponibile. Ho fatto semplici prove con la precedente, del tipo: «Scrivete una microfiction con aereo alla maniera di Régis Jauffret». Il risultato era perfetto – se me l’avessero presentata come mia, avrei detto: sì, è senza dubbio mia. Ho trovato, tuttavia, che quella storia faceva un po’ la caricatura al mio modo di scrivere. Mi sono detto anche che mi era senza dubbio capitato, senza che lo sapessi, di fare la caricatura di me stesso. L’IA rimette completamente in questione la letteratura, tanto quanto la filosofia. Non capisco perché non si siano scritte nuove opere di Kant o di Leibniz – tutto il corpus esiste e alla sua maturità un filosofo non fa che sviluppare il suo pensiero partendo dalla base di dati che costituisce la sua opera, le sue note, la sua corrispondenza, i suoi abbozzi. Nello stesso spirito, si potrebbe prolungare la Commedia umana, la Ricerca del tempo perduto, l’opera di chi volete. Se avete diciotto anni oggi, non avete più bisogno di saper scrivere: raccontate una storia, alla meno peggio, l’IA ne migliora la trama, ne rifinisce le frasi: lo stile è la cosa più facile da ottenere.
Di fronte ai sospetti crescenti riguardo l’uso dell’intelligenza artificiale da parte di alcuni romanzieri contemporanei, non pensa che bisognerebbe apporre una sorta di etichetta “100% (cervello) umano” per rassicurare i lettori?
RJ: Ma non c’è nemmeno più bisogno di sapere scrivere, basta la voce. Già adesso, la maggior parte degli sceneggiatori ricorre all’IA e i giornalisti idem. La maggior parte degli editorialisti fa almeno migliorare il proprio pezzo dall’IA. Il vantaggio è che non vengono più commessi errori di francese, i participi passati vengono accordati e talvolta le frasi sono più eleganti. Non farò nomi, dato che non leggo quasi nulla di quello che viene pubblicato – quando non perdo i libri nel corso dei miei spostamenti – posso assicurarvi che non ho nessuna lista di nomi in tasca, ma è chiaro che da qualche mese escono in Francia, come altrove, numerosi romanzi che devono un po’, molto, quasi tutto all’IA. Dico quasi tutto, ma la tragedia – che bella parola – è che fra una settimana, tre mesi, anzi sei o sette, l’IA scriverà meglio dei migliori tra noi. E che, tra, diciamo, un anno, un anno e mezzo forse, per ragioni che sarei assolutamente incapace di spiegarvi, la forza creatrice, innovatrice, inventrice, rivoluzionaria, sconvolgente dell’IA sarà superiore a quella dell’umano. Superiore, una litote. Questo è lo stato delle cose. Non ne penso nulla. È così. Quelli che pensano il contrario sono dei terrapiattisti, ma non è perché loro non distinguono la curvatura della terra in fondo al loro giardino che la terra è una tartina imburrata. Allora, allora, allora? Allora, questa rivoluzione di cui ignoriamo le conseguenze sul destino degli uomini deve metterci in uno stato di esaltazione millenarista. Il letterato deve spaccarsi la testa a colpi di martello per esporne la materia al primo venuto. Questo modo di aprire la «factory», di far visitare l’atelier, risponde alla mia volontà di ritrovare una libertà totale. In ogni caso, quando si parla della propria madre, l’IA non può far nulla per voi. Si scrive col proprio cervello. Ma di fronte a ciò che nessuna macchina potrà dire – la relazione carnale, irriducibile, a una madre reale -, la scrittura umana detiene ancora il proprio territorio.
Lei viene accusato spesso di forzare la mano, di scivolare nell’iperbole sistematica. Questa tendenza all’eccesso non rischia di nuocere alla finezza del vostro discorso letterario?
RJ: Tutto quello che ho appena detto nelle ultime risposte è esagerato, provocatorio, ingiusto ed è così che si può sperare di progredire nell’analisi della realtà. Esagerandola. Pensare è esagerare, esagerare smisuratamente. Come fanno la lente d’ingrandimento e il microscopio. […] Mi sento come qualcuno che è appeso a un filo. C’è un tempo nella vita in cui non si sta più vivendo ma morendo. Un’agonia vivace, lesta e che può protrarsi per anni – siamo folli – diversi decenni probabilmente, ma poi ci si stacca, il frutto cade e ci si chiede se non si stia solo vivendo la caduta. Nessuna paura, nessun dolore. Spensieratezza, sete di scrivere. Scrivere, di per sé, è una gioia. Qualche settimana fa ho pubblicato questo post su X: D’ora in poi, si possono scrivere opere di finzione con l’IA. Per quanto mi riguarda, questo mi fa pensare alla strana idea di mandare un robot a fare l’amore al mio posto.
Mi resta poco tempo. Prima di partire devo farmi elefante e non lasciare dietro di me che briciole in questo negozio di porcellana che è la letteratura. Ecco ancora un’immagine. Che dopo la mia morte sia srotolata all’infinito come una stampa magica.
Teresa Lussone e Christophe Reig

Teresa Lussone è ricercatrice di Lingua e traduzione francese alla Università di Bari Aldo Moro. Specialista delle opere postume di Irène Némirovsky, ha curato con Olivier Philipponnat la nuova edizione di “Suite française” (Denoël, 2020) e di “Les Feux de l’automne” (Albin Michel, 2014).
Con Laura Frausin Guarino ha tradotto “Tempesta in giugno”, prima parte di Suite française (Adelphi, 2022). Ha scritto svariati articoli sull’autobiografia di Sartre e attualmente sta preparando l’edizione di due opere di Sophie Cottin per Classiques Garnier. Ha curato per Adelphi la raccolta di racconti “Il Carnevale di Nizza” in libreria dal 21 gennaio scorso.

Christophe Reig insegna Letteratura francese all’Università di Perpignan (Francia). Ha dedicato numerosi studi a Jacques Roubaud, Raymond Roussel, ma anche all’Ouvroir de Littérature Potentielle (OuLiPo) e ai suoi membri (tra cui Marcel Bénabou, Paul Fournel, Jacques Jouet, Hervé Le Tellier, Harry Mathews, Georges Perec…). Ha pubblicato saggi su scrittori contemporanei come Emmanuel Carrère, Régis Jauffret, Jean Lahougue e Christian Oster… Particolarmente interessato alle teorie della finzione e della transfinzione, alle varie forme di riscrittura così come ai rapporti tra arte contemporanea e scrittura (Closky, Levé…). Dopo aver codiretto fino al 2017 la rivista Formules – Revue des créations formelles con Christelle Reggiani, Hermes Salceda e Jean-Jacques Thomas, ha curato o co-curato numerosi volumi sulla letteratura e la narrativa contemporanee.