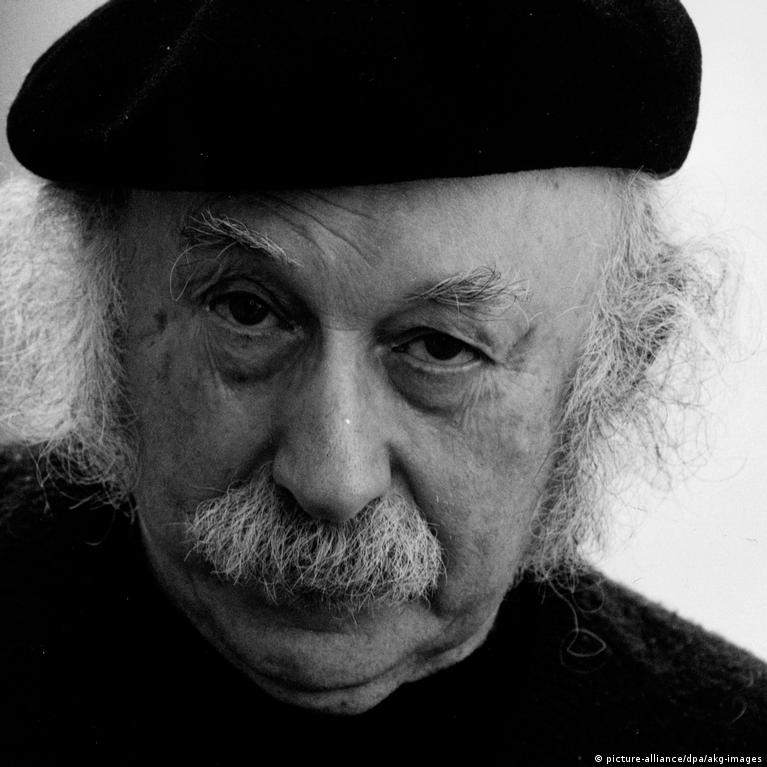Non fatevi ingannare dall’apparente semplicità di questo libretto di un centinaio di pagine, il decimo ed ultimo romanzo del grande scrittore ceco, il quarto scritto direttamente in francese, pubblicato da Adelphi nel 2013, prima ancora che uscisse in Francia con Gallimard nell’aprile del 2014. Se proprio volessimo parlare di “semplicità” dovremmo fare ricorso alla fin troppo abusata leggerezza o alla “squisita semplicità” di un piatto di gnocchi di pane o di una zuppa di cipolle preparati da uno chef stellato. Semplici sono solo le cose della vita che però bisogna saper raccontare e Kundera lo fa da grandissimo scrittore, aggiungendo poesia e complessità, mescolando banale ed essenziale, malinconia e felicità traboccante, tragedia e farsa.
Ma La festa dell’insignificanza, questo “non romanzo” costruito come un’opera teatrale in sette parti, non è affatto semplice. Ci sono infatti molti più significati di quanti possiate immaginarne in questa insignificanza, un’insignificanza che svela sorridendo l’assurdità dell’esistenza, un’insignificanza che, come dice Ramon, uno dei protagonisti, è “l’essenza dell’esistenza.”

Il romanzo si apre con Alain che camminando per le strade di Parigi osserva affascinato e turbato che la moda del momento per le ragazze è di mettere in mostra l’ombelico, “come se il loro potere di seduzione non fosse più concentrato nelle cosce, nelle natiche o nel seno, ma in quel buchetto tondo situato al centro del corpo.” Ma mentre riesce a spiegarsi il motivo per cui un uomo possa essere sedotto dalle cosce , dalle natiche e dal seno, viceversa si chiede: “come definire l’erotismo di un uomo (o di un’epoca) che vede la seduzione femminile concentrata nell’ombelico?”
Mentre Alain riflette sulle diverse fonti della seduzione femminile, Ramon, l’intellettuale in pensione, passeggia senza meta nei giardini di Lussemburgo perché ha appena rinunciato alla visita di una mostra dedicata a Chagall a causa della coda “disgustosa” alla biglietteria, di cui non vuole essere parte. Dice: “Guardali! Pensi che, d’un tratto, abbiano cominciato ad amare Chagall? Sono disposti ad andare ovunque, a fare qualsiasi cosa, solo per ammazzare il tempo che non sanno come impiegare. Non hanno idea di nulla, quindi si lasciano guidare. Sono splendidamente guidabili.”
Camminando Ramon incrocia D’Ardelo, il narcisista, che per il solo piacere di mentire finge di confessargli di avere un cancro, ma nel contempo lo invita alla sua festa di compleanno, chiedendogli se conosce qualcuno in grado di organizzarne il catering.
Dopo un’ora, Ramon è a casa di Charles, l’amico che sogna di mettere in scena una commedia di marionette su un aneddoto della vita di Stalin, da cui emergerebbe un dittatore ironico e burlone, che si prende gioco dei suoi più stretti collaboratori che non osano ridere per servile ossequio (metafora della nostra incapacità di cogliere il senso dell’ironia). I due osservano che tra questi lacchè c’è Kalinin, il funzionario con la vescica debole, che dà ancora oggi il nome alla città natale di Kant (Kaliningrad), mentre invece, ironia della Storia, il tiranno baffuto pare svanito dalla memoria soprattutto dei più giovani.
A casa di Charles c’è poi l’attore disoccupato Caliban, che si diverte a inventare nuove identità e a creare lingue immaginarie. I due fanno saltuariamente i camerieri per sbarcare il lunario.
Ecco così presentati dal narratore i protagonisti del racconto, omuncoli insignificanti che non fanno o dicono granché, sprofondati nell’inconsistenza della vita quotidiana. Tutti loro si incontreranno durante la festa nel salotto di D’Ardelo, osservatori di un mondo troppo pieno di vanità, della vacuità di un divertimento per cui ogni ospite si dà delle arie per apparire più importante di quanto non sia, si compiace dei propri successi e fa sfoggio della propria felicità intorno ai bicchieri di alcol appoggiati su un vassoio. La festa è il pretesto per Kundera per sorridere della banalità del nostro tempo, che è “comico proprio perché ha perso ogni senso dell’umorismo”.

Nonostante le poche pagine, il libro è ricco di passaggi indimenticabili come quello su Quaquelique, il seduttore, che conquista le donne con osservazioni banali, che non richiedono risposte intelligenti o presenza di spirito perché l’essere brillante le sfida a competere, mentre l’insignificanza le tranquillizza, le rilassa, rendendole più facilmente abbordabili.
È la consueta misoginia dell’autore già emersa nei precedenti romanzi e “spiegata” ne L’arte del romanzo, dove si ricorderà la distinzione tra maschilista e misogino: il primo adora la femminilità archetipa (maternità, debolezza, ecc…), esalta la propria virilità e la famiglia, mentre il secondo ha orrore della femminilità e il suo ideale è restare celibe con molte amanti…
Nel romanzo infatti, mentre gli uomini sono amici (“solo una parola è sacra: ‘amicizia’”), le donne sono per lo più assenti, personaggi secondari, a volte anche un po’ spaventosi. C’è la madre di Charles che sta morendo, quella di Alain che l’ha abbandonato alla nascita e con la quale Alain ha un dialogo immaginario, una tale M.me Frank, la vedova allegra, che ha trasformato la morte del marito in un’opportunità per dimostrare agli altri il proprio valore.
Le poche relazioni uomo-donna appena accennate sono all’insegna dell’ incomunicabilità: quella tra Alain e Madeleine per la differenza di età, quella di Caliban con la cameriera portoghese perché i due parlano lingue diverse. Più che personaggi del racconto, le figure femminili sembrano bozzetti funzionali solo a dimostrare un più generale disagio maschile.
Arte (sottratta all’individuo dalla massa), sessualità, erotismo, desiderio (un tempo piaceri assoluti, oggi banalizzati), amicizia, ironia, rapporti problematici tra uomo e donna, tra madri e figli, la politica, la vecchiaia (“le sue dichiarazioni non conformiste, che un tempo lo ringiovanivano, facevano ora di lui, malgrado l’ingannevole apparenza, un personaggio inattuale, fuori dal tempo, perciò vecchio.”) sono tra le tematiche trattate in questo libretto, in una sorta di compendio finale o di manifesto della poetica di Kundera, che, all’età di 84 anni, sa che quello che sta scrivendo potrebbe essere il suo ultimo romanzo.
I protagonisti ricordano i tempi di Stalin, di Krusciov e dell’Unione Sovietica (“un’epoca di cui non rimarranno più tracce”), elaborano discutibili teorie sulla seduzione (quanta distanza da scene ad alto contenuto erotico come quella de Il libro del riso e dell’oblio del 1978 con Karel che guarda Eva che si masturba sulle note di una suite di Bach!), riflettono sull’insignificanza e sul suo impatto sulla felicità, si confrontano sul posto che deve assumere nella vita l’assurdo e il riso, quest’ultimo tema cui, com’è noto, Kundera ha dedicato almeno tre romanzi: Lo scherzo, La vita è altrove, ma soprattutto Il libro del riso e dell’oblio. Secondo Ramon, ispirato da Hegel, “il vero umorismo è impensabile senza l’infinito buonumore, l’ “unendliche Wohlgemutheit”. Non lo scherno, non la satira, non il sarcasmo. Solo dall’alto dell’infinito buonumore puoi osservare sotto di te l’eterna stupidità degli uomini e riderne.”

Tutto finisce nell’inno di Ramon all’insignificanza, con la celebrazione della vita che in fin dei conti non significa nulla. In realtà non c’è un vero e proprio finale, così come a volerla dire tutta non c’è una trama. Non c’è descrizione fisica dei personaggi, rappresentati solo attraverso le loro discussioni e introspezioni. Nessuna parola di troppo, nessun superlativo, nessun abuso di aggettivi. Ci sono però i pensieri e le domande di sempre, sospesi come la piuma che gli ospiti della festa osservano galleggiare nell’aria in lentissima caduta. Pensieri sintetizzati, domande riformulate da un uomo consapevole di essere alle battute finali.
La festa dell’insignificanza, questa piccola grande eredità di Kundera, ricorda per la leggerezza del tocco e la vivacità della prosa gli ultimi lavori – perdonate l’azzardo – di Woody Allen, meno brillanti dei suoi film migliori, ma sempre attraenti per sapore e personalità, fascino ed eleganza. “L’insignificanza, amico mio, è l’essenza della vita. È con noi ovunque e sempre. È presente anche dove nessuno la vuole vedere: negli orrori, nelle battaglie cruente, nelle peggiori sciagure. Occorre spesso coraggio per riconoscerla in condizioni tanto drammatiche e per chiamarla con il suo nome. Ma non basta riconoscerla, bisogna amarla, l’insignificanza, bisogna imparare ad amarla. Qui, in questo parco, davanti a noi, guardi, amico mio, è presente in tutta la sua evidenza, in tutta la sua innocenza, in tutta la sua bellezza. Sì, la sua bellezza. L’ha detto anche lei: l’animazione perfetta — e del tutto inutile —, i bambini che ridono — senza sapere perché —, non è forse bello? Respiri, D’Ardelo, amico mio, respiri questa insignificanza che ci circonda, è la chiave della saggezza, è la chiave del buonumore…».”
Gigi Agnano