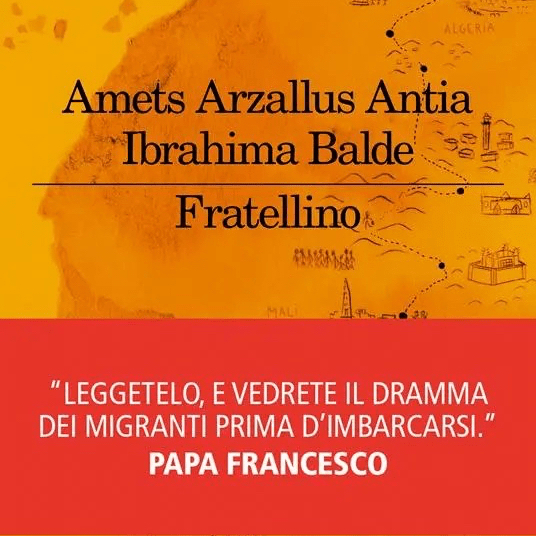“Rifugiato: sostantivo maschile, persona che ha trovato rifugio in luogo sicuro; part., individuo che, in seguito alle vicende del proprio paese, ha ottenuto asilo politico in un paese straniero.”
Più brevemente, “rifugiato” fa pensare a uno che in qualche modo ce l’ha fatta, nel senso che respira. Respira a dispetto dei vari decreti “Sicurezza” o “Cutro” che i nostri fantasiosi politici si affannano ad introdurre nel sistema normativo italiano per ridurre protezione ed accoglienza.

Chi invece non ce l’ha fatta sono gli oltre 28.000 migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo dal 2013 al 2023 (di questi, 22.300 lungo la rotta del Mediterraneo centrale).
Chi non ce l’ha fatta sono le “decine” di migranti “dispersi” – pare fossero 66, di cui 26 bambini – che erano sulla barca a vela che si è ribaltata lunedì al largo delle coste calabresi.
Chi non ce l’ha fatta sono il papà e la mamma della tredicenne superstite che i genitori li ha visti morire tra le onde.
E non ce l’ha fatta Satnam Singh, il lavoratore indiano, che sempre lunedì, nei campi vicino Latina, è stato schiacciato da un macchinario che gli ha tranciato il braccio destro e le gambe. Singh lavorava da due anni senza contratto e pare che dopo l’incidente sia stato abbandonato ancora vivo davanti casa con il braccio tagliato in una cassetta per la raccolta degli ortaggi. E’ morto dopo due giorni di agonia, non ce l’ha fatta.
Abbiamo un’umanità che annega vicino casa nostra, che muore di botte e di sevizie un po’ più in là in Libia, in Tunisia, in Turchia, o di stenti nel Sahara. Che quando arriva, se arriva, viene sfruttata come neanche le bestie meriterebbero.
Abbiamo miliardate di soldi pubblici italiani ed europei, cioè nostri, che vengono spese perché l’umanità muoia.
In questo mare magnum c’è, a titolo d’esempio, il simpatico accordo con l’Albania che ha un costo previsto (e sottolineerei “previsto”) di 653 milioni, di cui 252 per le spese di trasferta dei funzionari ministeriali. Soldi nostri perché l’umanità muoia.
Oggi, 20 giugno, è la “Giornata mondiale del Rifugiato”. Noi del Randagio vogliamo celebrarla perché ogni essere umano abbia diritto a sperare e sognare.
Gigi Agnano