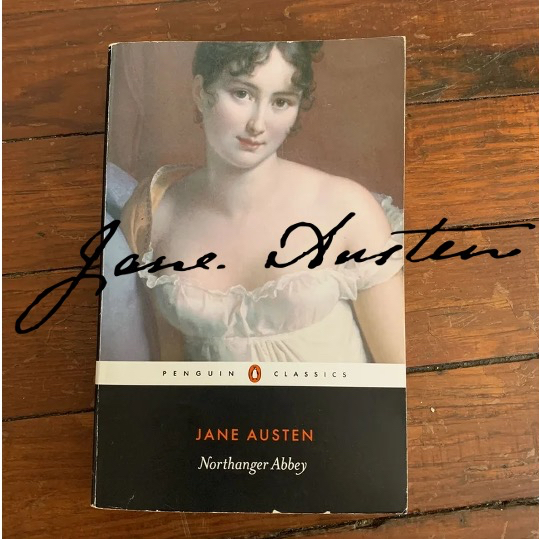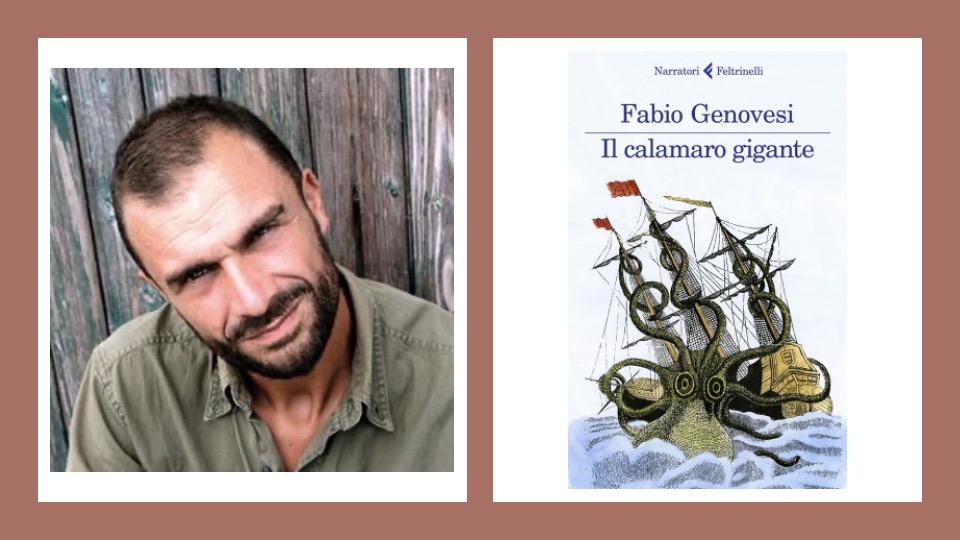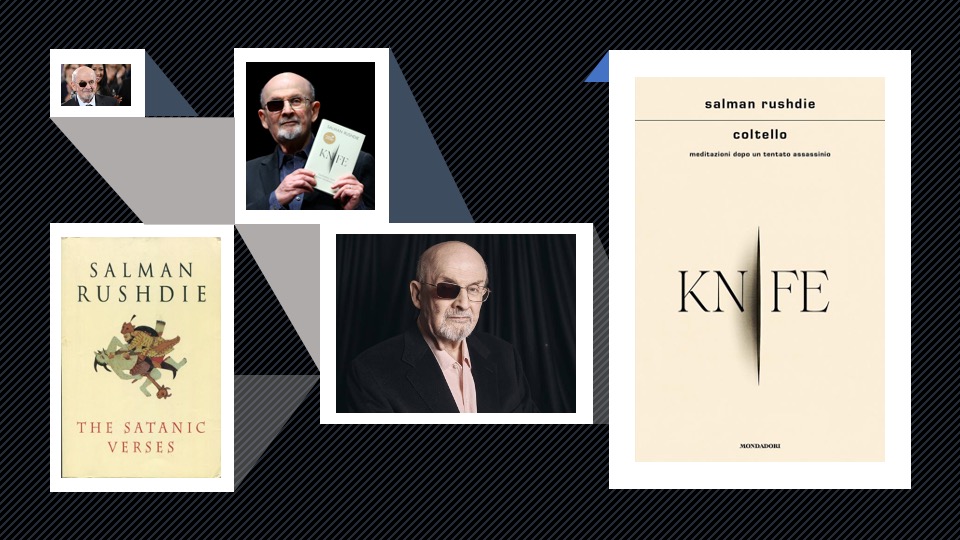L’abbazia di Northanger è uno dei libri meno conosciuti ma anche più insoliti di Jane Austen. Un romanzo in stile gotico che accompagna le vicende della sua anti-eroina, Catherine Morland, e che ben si differenzia dai romanzi dell’autrice a cui siamo abituati. Scritto per primo fu pubblicato postumo solo nel 1818 insieme a Persuasione, dallo stesso editore che aveva pubblicato Emma qualche anno prima.

A guidare le vicende di questa eccentrica storia è Catherine, una giovane ragazza di diciassette anni che vive con la sua famiglia in un piccolo paesino di campagna, dove la monotonia e lo stile di vita semplice ed ordinario non rendono facile fare nuove conoscenze. L’unico svago è rappresentato da alcune visite ad amici di famiglia e vicini di casa, tra cui gli Allen, i quali la invitano a trascorrere qualche settimana con loro nella cittadina di Bath, occasione che la giovane coglie al volo e con entusiasmo.
Catherine non è mai stata particolarmente avvezza allo studio o alle mansioni domestiche, frequenti sono infatti le allusioni dell’autrice al fatto che non sia la classica eroina che ci aspetta dai romanzi, in quanto ragazza dai modi semplici, di una bellezza scialba ed incolore, e senza alcun talento particolare, se non la sua grande passione per i romanzi gotici. Bath è il luogo ideale per fare il proprio debutto in società: eventi mondani, serate a teatro, occasioni di ritrovo in cui contano solo la forma e le apparenze.
“Vorrete concedermi che nella coppia l’uomo ha il privilegio della scelta, e la donna soltanto la facoltà di rifiutare”
Ed è proprio in queste circostanze che Catherine conosce due famiglie piuttosto influenti, i Thorpe ed i Tinley. I primi che le impongono prepotentemente la loro presenza ed i secondi di cui aspira invece a farne parte, complice il tenero incontro con Henry, uno dei figli del Generale Tinley.
“Ogni giovane signora può sentirsi vicina alla mia eroina in questo momento fatale, poiché ogni giovane signora ha, in un momento della sua vita, conosciuto un analogo turbamento. Tutte sono state, o quanto meno si sono credute, in pericolo per l’attenzione di qualcuno che desideravano allontanare, e tutte sono state ansiose e desiderose delle attenzioni di qualcuno al quale volevano piacere.”
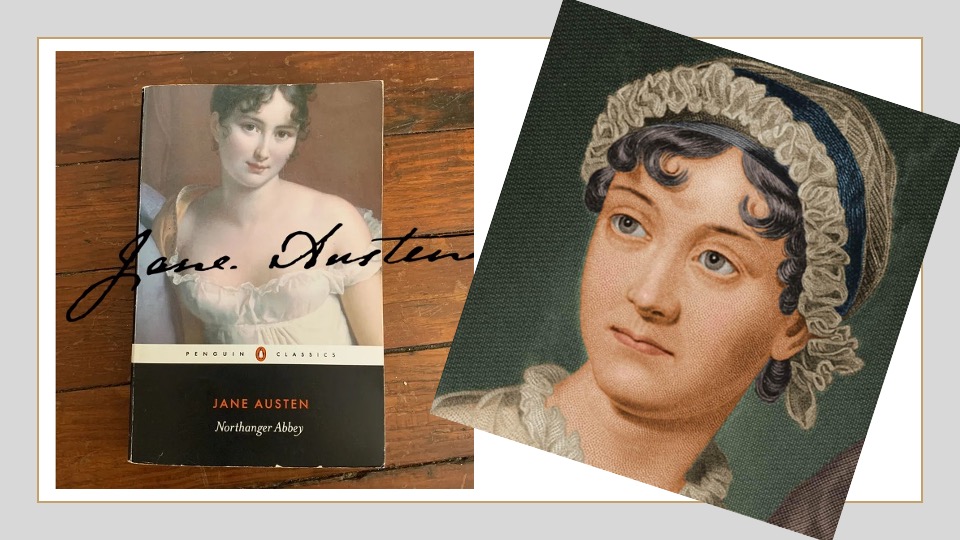
I Tinley invitano a loro volta Catherine a passare qualche giorno con loro presso l’ex abbazia di Northanger, un’antica dimora di loro proprietà che a prima vista sembra essere la perfetta scena di un crimine misterioso, proprio come i romanzi gotici a cui è tanto appassionata. E così, fantasticherie di ogni genere iniziano a farsi strada attraverso la sua fervida immaginazione.
Ma non è l’unica incomprensione di questa strana vicenda: il Generale Tinley crede di avere di fronte una ricca ereditiera come futura nuora di suo figlio, e che giustifica il suo invito presso l’abbazia che altrimenti non avrebbe avuto luogo. Uno spiacevole malinteso che tuttavia non impedisce all’eroina di questa storia di ottenere il suo tanto atteso lieto fine.
Catherine è una ragazza dei giorni nostri: inconsapevole del proprio avvenire, semplice e senza grilli per la testa, piena di sogni e speranze per il futuro. Contestualmente viene dipinta anche come una ragazza ingenua, poco posata, non particolarmente avvenente o talentuosa, e che possono essere considerati tutti degli espedienti che l’autrice utilizza per dare un carattere di maggiore autenticità al personaggio.
Pur essendo la prima opera di Jane Austen, e quindi stilisticamente prematura, è indubbio il suo modo elegante e raffinato di ricreare scene ed ambientazioni, che rende i suoi racconti mai privi di personalità. L’elemento gotico e quello romantico viaggiano ad una sintonia perfetta, creando un’atmosfera misteriosa e suggestiva, e rendendo quest’opera decisamente insolita rispetto allo stile più tradizionale di Jane Austen. Quello che invece non sappiamo è il perché l’autrice ci da solo un breve e frettoloso assaggio dell’abbazia, il luogo dove si manifesta l’elemento più spooky della storia ed il cui ruolo viene confinato soltanto agli ultimi capitoli.
Un classico non solo originale ma anche profondamente attuale.
Veronica Saporito
Veronica Saporito: Specializzata in Finanza e Controllo presso una rinomata azienda nel settore della nutrizione sportiva. Appassionata lettrice, dal 2020 scrive di libri su Instagram dove è conosciuta come thatslibridine, e sul suo blog: www.libridine.net, a cui è legata anche una newsletter mensile. Collabora con case editrici, uffici stampa, ed ha supportato come media partner il festival letterario comasco Parolario Junior.