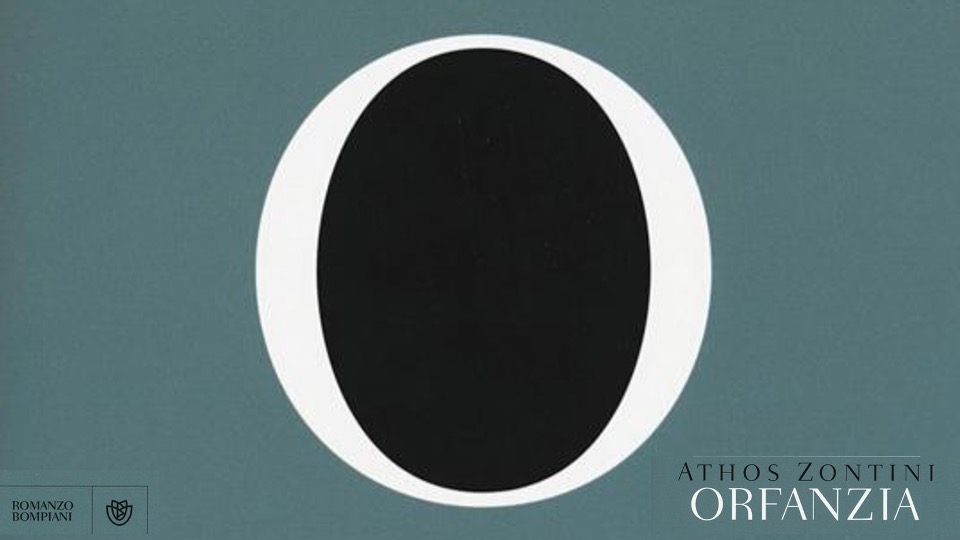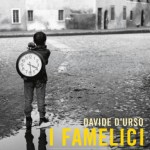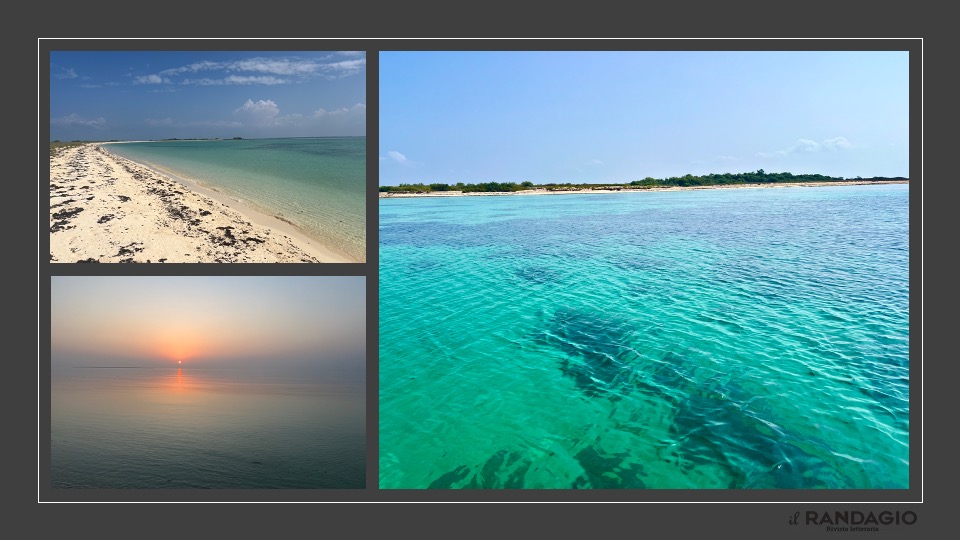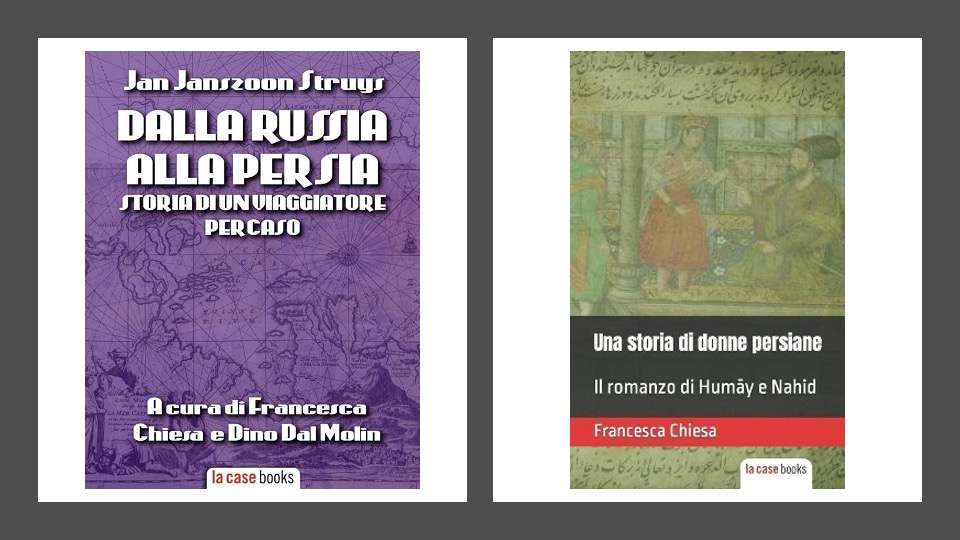“Ognuno può suonare senza timore e senza esitazione la nostra campana. Essa ha voce soltanto per un mondo libero, materialmente più fascinoso e spiritualmente più elevato. Suona soltanto per la parte migliore di noi stessi, vibra ogni qualvolta è in gioco il diritto contro la violenza, il debole contro il potente, l’intelligenza contro la forza, il coraggio contro la rassegnazione, la povertà contro l’egoismo, la saggezza e la sapienza contro la fretta e l’improvvisazione, la verità contro l’errore, l’amore contro l’indifferenza.”
Adriano Olivetti
Una qualche osservazione preliminare è indispensabile per comprendere l’interesse che nel contesto della trattazione presente ha la vicenda della fabbrica di Ivrea e di Adriano Olivetti, un “unicum” assoluto, non solo nella dimensione nazionale ma, con tutta evidenza, nell’intera vicenda del capitalismo mondiale.
La novità presenta due aspetti diversi eppure fra loro intrinsecamente intrecciati: da un lato, il progetto culturale e, in definitiva, politico, che ispirò e innervò l’intera costruzione olivettiana, la fondazione del Movimento Comunità, da Olivetti fondato nella città di Torino nel 1948, e le cui idee egli espresse in modo organico ne L’ordine politico delle comunità; dall’altro, lo straordinario successo industriale che portò l’azienda di Ivrea a livelli di primato planetario con la costruzione del primo computer elettronico da tavolo: un successo che entrò in rotta di collisione con l’IBM, il colosso statunitense che, in piena guerra fredda, collaborava col programma militare del Pentagono, impegnato nel perfezionamento dei dispositivi elettronici di guida dei missili intercontinentali.

Al primo degli aspetti, meritevole in altra sede di un più ampio approfondimento, dedicheremo solo qualche breve annotazione, per rimarcare la differenza abissale fra l’impianto solidaristico, egualitario, fondato su una proiezione umanistica dei rapporti sociali e l’esatto opposto in quegli stessi anni rappresentato dalla Fiat di Agnelli, diretta da Vittorio Valletta, impegnata nella repressione anticomunista, nelle schedature dei suoi operai, nella creazione dei reparti confino, del tutto refrattaria a qualsivoglia ipotesi di ricaduta sul territorio dei profitti d’azienda, aliena dalla benché minima propensione ad un’idea di responsabilità sociale dell’impresa capitalistica.
La fabbrica “totale” e “L’ordine politico delle comunità”
“L’uomo che vive la lunga giornata nell’officina non sigilla la sua umanità nella tuta da lavoro”
Adriano Olivetti
“Adriano Olivetti si sarebbe stupito, nel sentire affermare con enfasi, con il taglio perentorio onde viene formulata questa idea al presente, che la missione dell’impresa è primariamente quella di creare valore per gli azionisti”
Luciano Gallino
Adriano Olivetti riuscì a creare nel secondo dopoguerra italiano un’esperienza di fabbrica nuova e unica al mondo in un periodo storico in cui sullo scenario planetario plasmato dalla guerra fredda si fronteggiavano due grandi potenze: capitalismo e comunismo. Olivetti credeva che fosse possibile creare un equilibrio tra solidarietà sociale e profitto e che l’organizzazione del lavoro dovesse comprendere un’idea di felicità collettiva, di armonia generale che valorizzava genio, inventiva e generava efficienza.
Sotto l’impulso delle fortune aziendali e dei suoi ideali comunitari, Ivrea negli anni cinquanta raggruppò una quantità straordinaria di intellettuali che operavano (chi in azienda chi all’interno del Movimento Comunità) in differenti campi disciplinari, inseguendo il progetto di una sintesi creativa tra cultura tecnico-scientifica e cultura umanistica.
Si può dire che Adriano Olivetti tenesse sì in gran conto la tecnica e la scienza, ma non come fini a se stesse, bensì come strumento di liberazione umana.
Nella fabbrica di Ivrea sorse un welfare aziendale che si estese e riverberò sull’intera città, alla ricerca di un equilibrio tra profitto, democrazia e giustizia sociale: gli operai della Olivetti arrivarono a percepire salari fino al 30 per cento superiori a quelli stabiliti dal contratto collettivo per un orario di lavoro di 45 ore, inferiore di tre ore a quello a quello standard di quel tempo; beneficiarono di convenzioni per case e asili accanto alla fabbrica, ebbero una biblioteca in azienda con libri da poter leggere durante le pause. “I servizi sono un dovere che deriva dalla responsabilità sociale dell’azienda” sosteneva Olivetti che si esprimerà così:
“La fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti. Deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia. Io penso la fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica, giusto? (…). In fabbrica si tengono continuamente concerti, mostre, dibattiti. La biblioteca ha decine di migliaia di volumi e riviste di tutto il mondo. Alla Olivetti lavorano intellettuali, scrittori, artisti, alcuni con ruoli di vertice. La cultura qui ha molto valore”.
Luciano Gallino ricorda che
“la Olivetti fu la prima grande azienda italiana, e una delle primissime in Europa, a introdurre il sabato interamente festivo. Nel 1957, negli stabilimenti di Ivrea, la settimana lavorativa fu ridotta a 5 giorni, a parità di salario”.
Anche all’interno della fabbrica l’ambiente era diverso: durante le pause i dipendenti potevano servirsi delle biblioteche, ascoltare concerti, seguire dibattiti, e non c’era una divisione gerarchica tra ingegneri e operai, in modo che conoscenze e competenze fossero alla portata di tutti. L’azienda accoglieva anche architetti, artisti, scrittori, disegnatori e poeti, poiché Adriano Olivetti riteneva che la fabbrica non avesse bisogno solo di tecnici ma anche di persone in grado di arricchire il lavoro con creatività e sensibilità.
Fu Olivetti a commissionare a Renato Guttuso il grande quadro “Boogie Woogie”, otto metri di inno alla vita per la guerra appena conclusa, collocato nella mensa dei modernissimi stabilimenti di Scarmagno, simbolo di un’opera d’arte fruibile ogni giorno da migliaia di lavoratori. L’iniziativa attestava la volontà di includere anche l’arte negli obiettivi dell’impresa, e di ritenerla anzi una delle forme creative più importanti, rivelatrici e formative, perseguendone l’acquisizione con una assiduità e continuità totalmente estranee alla cultura della borghesia industriale del tempo.
Guttuso – in linea con lo spirito generale che si respirava nella fabbrica di Ivrea, raccontò ad un giornale di aver chiesto alla Olivetti che il suo lavoro fosse pagato ad ore, secondo il guadagno di un operaio specializzato.

Fin dagli anni Quaranta, con la collaborazione di Cesare Musatti, era stato istituito presso la fabbrica il Centro di Psicologia. E furono proprio le critiche al meccanismo tayloristico che portarono ad una riflessione sul contenuto delle varie fasi della lavorazione, a esperimenti di lavoro in gruppo, al fine di arricchire per quanto possibile il lavoro operaio.
Nell’adolescenza Adriano Olivetti sperimentò il lavoro di fabbrica. Fu il padre, Camillo, ad inviarlo per l’intero periodo estivo, a lavorare nell’officina di famiglia. L’esperienza contribuì a persuaderlo che il lavoro faticoso e non meno ripetitivo che si svolgeva fra le mura di un’azienda era tutto meno che gratificante. L’intero suo impegno fu dedicato a creare una fabbrica di tipo nuovo, ispirata da un’architettura orientata alla ricerca del bello, priva di barriere, diversa dall’universo concentrazionario che costituiva il modello dell’impresa manifatturiera tradizionale.
Nell’idea di Olivetti l’umanizzazione del lavoro si sarebbe potuta raggiungere percorrendo due vie: la prima aperta dal progresso tecnologico e, in prospettiva, dall’automazione quale strumento di liberazione dagli aspetti più penosi del lavoro; la seconda basata sulla costituzione di un assetto proprietario capace di conferire ai lavoratori il controllo dell’attività produttiva e della stessa azienda. Ma di queste due condizioni, che potremmo definire due pilastri di uno stesso ponte, una compiuta democrazia economica, nessuno, neppure Adriano Olivetti, è mai riuscito a costruire l’arcata centrale. Nemmeno Adriano Olivetti. La trasformazione della proprietà dell’azienda in una fondazione o in una qualsiasi altra forma statutaria che avesse visto il passaggio verso un potere sostanziale dei lavoratori, sino a conferire ad essi il controllo su tutto l’andamento dell’azienda e non solo sui servizi sociali, è rimasta a giacere nell’opera teorica e nelle intenzioni di Adriano Olivetti. Va poi tenuto conto che Adriano Olivetti non era l’azionista di maggioranza, come dire che il suo potere oggettivo era in realtà limitato. Egli doveva di continuo fare i conti con il gruppo degli azionisti, a cominciare dalla sua famiglia che quando non gli fu avversa guardò alla sua opera e al suo cimento come alle velleità di un visionario; una parte di questo gruppo gli era più vicina, ma altre componenti erano tendenzialmente restie dinnanzi ai suoi progetti, se non addirittura ostili. Tuttavia, Adriano Olivetti non dimenticò mai l’imperativo categorico che gli fu inculcato dal padre Camillo il quale, dubbioso e in qualche caso contrario ai nuovi metodi organizzativi, scrisse al figlio: “Tu puoi fare qualunque cosa, tranne licenziare qualcuno per motivo dei nuovi metodi, perché la disoccupazione involontaria è il male più terribile che affligge la classe operaia”.
FINE PARTE 1 DI 3 [… continua]
Dino Greco

Dino Greco scrittore, saggista, giornalista, è stato direttore del quotidiano Liberazione. Ha pubblicato numerosi articoli e saggi su Il manifesto, Rinascita, Critica Marxista, Carta, Alternative. Il suo ultimo lavoro del 2024 è “Il bivio. Dal golpismo di Stato alle Brigate Rosse: come il caso Moro ha cambiato la storia d’Italia” (Bordeaux)