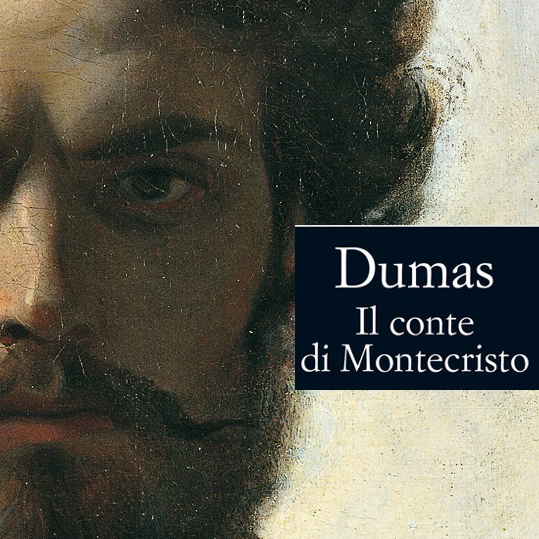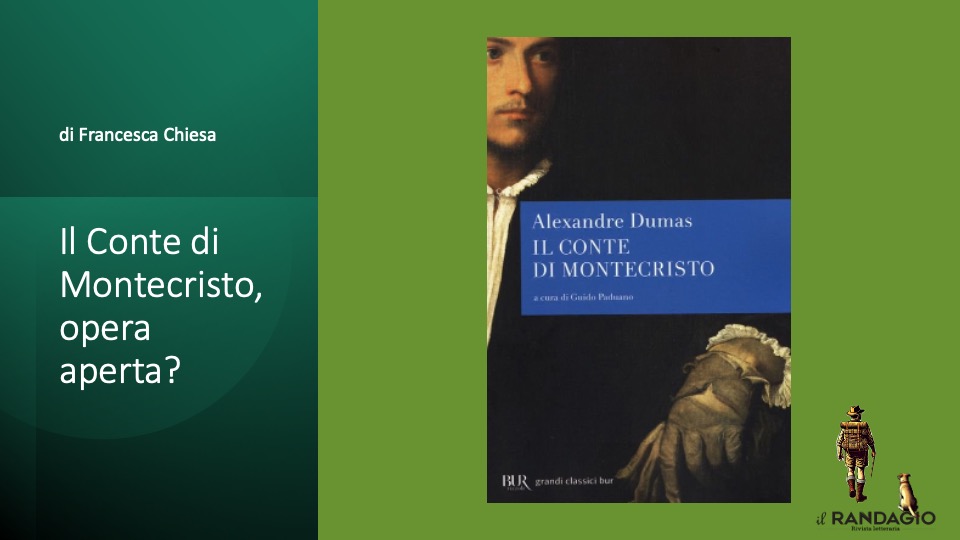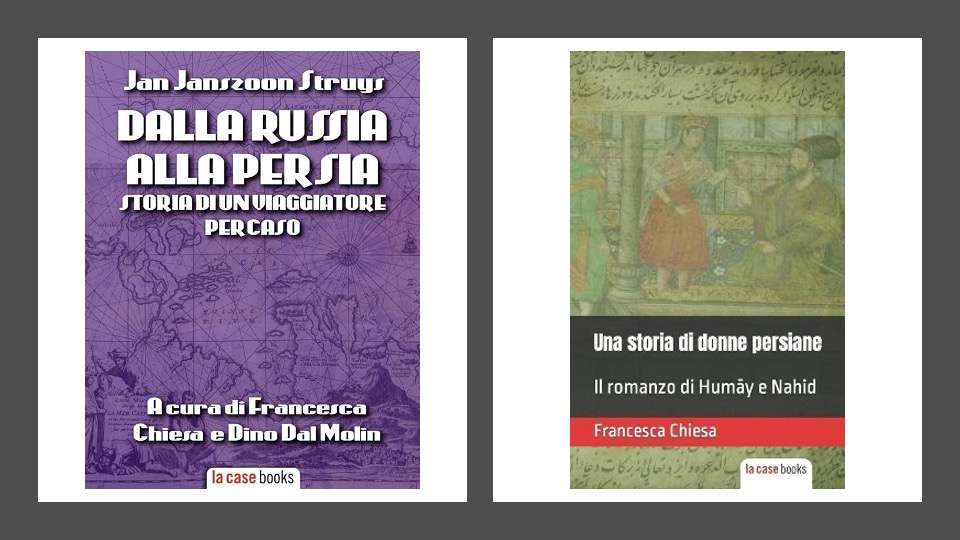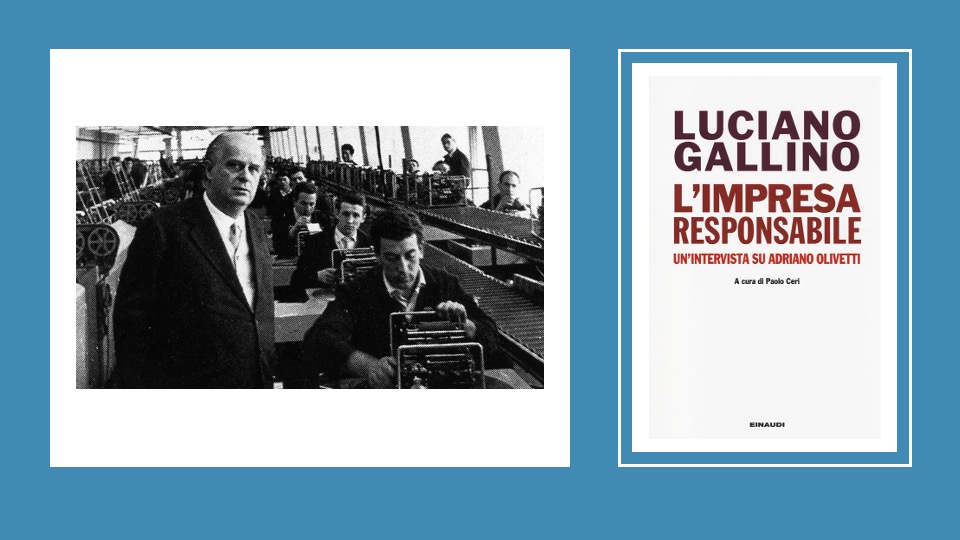Un mese di vacanza al mare è lungo, molto lungo. Specialmente se sei una donna giovane e sola, dal lunedì al venerdì sera, e con due bambine da accudire. Certo, nel week end diventa tutto più bello, la famigliola si ricompone e io sono felice. Lo sono anche le piccole pesti, che si arrampicano sul povero papà, distrutto da una settimana di lavoro e due ore di viaggio per raggiungerci. Abbiamo ragionato molto sulla necessità di questa separazione forzata, arrivando alla conclusione che fosse necessaria per il benessere delle nostre figlie, Martina soprattutto, affetta da una perniciosa asma bronchiale che le toglie il fiato. Fatti i dovuti conti, che non tornano mai, abbiamo preso in affitto questa bella casetta sulla spiaggia, una villetta unifamiliare che mi consente di non dover usare la macchina per portarle al mare. La zona non è di quelle turistiche per giovani leoni, e non ha molte attrattive neppure per gli stranieri, però il mare è pulito e l’aria è tanto tersa e salmastra da pizzicare il naso, la mattina presto. Quella è l’ora giusta per portare le bambine a salutare il mare, come le ho insegnato, spiegando che ci si va quando non c’è molta gente perché lui, il mare, ama il silenzio.

Anch’io lo amo, ma è decisamente molto più divertente quando in spiaggia c’è almeno qualche bagnante con cui scambiarsi un sorriso e un buongiorno. A volte siamo talmente sole che le bambine si riaddormentano, stese sulle stuoie all’ombra, cullate dal respiro del mare, ed io mi ritrovo a non sapere cosa fare del mio tempo. Leggo, tantissimo. Ascolto musica in cuffia per ore. Penso tanto, all’importanza del tempo e alla sua duttilità, che lo fa adattare ai nostri stati d’animo, alle stagioni della vita, all’intensità dei sentimenti. Rifletto sul fatto che siamo un po’ suoi prigionieri, del tempo, intendo, che diventa padrone dei nostri spazi, delle esistenze stesse.
Mi guardo intorno, mettendo a fuoco mille dettagli, per impegnare i lunghi intervalli tra la colazione e il pranzo, tra la merenda e la cena. Proprio di fronte all’ombrellone che pianto sempre nello stesso punto, in linea d’aria con la nostra casa ma leggermente più a destra, c’è un’altra costruzione bassa, a due piani. E’ certamente una casa molto più vecchia di quella che abitiamo, anche se tenuta bene, e proprio per questo motivo c’è un particolare che ha colpito la mia attenzione dal primo momento. La terrazza del piano superiore, quasi interamente circondata da piante belle e rigogliose che ne assicurano la riservatezza, è letteralmente dominata da un grande orologio che si vede persino dalla spiaggia. Il quadrante è rotondo e bianco, mentre la cornice e le lancette grosse e puntute sono nere. Somiglia ad un classico orologio da stazione e molte volte al giorno, in modo automatico lo sguardo corre a consultarlo, rimanendo invariabilmente delusa. Sì perché, ed è questa l’anomalia, l’orologio è fermo ad un’ora che è sempre la stessa, le 10 e 25, di mattina o di sera non è dato sapere. In una casa bella e curata come quella è un dettaglio stonato, un pugno in un occhio, e tante volte ho pensato di dirlo ai proprietari, appena ne incontro qualcuno. In effetti c’è un bel po’ di gente che anima la casa sulla spiaggia, durante il giorno e la sera, ma nessuno di loro esce mai a fare la spesa in paese o una passeggiata sul bagnasciuga. Probabilmente lo fanno in orari diversi dai miei, comunque sulla terrazza c’è sempre movimento.
Durante le mie minuziose osservazioni ho notato anche un curioso alternarsi degli occupanti, una sorta di turnistica che ho scoperto essere sempre uguale. Dopo tre settimane di permanenza sono certa di aver individuato una rotazione fissa: di mattina giovani, di sera anziani, mai tutti insieme. Al principio pensavo fosse un caso, dopotutto non è che stavo a guardare il terrazzino di continuo. Ne ho parlato anche con Paolo, mio marito, ma lui si è messo a ridere, poi ha detto che era un fatto normalissimo. I giovani vanno al mare, hanno voglia di sole e di fare casino in spiaggia, le persone anziane se ne stanno in casa e la sera cenano al fresco. Mi è sembrato tutto sommato realistico, anche se ricordando le mie estati da ragazzina mi viene in mente qualcosa di diverso. Noi la mattina volevamo dormire, dopo aver fatto le ore piccole, e quindi scendevamo al mare a mezzogiorno, mentre i miei genitori erano in spiaggia alle sette del mattino, per prendere il sole migliore. Allora mi sono messa d’impegno ad osservare la strana famiglia “dell’orologio”, così come l’ho battezzata. Ho contato, di mattina, sette giovani occupanti del terrazzino, quattro maschi e tre femmine, tutti sui diciotto/vent’anni. Al riparo del mio ombrellone, li ho visti ogni giorno apparire e sparire tra le piante messe a protezione della loro privacy. Belli, biondi e castani, ben vestiti, forse solo un po’ classici per i nostri giorni, mai in costume da bagno. Stanno lì forse un’oretta, poi rientrano in casa e non li vedo più sino alla mattina successiva. Per scorgere altro movimento mi tocca aspettare la sera, dopo le dieci, quando sul terrazzo bagnato dalla luce morbida di alcune lampade, arrivano gli adulti. Sarebbe meglio dire i vecchi, se mi si passa il termine rude. Sono anche loro sette, a pensarci bene. Quattro uomini e tre donne, anziani. Raffinati, discreti, sempre perfettamente abbigliati, come dovessero andare ad una cena importante. Invece stanno lì, parlando a bassa voce e cenando. Si sentono solo i rumori lievi dei piatti che si toccano, il tintinnio dei bicchieri e qualche sommessa risata, ogni tanto. Stanno insieme poco: un’ora, un’ora e mezza al massimo, poi si ritirano in casa. Li rivedo la sera successiva e tutto si ripete. Il mese di villeggiatura è quasi passato, e questo è l’ultimo fine settimana nel quale Paolo ci raggiungerà per poi riportarci a casa. Finalmente, penso io. E’ stato un mese lunghissimo, buono solo per preparare la piccola ad un inverno meno complicato e regalarci un colorito uniforme e sano. Io ho sofferto enormemente la solitudine, e ho già deciso che, da oggi in poi, le vacanze si fanno tutti insieme e basta.
L’unico diversivo è stata l’osservazione della famiglia “dell’orologio”, che però non sono riuscita a conoscere. Allora mi prende un puntiglio che stenta a lasciarmi, una fissazione che non passa. Non posso andarmene senza aver chiesto ai vicini di casa perché non rimettono in funzione il grande orologio del terrazzo. Magari è un reperto storico, magari non sanno chi possa andare ad aggiustarlo, magari è un oggetto d’arredamento ed è proprio così che dev’essere, fermo alla stessa ora per sempre. Ho deciso, vado a bussare alla casa. Prendo le bambine, una per mano e l’altra nel passeggino, e mi dirigo verso la villetta. Suono al campanello, già quasi pentita dell’impulso irrazionale che mi ha preso, ma non mi risponde nessuno. Sono le sei del pomeriggio e forse sono tutti fuori. Faccio una passeggiata, come tutte le sere, e mi dirigo verso il centro del piccolo paesino che ha ospitato la mia solitaria vacanza, per passare nell’unico bar dell’unica microscopica piazza e prendere un caffè. La signora Rosa, la proprietaria con la quale scambio volentieri qualche chiacchiera gentile non c’è, stranamente. Mi accoglie una signora grassoccia, con i capelli biondo platino, che dice di essere la cognata. Racconta di una sciatica violenta che costringe la signora Rosa a letto, e si lancia in una filippica infinita sulla presunta incoscienza dell’assente, rea di non avere troppa cura di sé. Tra elenchi di medicinali e digressioni sui suoi, di dolori, riesco finalmente ad incuneare una domanda. “Mi sa dire qualcosa della famiglia che abita nella casa vicino alla nostra?” – “Perché?” mi chiede con gli occhi sgranati.
Io rimango un po’ spiazzata, non mi sembra di aver chiesto qualcosa di tanto strano. “Volevo salutare qualcuno dei ragazzi, oppure le signore che vedo la sera sul terrazzo, ma ho bussato e non mi ha risposto nessuno …” dico un po’ imbarazzata dalla sua espressione che continua ad essere attonita. Finalmente, dopo un minuto che mi sembra eterno, la vedo riaversi e guardarmi ancora, stavolta dubbiosa. Forse riflette sul mio stato mentale, considerato quello che mi racconta subito dopo. Al rientro sono ripassata davanti alla casa, ho provato a bussare il campanello ripetutamente e senza speranza, ancora incredula per le parole della signora del bar, che si chiama Iole ed è molto chiacchierona. Quello che mi ha detto, con un sorriso complice, sembra inventato, ma ormai sono sicura che sia la verità. Non credo che lo racconterò a nessuno, ecco perché lo scrivo, mentre cerco una spiegazione che non c’è. Io, però, sento di essere stata spettatrice di qualcosa di speciale. Forse l’unica, e chissà per quale scopo. Ripenso alla storia che mi è stata raccontata con un brivido.
La famiglia che abitava la casa dell’orologio era composta, sessant’anni prima, da tre sorelle e quattro fratelli, oltre ai genitori. Erano stati proprio loro a chiudere in cantina i figli, dopo averli storditi con del sonnifero, per nasconderli ai tedeschi che stavano rastrellando ebrei. Non avrebbero mai permesso che portassero via i ragazzi, piuttosto prendessero loro, avevano pensato. Così era stato, erano stati fatti prigionieri e portati via, con uno dei treni ormai tristemente famosi.

I figli si erano risvegliati nella cantina buia e ancora piena di scaffali sui quali, un tempo, venivano conservate le bottiglie di vino pregiato che il padre teneva come reliquie. Avevano cercato di uscire, scoprendo con orrore che la porta non si apriva dall’interno. Forse avevano gridato sino allo sfinimento, chiedendosi perché, mille volte perché, fino a quando la morte li aveva presi, uno dopo l’altro. Li avevano trovati molto tempo dopo, al termine della guerra, e la spiegazione dell’accaduto era stata offerta da un bigliettino lasciato dai genitori sulla credenza. Poche righe nelle quali dicevano ai figli che al loro risveglio non li avrebbero trovati, ma che preferivano morire, piuttosto che vederli nelle mani dei nazisti. Loro dovevano vivere e divertirsi, perché erano giovani e avevano una vita da vivere. Mai avrebbero pensato che il destino fosse tanto beffardo, e che se li prendesse tutti, con una zampata sola.
Mi giro e rigiro nel letto, e non riesco a prendere sonno, in questa ultima notte al mare. Paolo russa piano, non ha intuito nulla del mio stato d’animo, forse è troppo stanco per guardarmi con attenzione. Allora esco fuori, e mi dirigo sulla spiaggia silenziosa e buia. Prima esito, ma poi mi giro e guardo in su, verso la terrazza e verso l’orologio fermo sempre alla stessa ora, quella che ha determinato la fine di sette giovani vite che avevano tutto il futuro davanti. Avrebbero vissuto fino a diventare vecchi e saggi, così come li vedevo la sera, nelle infinite e pacate cene, dopo essere stati giovani e spensierati, come mi si presentavano alla luce del sole. Il tempo li ha fatti prigionieri, e li tiene legati da qualche parte. Sempre uniti, eternamente insieme. Volevano che qualcuno lo sapesse e hanno scelto me. Forse dovrei sentirmi orgogliosa, penso, mentre dietro le piante sul terrazzo vedo una mano agitarsi, in un saluto. Ricambio, commossa, e me ne ritorno a letto.
Letizia Vicidomini

Letizia Vicidomini è nata a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, ma raggiunge Napoli da vent’anni per lavoro, e ne ha fatto lo scenario privilegiato delle sue storie.
E’ stata speaker per le maggiori emittenti nazionali e regionali (RTL 102.5, Kiss Kiss, Radio Marte, Radio Punto Nuovo), attrice e e voce pubblicitaria. Alcuni suoi scritti sono diventati pièce teatrali ad opera dell’attrice e regista Ramona Tripodi.
La prima pubblicazione è del 2006, il romanzo “Nella memoria del cuore” edito da Akkuaria, così come “Angel”, del 2007. Nel 2012 è la volta della storia ambientata tra la Puglia e l’Argentina, “Il segreto di Lazzaro”, edito da CentoAutori e impreziosito dalla prefazione di Maurizio de Giovanni.
Nel 2014 per Homo Scrivens pubblica “La poltrona di seta rossa”e l’anno successivo, sempre con la stessa casa editrice, passa al noir con “Nero. Diario di una ballerina”. Il romanzo è nella sestina dei finalisti del premio “Garfagnana in giallo 2015” e Menzione speciale al Festival Giallo Garda. La “trilogia dei colori” si completa con “Notte in bianco” (2017), di nuovo finalista in Garfagnana. Nel 2019 pubblica, sempre per Homo Scrivens, “Lei era nessuno”. Ad aprile 2021 Homo Scrivens ripubblica “Il segreto di Lazzaro” in una versione aggiornata e rivista, che vince il Premio Internazionale Giallo Garda, VII Edizione.
Suoi racconti sono inclusi in numerose antologie. Tra le principali “Una mano sul volto” e “Diversamente amici” , curate da Maurizio de Giovanni (Ed. A est dell’Equatore), “Napoli in cento parole” e “Napoli a tavola in cento parole” (Perrone Editore), “Free Zone” (Echos) e “Il bivio” (Oakmond Publishing), “Attesa. Frammenti di pensiero“, “Un giorno per la memoria” (Homo Scrivens). Pubblica nella collana di Mursia Giungla Gialla curata da Fabrizio Carcano, “La ragazzina ragno” che trionfa nell’edizione 2021 del Garfagnana in giallo, in finale anche al Premio Misstery legato al Festival del Giallo a Napoli. A novembre 2022 esce “Dammi la vita” con la stessa casa editrice, che entra nuovamente nella cinquina votata dai lettori del Premio Misteri.
A marzo 2023 pubblica per SetteChiavi il thriller “Salvami“, racconto lungo che apre la collana Passepartout curata da Diego Di Dio, che si piazza sul podio della X edizione di Giallo Garda. Viene menzionata da Ciro Sabatino nella “Storia del giallo a Napoli” (Homo Scrivens 2024) tra le rappresentanti di spicco della “scuola napoletana” capeggiata da Maurizio de Giovanni.
A ottobre 2024 pubblica “Non si uccide il passato. Il male sporca Napoli” (Mursia Editore), che riceve immediatamente riscontri positivi da blog e lettori.