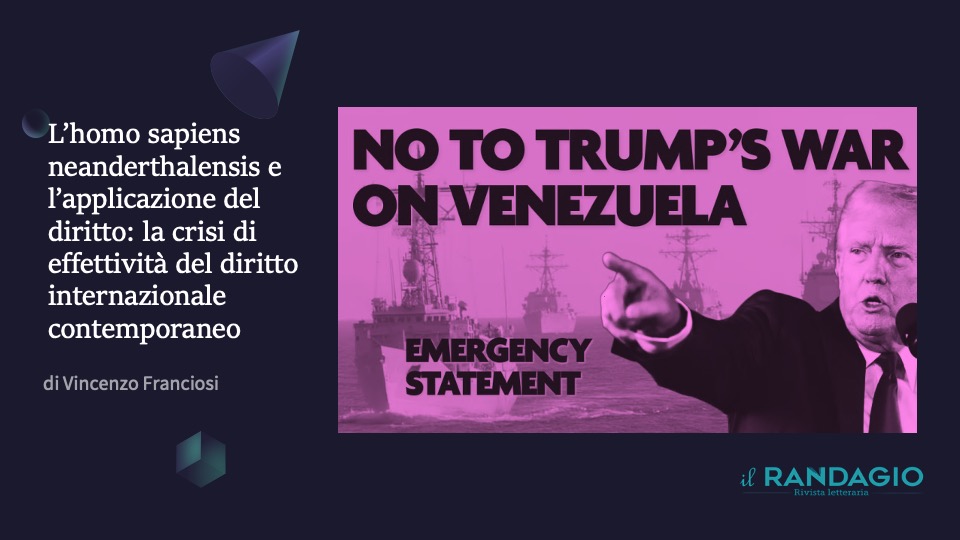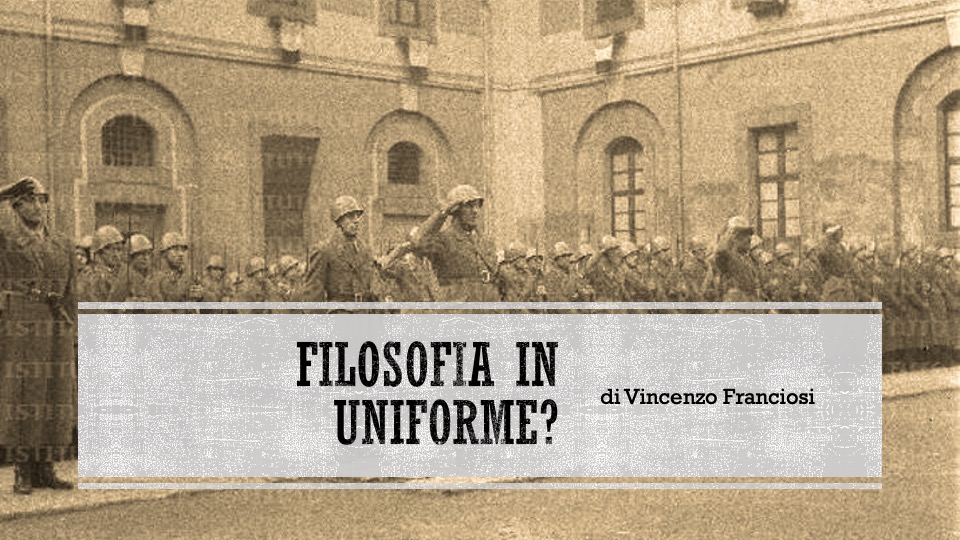C’è un modo elegante, e dunque pericoloso, di imporre il silenzio: non proibendo le parole, ma alterandone il significato. Non dicendo “non puoi parlare”, ma stabilendo in anticipo che cosa, tra ciò che dici, sarà interpretato come odio.
La definizione dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) di “antisemitismo” si colloca esattamente in questa logica: nasce per proteggere, ma per come è costruita e soprattutto per come viene impiegata finisce spesso per disciplinare. È una tecnologia del discorso prima ancora che un criterio morale. La parte iniziale della definizione, considerata in astratto, sembra persino ovvia: l’antisemitismo come “percezione” degli ebrei che può esprimersi come odio; e le sue manifestazioni retoriche e fisiche dirette contro persone, proprietà, istituzioni comunitarie e luoghi di culto. Fin qui, nulla da eccepire. Tutti i razzismi agiscono così: colpiscono corpi, simboli, memorie, spazi. Il problema comincia quando la definizione si correda di esempi “illustrativi” che dovrebbero aiutare a riconoscere il fenomeno e invece ne spostano il baricentro. È lì che la tutela si rovescia in immunità; ed è lì che la lotta all’odio rischia di diventare un dispositivo di governo del dissenso.
Gli esempi 1–6 e 11 appartengono a una costellazione chiara: incitamento alla violenza contro ebrei, stereotipi complottistici, responsabilità collettiva, negazionismo della Shoah, accusa di doppia fedeltà. Sono fenomeni storici riconoscibili; colpiscono ebrei in quanto ebrei; ricalcano strutture note dell’odio antiebraico moderno. La parte controversa è un’altra: i punti 7–10, quelli che toccano Israele. È qui che la definizione, anziché restare una griglia per distinguere l’odio razziale, entra nel campo minato della politica internazionale e vi porta strumenti concettuali impropri, perché elastici, indeterminati, facilmente convertibili in arma.
Per evitare equivoci, è utile riportare integralmente la formulazione di questi esempi, poiché è in essi che si concentra la torsione:
7) “Negare al popolo ebraico il diritto all’autodeterminazione, ad esempio sostenendo che l’esistenza dello Stato di Israele è un’impresa razzista”.
8) “Applicare doppi standard a Israele, richiedendogli un comportamento non atteso o non richiesto a nessun’altra nazione democratica”.
9) “Utilizzare simboli e immagini associate al tradizionale antisemitismo (ad esempio l’accusa di ‘deicidio’ contro gli ebrei o l’immagine del ‘libello di sangue’) per caratterizzare Israele o gli israeliani”.
10) “Fare confronti tra la politica contemporanea di Israele e quella dei nazisti”.

Il punto 7, “negare al popolo ebraico il diritto all’autodeterminazione, ad esempio sostenendo che l’esistenza dello Stato di Israele sia un’impresa razzista”, è già una dimostrazione del corto circuito. L’autodeterminazione non è un talismano: è un principio storico che convive con altri principi e non annulla, per definizione, le questioni di eguaglianza e di discriminazione. Trasformare l’accusa “Israele è razzista” in segnale di antisemitismo significa scambiare un giudizio politico e giuridico con un odio etnico. Si potrebbe, semmai, discutere quella tesi, contestarla, confutarla; ma farne un indicatore automatico di razzismo antiebraico è un salto concettuale. È la scorciatoia che un pensiero democratico dovrebbe respingere.
Il punto 8, quello dei “doppi standard”, è ancora più insidioso. “Doppio standard” è un’accusa che, in teoria, richiederebbe comparazioni, criteri espliciti, dimostrazione. Nella pratica, funziona diversamente: non confuta, insinua. Non discute i fatti, interroga la coscienza. Serve soprattutto a spostare il discorso dal contenuto all’intenzione dell’oratore: non “quello che dici è falso”, ma “lo dici perché sei prevenuto”. Con un colpo solo, la critica politica viene delegittimata e l’attenzione morale trasformata in sospetto. A quel punto qualunque dissenso diventa colpevole, perché non esiste un universo in cui ogni attore politico venga criticato con la stessa intensità, lo stesso spazio mediatico, lo stesso tempo. La politica non è contabilità morale. “Doppio standard”, se diventa criterio operativo, è un dispositivo perfetto di censura morbida: non serve dimostrare antisemitismo, basta attribuire un movente.
Il punto 9, quello relativo all’uso di simboli e immagini dell’antisemitismo tradizionale per caratterizzare Israele, contiene un nucleo sensato: quando riemergono figure storiche come il libello di sangue o la demonizzazione teologica dell’ebraismo, siamo davanti a una continuità riconoscibile dell’odio. Ma anche qui la definizione apre una porta: se manca una competenza storica nel riconoscere quelle immagini, qualunque metafora forte può essere trascinata dentro il perimetro dell’odio. E una volta che la rete si allarga, diventa rete a strascico: non protegge più dalle immagini razziste, assorbe la polemica politica in quanto tale.
Infine il punto 10, quello sui paragoni con i nazisti, è emblematico del clima emotivo in cui la definizione opera. Ma trasformare il paragone in prova morale di antisemitismo significa costruire un tabù che non riguarda più l’odio antiebraico, bensì l’intangibilità di uno Stato. Una definizione che pretende di riconoscere l’odio non dovrebbe automatizzare i giudizi: dovrebbe distinguere, verificare, contestualizzare. Altrimenti finisce per sacralizzare uno Stato non per le sue virtù democratiche, ma per la potenza simbolica del trauma europeo. Il cuore della questione sta qui: nei punti 7–10, la definizione opera una sovrapposizione quasi continua tra popolo ebraico e Stato di Israele. È il passaggio più assurdo e più pericoloso, perché produce un cortocircuito che finisce per essere, in un senso serio e non polemico, paradossalmente antiebraico. Una definizione nata per proteggere gli ebrei incorpora così una premessa tipica dei dispositivi razzisti: l’idea di un soggetto collettivo ebraico unitario che si identifica organicamente con uno Stato e ne assume la rappresentanza. Proprio questo meccanismo – la collettivizzazione essenzialista – è stato storicamente un motore dell’odio antiebraico: ridurre gli ebrei a un corpo unico, dotato di volontà comune, e dunque responsabile “in quanto tale”. Fondendo popolo e Stato, la definizione costruisce le condizioni perfette per due esiti simultanei: la criminalizzazione della critica politica a Israele, e l’esposizione simbolica degli ebrei alla responsabilità delle azioni di uno Stato. In altri termini, non separa l’odio dalla critica, li confonde, e confondendoli, non riduce l’odio, ma lo ristruttura e lo rende più manipolabile.
Tutto questo accade mentre in Palestina si consuma un genocidio: bombardamenti, fame, assedio, punizione collettiva, deportazioni, disumanizzazione. In questo contesto, l’uso politico dell’accusa di antisemitismo diventa un’operazione moralmente intollerabile: serve a rovesciare la realtà, a spostare l’attenzione dal crimine all’accusatore, e a trasformare la denuncia in colpa. Non è un’astrazione, ma una dinamica concreta che ha inquinato università, teatri, giornali, piazze. Si parla meno di ciò che accade e più di ciò che “si può dire”. È la sostituzione della verità con il protocollo.
Qui emerge un secondo paradosso, altrettanto rivelatore: oggi molti ambienti dell’estrema destra, eredi culturali del razzismo nazi-fascista europeo, sono filoisraeliani. Non perché abbiano scoperto l’antirazzismo, ma perché riconoscono in Israele ciò che ammirano: lo Stato identitario, la militarizzazione permanente, l’idea di confine come destino, la gerarchia delle appartenenze, la violenza come linguaggio politico. L’estrema destra non ama gli ebrei, ama la forma dello Stato che vede come proprio ideale, e così può riciclarsi come “difensore contro l’antisemitismo” mentre resta xenofoba e autoritaria. Proclamarsi filoisraeliani diventa un certificato di rispettabilità. È una mutazione cinica, ma perfettamente coerente.
In questo quadro, parlare di una legge “contro l’antisemitismo” che isoli l’odio antiebraico come categoria autonoma non è un atto neutro, ma una scelta di potere. È qui che si colloca il ddl Delrio, promosso dall’area “riformista” del Partito Democratico, in un gesto che appare tanto più inquietante quanto più risulta sovrapponibile, per logica e direzione, a proposte analoghe provenienti dalla destra radicale. Non importa il lessico benevolo (prevenzione, educazione, osservatori, monitoraggi, deleghe sul digitale) perché l’effetto istituzionale è già scritto: la creazione di una cornice pubblica di interpretazione in cui la critica a Israele può essere resa sospetta per definizione.
Un elemento decisivo, spesso rimosso nel dibattito pubblico, è che il ddl Delrio incontra una contrarietà netta anche da parte di intellettuali italiani di origine ebraica. Anna Foa, storica che ha dedicato studi fondamentali alla storia dell’ebraismo e delle persecuzioni, ha espresso un dissenso esplicito, denunciando la torsione per cui la tutela contro l’odio antiebraico finisce per trasformarsi in un dispositivo di protezione politica dello Stato di Israele e di compressione della critica. E non si tratta di una posizione isolata: un appello pubblico sottoscritto da studiosi e scrittori, tra cui numerosi firmatari di origine ebraica, ha contestato la stessa impostazione, rifiutando l’idea che l’odio antiebraico debba diventare un’eccezione normativa separata dal resto dei razzismi e segnalando il rischio di una deriva censorio-identitaria proprio nel momento in cui la libertà di parola e di ricerca dovrebbe essere difesa con maggiore rigore.
Il punto decisivo, però, non è soltanto la questione Israele. È la questione dell’eguaglianza. Una legge che considera l’odio antiebraico come fenomeno “a sé”, distinguendolo strutturalmente dal razzismo contro arabi, rom, africani, migranti in genere, produce una gerarchia delle vittime. E una gerarchia delle vittime è razzismo istituzionalizzato: non perché difende gli ebrei, che devono essere difesi come chiunque, ma perché stabilisce che alcune discriminazioni meritano un trattamento speciale mentre altre restano normalizzate, tollerabili, periferiche. È il contrario dell’articolo 3 della Costituzione: l’uguaglianza come principio universale, non come eccezione selettiva. Un antirazzismo che funziona per eccezioni non è antirazzismo: è amministrazione politica delle vittime.
C’è infine un dettaglio linguistico, che dettaglio non è. “Antisemitismo” è un’aberrazione terminologica: i semiti non sono solo gli ebrei. Semiti sono gli arabi (quindi anche i palestinesi) e storicamente fenici, aramei, cananei, assiri, accadi e tanti altri popoli del Vicino Oriente antico. Il termine nasce in un’Europa ottocentesca che cercava etichette pseudoscientifiche per nobilitare l’odio antiebraico. È diventato un tecnicismo storico e in certi contesti può restare tale; ma oggi, come parola sacra, agisce da strumento ideologico. Sarebbe più corretto dire antiebraismo, o odio antiebraico. Chiamare le cose col loro nome significa anche impedire che una parola venga monopolizzata per costruire immunità.
Odio antiebraico è ciò che colpisce gli ebrei in quanto ebrei: violenza, stereotipi, responsabilità collettive, negazionismo. Critica politica è ciò che colpisce uno Stato, un governo, una legge, un esercito, una prassi. Il principio democratico è altrettanto semplice: nessuno Stato è sacro, nessuna istituzione è intoccabile; sacra è la dignità delle persone. Separare popolo e Stato non è una concessione, ma il requisito minimo per non ricadere nella logica del razzismo. Confonderli, come fa la definizione dell’IHRA nella sua parte più controversa, significa creare le condizioni della censura e, insieme, alimentare il risentimento che il razzismo sfrutta sempre.
Per questo il ddl Delrio va respinto non perché “combatte l’odio”, ma perché lo fa nel modo peggiore: trasformando un concetto storico in una tecnologia politica di controllo del discorso, e creando un’eccezione privilegiata che frantuma l’uguaglianza. È un errore democratico prima ancora che un errore teorico.
In conclusione, questo disegno di legge va contrastato non perché minimizzi l’odio antiebraico, ma perché lo separa, lo assolutizza e lo trasforma in un’eccezione, inaugurando una gerarchia delle discriminazioni. Uno Stato che seleziona quali razzismi meritino un trattamento speciale e quali no, non sta combattendo il razzismo: lo sta amministrando. E una Repubblica fondata sull’uguaglianza non può permettersi una legge che, nel nome dell’antirazzismo, finisce per tradire l’articolo 3 e legittima l’idea più pericolosa di tutte: che esistano vittime più degne di altre.
Vincenzo Franciosi

Vincenzo Franciosi è professore associato di Archeologia Classica. Ha scavato in vari siti dell’Italia meridionale quali Fratte (SA), Buccino (SA), Montescaglioso (MT), Pompei (NA). Ha pubblicato studi sulle importazioni ceramiche corinzie di età geometrica nell’isola d’Ischia e sulle loro imitazioni locali; sulla ceramica figurata attica del V sec. a.C.; sull’urbanistica pompeiana e sugli scavi dell’insula VII, 14 a Pompei; sul culto della Mefite in Valle d’Ansanto; sulla statuaria arcaica in marmo dall’Acropoli di Atene; sulla statuaria in bronzo dalla Villa dei Papiri ad Ercolano; sulla statuaria policletea. È stato insignito, per l’insieme degli studi e delle indagini condotti nel campo dell’Archeologia Classica, del Premio Anassilaos 2020-21 (XXXII-XXXIII) “Arte, Cultura, Economia, Scienze” – Premio Μνήμη per l’Archeologia, Reggio Calabria, 13 Novembre 2021.