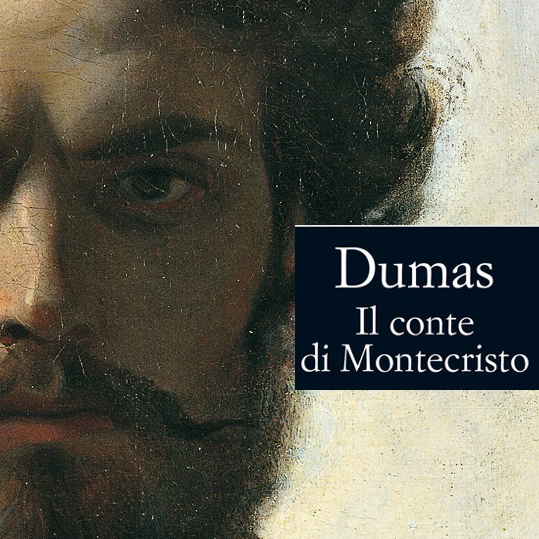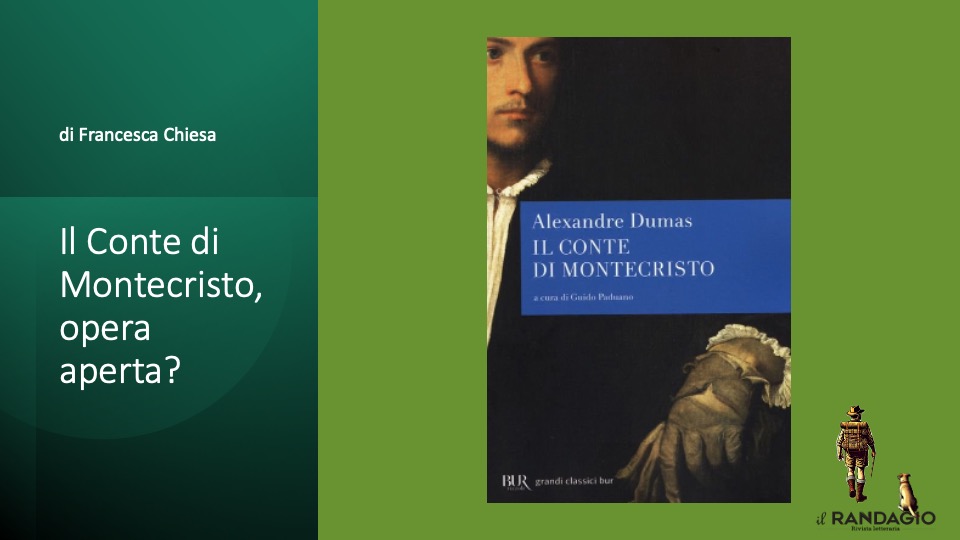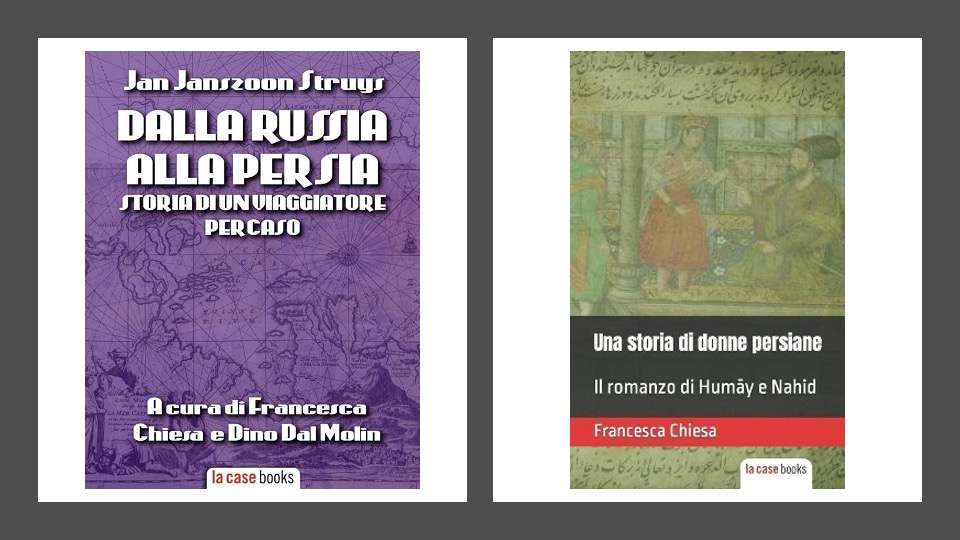Nel 1844 Alexandre Dumas inizia la pubblicazione a puntate del Conte di Montecristo, destinato a diventare il romanzo per eccellenza sul tema della vendetta. La penna dell’autore traccia magistralmente l’evoluzione di questo sentimento, che diventa sempre più dominante nella vita del protagonista. La sua esistenza, già segnata irrimediabilmente dagli eventi che hanno scatenato il desiderio di rivalsa, viene plasmata da una vendetta nata dall’invidia altrui.

L’invidia si rivela ben più pericolosa della gelosia: mentre quest’ultima si limita al desiderio di possedere ciò che altri hanno, l’invidia spinge all’azione, mirando a privare gli altri di quanto possiedono. È proprio questo il motore che spinge Danglars e Fernand, con la complicità di Caderousse, ad agire contro il giovane marinaio Edmond Dantès. Fernand brama Mercédès, la promessa sposa di Dantès; Danglars ambisce alla posizione di capitano del Pharaon destinata al giovane. Per questo motivo, fanno recapitare a Villefort, sostituto procuratore del re, una lettera anonima che accusa falsamente Dantès di essere un agente bonapartista. Villefort, temendo per la propria carriera, pur consapevole dell’innocenza del giovane, lo fa incarcerare in isolamento nel Castello d’If come pericoloso criminale. Così, ciascuno dei tre – Fernand, Danglars e Villefort – riesce a rimuovere l’ostacolo alle proprie ambizioni. Nel romanzo, fatta eccezione per pochi personaggi, tutti sono mossi dalla brama di potere, posizione sociale e ricchezza. Persino amicizie e matrimoni vengono orchestrati per puro interesse economico, probabile riflesso della società che Dumas aveva osservato nei suoi viaggi nell’Europa ottocentesca, particolarmente a Parigi. Come scrive l’autore a proposito di Danglars: «Era un calcolatore, nato con la penna all’orecchio e un calamaio al posto del cuore: per lui esistevano solo addizioni e sottrazioni, e le cifre potevano essere molto più preziose degli uomini, quando queste andavano ad accrescere ciò che gli uomini minacciavano di diminuire»
Ben diverso è Edmond Dantès, marinaio di appena 19 anni ma già saggio e responsabile. Nella sua imminente promozione a capitano del Pharaon, guadagnata grazie alla stima dell’armatore Morrel, vede l’opportunità di costruire una famiglia con Mercédès e garantire una vita migliore al suo anziano padre.
Nelle prime pagine del romanzo, Dantès ci appare come un giovane affabile e cortese, privo di malizia e incapace persino di concepire il male negli altri. Questa ingenuità lo porta a non comprendere le ragioni della sua incarcerazione, non sospettando di nessuno, tanto che nei primi tempi di prigionia rischia di impazzire nel tentativo di dare un senso alla sua condizione. L’incontro con l’abate Faria, altro prigioniero di grande esperienza e profondo conoscitore dell’animo umano, si rivelerà fondamentale. Faria diventa per lui amico, padre e mentore eccezionale, fornendogli quella raffinata formazione culturale e linguistica che lo caratterizzerà negli anni a venire. È Faria ad aiutare Dantès a ricostruire gli eventi, guidandolo con la sua saggezza: «A meno che un cattivo pensiero nasca dall’errore, la natura umana ha orrore del crimine. Però la civiltà ci ha dato dei bisogni, dei vizi, dei falsi appetiti che a volte ci portano a soffocare i nostri buoni istinti, conducendoci al male. Da qui discende la massima: se vuoi scoprire il colpevole, comincia cercando di capire a chi poteva tornare utile il crimine».
Quando Dantès, supportato da Faria, scopre finalmente la verità, subisce una profonda trasformazione interiore che lo stesso abate percepisce con rammarico: «Ora rimpiango di averti aiutato nelle tue ricerche, e di averti detto tutte quelle cose […] Perché ti ho insinuato nel cuore un sentimento che prima non c’era: la vendetta». Questo desiderio di rivalsa, maturato durante gli anni di prigionia, spoglia Dantès della sua innocenza e purezza giovanili, sostituendole con un’unica, ossessiva missione.
Il male subìto spesso indurisce l’animo, rendendolo insensibile alla sofferenza altrui. Ne è esempio emblematico l’impassibilità con cui il Conte di Montecristo assiste a un’esecuzione, incoraggiando i giovani e pallidi Albert e Franz a non distogliere lo sguardo. Quando uno dei condannati riceve la grazia all’ultimo momento, l’altro, fino ad allora calmo e rassegnato, esplode in un moto di rabbia. Il commento del Conte rivela tutto il suo disincanto e la sua misantropia: «Portate due pecore al macello, e fate capire a una delle due che l’altra non morirà. Quella si metterà a belare di gioia! Ma l’uomo – l’uomo creato a immagine di Dio, l’uomo che segue come legge suprema l’amore verso il prossimo, l’uomo che ha voce per esprimere il proprio pensiero – cosa dice quando scopre che il suo compagno è salvo? Una bestemmia. Onore all’uomo, capolavoro della natura, re del creato!»

Il fascino del Conte di Montecristo seduce non solo i personaggi del romanzo ma anche il lettore, che impara a conoscerlo non attraverso monologhi interiori o introspezioni, ma mediante i suoi numerosi e avvincenti dialoghi e attraverso la sapiente narrazione di Dumas: «[…] tutti gli sguardi si posavano su di lui. Era quella pelle traslucida, i ricci neri, il volto calmo e puro, lo sguardo profondo e malinconico, la bocca disegnata con una finezza straordinaria, che assumeva tanto facilmente una piega di disprezzo profondo. Forse c’erano uomini più belli, ma non ce n’erano di più significativi, in un certo senso».
Il piano di vendetta del Conte si compie inesorabilmente, portando alla rovina le famiglie di Villefort, Danglars e Fernand, coinvolgendo anche i loro figli innocenti. Questo solleva una questione morale: è giusto che i figli paghino per le colpe dei padri? E ancora: può considerarsi giustizia la vendetta di un uomo ormai ricco e potente? Se così fosse, significherebbe ammettere che il benessere materiale possa compensare le ferite dell’anima – ma sappiamo che non è così. Ciò che è stato sottratto a Dantès non potrà mai essergli restituito, e il suo animo porta ancora le cicatrici indelebili di quell’antica sofferenza.
I tre cospiratori, ormai dimentichi del male inflitto, si trovano improvvisamente di fronte a una resa dei conti che il Conte considera guidata dalla Provvidenza. È questa convinzione che lo motiva e lo giustifica: si sente investito di una missione divina per punire i colpevoli e premiare i giusti. Sebbene questa posizione possa apparire presuntuosa, in diversi passaggi del romanzo il Conte mostra di riconoscere i segni della Provvidenza che, al momento opportuno, ripaga il male commesso o consola chi ha sofferto. Ne è esempio la sua generosità verso la famiglia Morrel, dove l’onestà dell’armatore viene premiata con la salvezza. In presenza dei Morrel, il Conte ritrova momenti di serenità e spesso cerca la loro compagnia come antidoto all’aria ‘immonda’ che respira con coloro che deve frequentare per attuare la sua vendetta. Questo dettaglio è significativo perché dimostra che, nonostante il cambiamento interiore, Dantès non ha perso completamente la sua integrità morale.
La conferma definitiva giunge nell’epilogo del romanzo, dove emerge che Dantès ha considerato il tesoro ereditato da Faria solo come strumento per la sua vendetta. Una volta compiuta la sua missione, la figura del Conte di Montecristo perde la sua ragion d’essere: le ricchezze nascoste sull’isola diventano irrilevanti per la felicità di Edmond Dantès, che ora cerca la pace dell’anima, della coscienza e il perdono di quel Dio in cui non ha mai smesso di credere. Solo ricevendo conferma di poter essere nuovamente oggetto d’amore, potrà godere senza rimorsi della ritrovata libertà. Particolarmente significativo è il modo in cui il Conte premia i Morrel: sia con il padre che con il figlio Maximilien, il dono giunge solo un attimo prima della catastrofe imminente. Non interviene prima, ma attende che il dolore raggiunga il limite del sopportabile; solo allora, inaspettatamente, la disperazione si trasforma in gioia estatica. Come dice Dantès stesso: «Solo chi ha conosciuto la miseria più estrema merita di conoscere il suo contrario. Bisogna aver voluto morire, Maximilien, per sapere quanto sia bello vivere».”
Elena Realino

Elena Realino, è nata a Castrovillari, in provincia di Cosenza. Studia le pagine della letteratura con passione e spirito critico. Impegnata nel sociale, laureata in Lingue e Culture Moderne all’Unical. Crede che lo studio delle letterature straniere possa essere la chiave di accesso alla società poliedrica in cui viviamo e possa accorciare le distanze rispetto a realtà e mondi altrimenti ignoti o poco conosciuti.