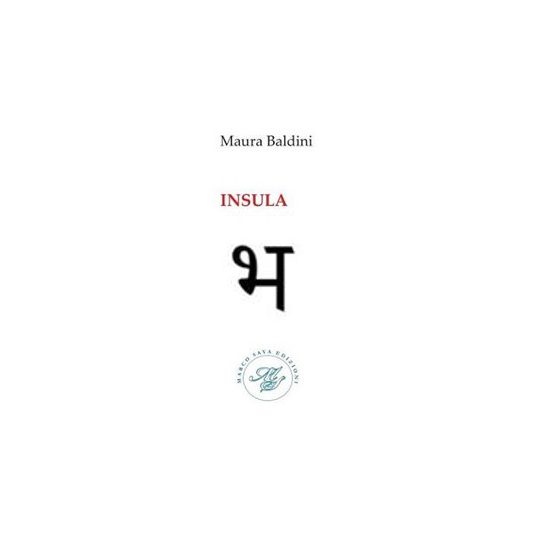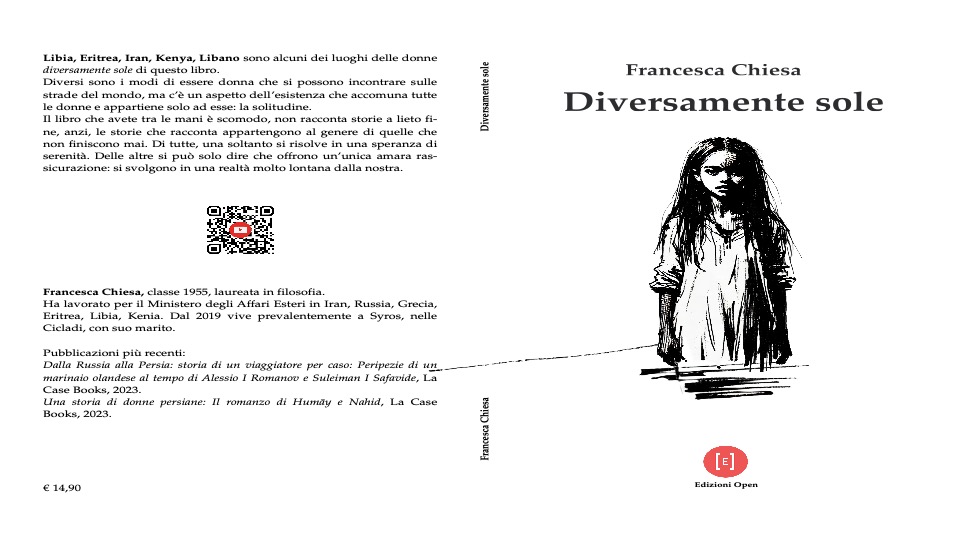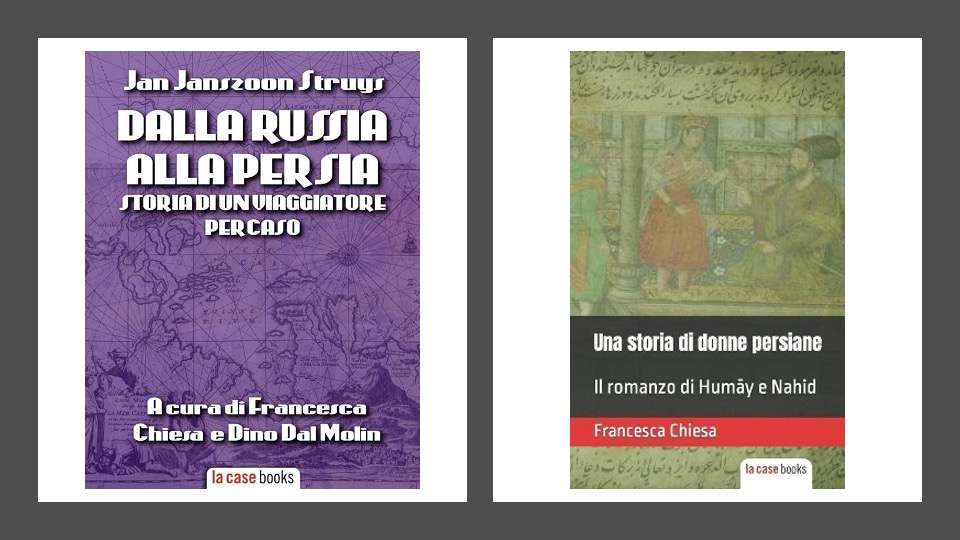Se ritratti in/versi (Bertoni Editore, 2024) costituisce, come suggerisce lo stesso titolo, una raccolta di ritratti – non solo a base di parole, ma talvolta raddoppiati attraverso la rappresentazione visiva, in grafite e pastelli a olio su carta, ché l’autrice è pittrice oltre che poeta, mentre in/versi allude non solo alla versificazione ma anche all’inversione data dalla scelta, parafrasando una fortunata mostra di Lea Vergine, di dedicare questi ritratti all’ “altra metà” dell’universo creativo, quella femminile – questa successiva, e fin ora ultima, raccolta poetica di Silvana Leonardi, psicogeometrie erranti (2025), pubblicata per la stessa casa editrice della precedente, oltre che per la stessa collana, Aurora, e prefata ancora da Bruno Mohorovich – curatore della collana – si configura piuttosto come un autoritratto. Meglio ancora come un autoritratto che – come avviene nella pittura cubista o futurista ed anche, per certi versi, in alcune prove impressioniste, benché con strumenti ed esiti differenti – possiede uno sviluppo non solo nello spazio, ma anche nel tempo, dal momento che i componimenti raccolti abbracciano un arco di quasi un decennio. Per quanto ciò sia dissimulato attraverso una disposizione di questi ultimi che non concede nulla alla diacronia, rigorosamente basata sull’ordine alfabetico dei titoli. La non staticità di tale autoritratto è inoltre garantita dal carattere dichiaratamente errante della sua opera, participio presente che associato alla psicogeometria rimanda immediatamente al metodo montessoriano, ma, a sua volta, la psicogeometria potrebbe richiamare alla mente la psicogeografia situazionista, consapevole delle implicazioni emotive proprie dell’ambiente che abbiamo intorno, nonché la deriva, ovvero la principale metodologia che traduca in pratica la disciplina psicogeografica.

Le derive situazioniste tuttavia – come è noto – sono strettamente legate all’ambito urbano. Leonardi, vice versa, pur mantenendo fermissima la relazione tra emozione e ambiente, ne evoca costantemente uno dai tratti ben poco antropizzati. Il suo spazio e il suo tempo sono quelli del mito pre-cristiano, ove l’ancoraggio alla natura e ai suoi ritmi abbraccia la sfera dell’estetica, ma anche quella della morale e persino della politica, intesa chiaramente nel senso più alto del termine. Come “strega e tarantolata quasi in trance”, come “sciamana sciamannata”, l’autrice ci dà così costantemente conto di impregiudicate esplorazioni entro una realtà che confina col sogno sempre pronto a farsi segno. E la gaia inquietudine di tale peregrinazione è restituita appunto dallo stesso curvarsi della sostanziale linearità della sua poesia verso il visivo: la scelta di evidenziare in neretto alcune parole, o parti di parole, di usare il maiuscolo, di eliminare gli spazi tra una parola e l’altra, di aumentare le dimensioni del carattere e, soprattutto, tratto più che mai caratterizzante i suoi versi, di allinearli al centro piuttosto che distribuirli uniformemente, in maniera tale da dare forma a impensabili figure geometriche per lo più assimilabili a rombi, ma talvolta persino a cerchi, irregolari.
Se tale peculiare modellare plasticamente la scrittura acquista, tra l’altro, più o meno consce valenze espressive, se non espressionistiche, assai visualmente evocativo è anche il significato più convenzionale cui i segni mettono capo, sollecitando un mondo archetipico di infallibile fascino e di inequivocabile senso. La Luna è forse la co-protagonista più ricorrente, e sulle implicazioni femminili di tale corpo celeste, fin da tempi antichissimi, è persino superfluo soffermarsi – con essa talvolta si rasenta l’identificazione: «la Luna nel mio corpo / mi illumina da dentro». Subito affianco porrei il mare-madre – ulteriormente dipanabile in variazioni «tra/mare e a/mare» -, un pur non inedito slittamento della più consueta, ma meno dinamica, associazione tra terra e madre, testimonia ancora la passione di Leonardi per l’assonanza-allitterazione e rende palese, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la matrice del suo sentire. La stessa che tra il 1980 e il 1981, giovane laureata in Storia dell’Arte e in Filosofia, la conduce a porre a Roma, sua città natale, la questione della produzione artistica al femminile attraverso mostre e dibattiti che coinvolgono studiosi del calibro di Giulio Carlo Argan, Maurizio Calvesi, Simonetta Lux, Dario Micacchi, Filiberto Menna e Marilena Pasquali, in significativa coincidenza cronologica con quanto Lea Vergine va facendo a Milano, ideando la sopra evocata mostra L’altra metà dell’avanguardia (1980). Una spinta che giunge fino ai nostri giorni, giacché un filo rosso corre da allora fino almeno alla già ricordata raccolta del 2024, composta da trenta ritratti di artiste, per lo più poete, spesso “fuori canone”, nelle cui «vicende autobiografiche mi sono rispecchiata».

Ma anche la matrice che ancora prima, nel 1978, la conduce ad inscenare una performance nella Pineta di Ostia, appena devastata da un incendio, operazione inaugurale del suo percorso che si inscrive in un decennio notoriamente assai pervaso – come i nostri tempi, ma con tante, inevitabili differenze – da una ansia ecologica. Ed anche qui, considerando la sua poesia recente, il cerchio si chiude perfettamente, benché temporaneamente. Malgrado l’afflato ottimista di fondo, a tratti profondamente vitalistico, che connota il suo errare psicogeometrico, la dimensione del mito non è sempre al riparo – e forse non potrebbe essere altrimenti in tempi funesti come questi – dai miasmi tossici della storia, contemporanea. Allora il vitalismo non si spegne ma si tramuta in indignazione, invettiva: «scoppio / di rabbia ed orrore / e lo sconforto cresce / implacabile invade / cuore e mente / scoppio / d’intolleranza / – ed è ora di dirlo – / per tutti i delinquenti / che per loro profitto / hanno distrutto il mondo». E se fosse necessario essere ancora più espliciti: «perduta l’armonia sapiente della natura / la contesa tra il molteplice e l’uno / è divenuta eterna / e tutti noi / in / folle / discesa / verso l’abisso / colpiti da infezione dell’orrore / destinati al declino / e all’estinzione / estrema malattia la distruzione / di alberi prati foreste / e acque dolci / di mari e monti / e infinite bellezze / che abbiamo dissipato / nel nome del guadagno».
Qui però la prospettiva sembra almeno in parte cambiata, giacché non si tratta più – o non solo – di puntare il dito sulle responsabilità altrui. L’umanità tutta – o, quanto meno, il mondo occidentale -, e quindi la stessa autrice – e forse, chissà la stessa felicità dell’arte e della poesia – Walter Benjamin non sostiene forse che ogni documento di civiltà è anche documento di barbarie? – viene posta sul banco degli imputati. Non di meno ella ridiviene fieramente accusatrice quando si tratta di confrontarsi col mondo della cultura, di stigmatizzare le brutture quotidiane agli occhi – e alle orecchie – di chi interroga il linguaggio e lo fa guidato dal senso etico: «di non cader per tracotante eccesso / nel banalmente ovvio e consueto / risaputo fortuito arbitrario /accademico arrogante / autoreferenziale / egocentrico / efferato / gioco / di gruppo / subdolamente / spacciato per poesia».
Stefano Taccone

Stefano Taccone è nato a Napoli nel 1981. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Metodi e metodologie della ricerca archeologica e storico-artistica all’Università di Salerno. Attualmente è docente di Storia dell’arte nella Scuola secondaria di II grado. Ha pubblicato le monografie Hans Haacke. Il contesto politico come materiale (Plectica, 2010), La contestazione dell’arte (Phoebus Edizioni, 2013; Iod Edizioni, 2015), La radicalità dell’avanguardia (Ombre Corte, 2017), La cooperazione dell’arte (Iod Edizioni, 2020), La critica istituzionale. Il nome e la cosa (Ombre Corte, 2022); le raccolte di racconti Sogniloqui (Iod Edizioni, 2018) e Morfeologie (Iod Edizioni, 2019), il romanzo Sertuccio (Iod Edizioni, 2020) e le raccolte di poesie Alienità (Edizioni Divinafollia, 2019), Terrestri d’adozione (Edizioni Progetto Cultura, 2021) e Sciogliete le rime (Campanotto Editore, 2023). Ha curato i volumi Contro l’infelicità. L’Internazionale Situazionista e la sua attualità (Ombre Corte, 2014) e Religione/arte/rivoluzione, anche (Massari Editore, 2020). Collabora stabilmente con le riviste “Frequenze Poetiche”, “Segno” ed “OperaViva Magazine”.