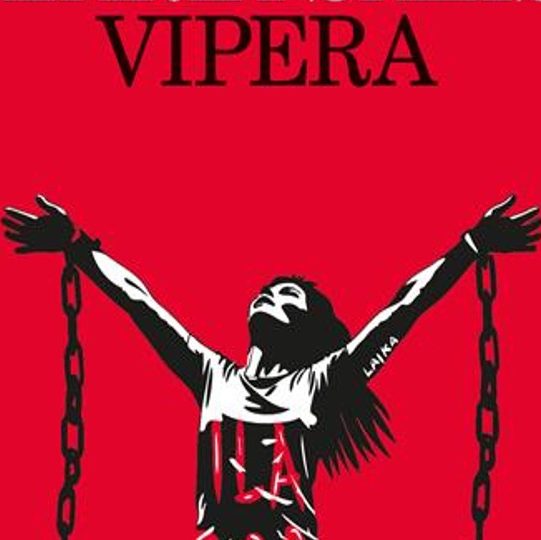Lo scorso ottobre la plenaria di Strasburgo ha confermato l’immunità parlamentare di Ilaria Salis. Il risultato del voto è stato la risposta negativa alla richiesta di revoca delle autorità ungheresi che avrebbero voluto il ritorno in carcere della eurodeputata di AVS (Alleanza Verdi Sinistra). Richiesta avente il chiaro sapore di un regolamento di conti evidentemente lasciati in sospeso, suo malgrado, dalla giustizia ungherese, che aveva tenuto Ilaria in carcere per quindici mesi di detenzione dura, di udienze che l’avevano vista comparire di fronte ai giudici con le catene ai polsi e alle caviglie.
La storia di questa assurda detenzione preventiva, che è stata già di per sé stessa una condanna, è raccontata dalla protagonista in “Vipera” (Ilaria Salis, Feltrinelli, 2025, 224 pagine) ed è iniziata con l’arresto avvenuto a Budapest nel febbraio del 2023 e motivato dall’accusa di partecipazione al pestaggio di due militanti neonazisti intenti a rendere omaggio ai loro “eroi” nel “Giorno dell’Onore”. Una celebrazione, quest’ultima, che ogni anno si tiene a febbraio nella capitale ungherese per ricordare la “valorosa resistenza” dei militi nazisti tedeschi e dei loro alleati ungheresi durante l’assedio di Budapest svoltosi fra il dicembre del 1944 e il febbraio successivo.
Se il “Giorno dell’Onore” è tollerato dal governo di Viktor Orbán non altrettanto può dirsi delle manifestazioni antifasciste che dall’esecutivo danubiano e dai suoi sostenitori vengono considerate nient’altro che pericolose provocazioni di facinorosi e violenti.
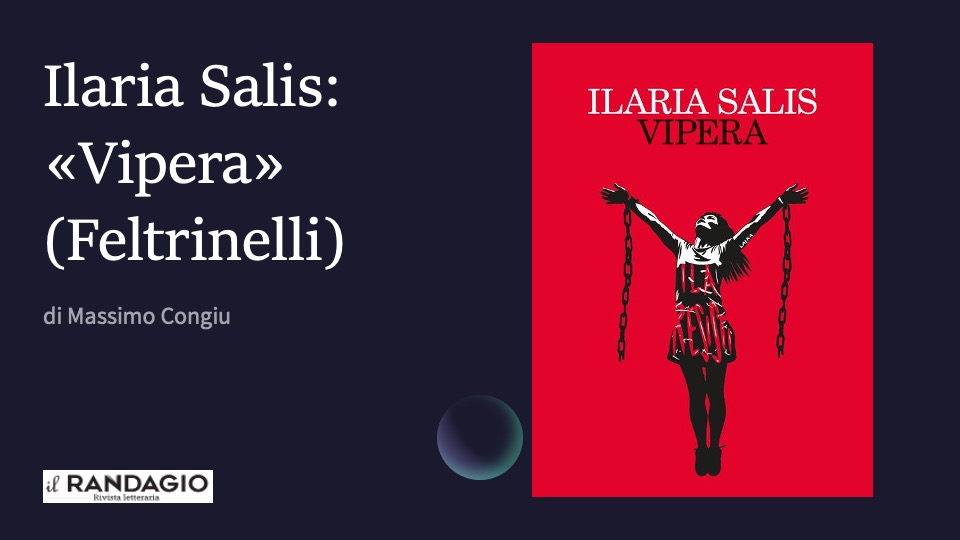
Così Ilaria è finita nel mirino delle autorità giudiziarie di quel paese e ha dovuto subire una detenzione disumana lunga e inaccettabile, espressione di un sistema che considera le pene come strumenti esclusivamente punitivi e afflittivi, volti a piegare il ristretto e a privarlo della sua dignità. Da considerare che tutto ciò è avvenuto senza che vi fosse uno straccio di prova a sostegno dell’accusa rivolta all’autrice del libro. Accusa che parla di ferite gravi, addirittura potenzialmente mortali, in realtà guarite in sei-otto giorni. È l’inizio dell’incubo, dell’assurdo che diventa realtà e che viene narrato in sette capitoli densi, coinvolgenti, scritti in prima persona ma dedicati a chiunque subisca la privazione della libertà in maniera ingiusta o perché innocente o per condizioni di detenzione da considerare intollerabili: scarsa igiene, poca luce, sovraffollamento, privazione di diritti fondamentali. “Vipera” è quindi una voce che si leva per denunciare queste brutture che sovente caratterizzano la realtà carceraria, non solo quella ungherese, e che sottolinea lo stato di angoscia e il senso di abbandono diffusi fra i detenuti, con particolare valenza per quanti si ritrovano a scontare pene all’estero, senza poter contattare i propri cari, senza agevolazioni che in qualche modo superino le barriere linguistiche.
Il libro è anche il racconto di una vicenda che trasuda umanità, fatta di quotidianità dietro le sbarre, in poco spazio umido e poco illuminato da condividere con altre ristrette che hanno alle spalle storie pesanti. Donne finite nelle maglie di un sistema brutale cui si deve la trasformazione degli istituti di pena in discariche sociali e l’illusione dispensata all’opinione pubblica, alla gente, che c’è chi veglia sulla sua incolumità. È il refrain di certa retorica securitaria di cui abbiamo esempi chiari anche qui da noi che subiamo gli effetti di un’involuzione autoritaria degna di andare a braccetto col sistema di Viktor Orbán e, anzi, fiera di questo parallelismo.
“Vipera” è una storia di resistenza che descrive soprusi visti e subiti; l’autrice lo fa con un approccio privo, comunque, di livore; la sua denuncia è colma di voglia di giustizia, di lotta contro qualsiasi forma di potere che criminalizzi la povertà, tolleri o addirittura incoraggi l’emarginazione sociale e tenda a punire in modo “esemplare” i reati commessi da gente che ha perso la speranza non certo per distrazione o per recare noia ai cosiddetti benpensanti. Nella testimonianza di Ilaria Salis c’è il tunnel ma anche la luce in fondo, guadagnata dopo un percorso di sofferenza e angoscia sì, ma anche di speranza tenace, sorretta da ideali e amore per la vita.
Oggi l’autrice del libro si dedica ai problemi del carcere da eurodeputata, visita gli istituti di pena italiani, incontra i detenuti, denuncia le gravi carenze del nostro sistema penitenziario e, memore della sua esperienza, cerca di tenere alto il livello dell’attenzione sul caso di Maja T. Inspiegabilmente estradata dalla Germania, suo paese d’origine, Maja è ancora in carcere in Ungheria, accusata dello stesso reato, e rischia una pena sproporzionata a 24 anni di carcere. Non va lasciata sola.
Massimo Congiu

Massimo Congiu: giornalista, laureato in Scienze storiche all’Università Federico II, studioso di geopolitica dell’Europa centro-orientale, ha vissuto a lungo a Budapest. Scrive per il Manifesto, MicroMega, Diritti Globali, Radio Mir, Fondazione Feltrinelli, ha collaborato a L’Humanité e a Historia Magistra. È curatore dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo, membro del Comitato Scientifico del Cespi, è autore di diversi libri e saggi di analisi storico-politica e di indagine sociale. Dal 2020 si occupa anche di carcere e collabora all’Osservatorio regionale sulla detenzione presso l’Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti della Regione Campania e collabora al progetto Parole in libertà che si svolge negli istituti di pena di Poggioreale e Secondigliano. Con 4Punte Edizioni, nel 2023, ha pubblicato Quattro Giornate di Napoli. Le periferie della Resistenza e, nel 2024, Giacomo Matteotti. L’assassinio, il processo-farsa, la cancellazione della memoria. Sempre nel 2024, è uscito per Feltrinelli La protesta è l’anima. La lotta della società civile in Ungheria e Polonia.