La polemica esplosa intorno alla richiesta del Ministero della Difesa di attivare un corso universitario di filosofia riservato ai militari presso l’Università di Bologna non è un incidente marginale né un conflitto locale. È il sintomo di qualcosa di ben più profondo: una tensione crescente tra l’autonomia dell’università e la volontà di alcuni apparati dello Stato di appropriarsi delle scienze umane per plasmarle a fini di legittimazione.
Che un’università pubblica abbia rifiutato di organizzare un corso chiuso, cucito su misura per un corpo armato, rientra perfettamente nella sua funzione istituzionale: difendere la propria libertà didattica e la natura pubblica del sapere. Invece il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha reagito con un attacco violento e sproporzionato, accusando l’ateneo di ideologismo, mancanza di senso dello Stato, persino di irresponsabilità. Una “sparata”, non trovo parola più adatta, che rivela un’idea distorta e pericolosa del rapporto tra potere esecutivo e autonomia accademica.
Per capire perché questo episodio sia così inquietante, occorre riflettere sul nodo centrale: la filosofia e l’apparato militare non sono due universi che possono convivere armonicamente. La filosofia non è un modulo di formazione professionale, né un camice morale che si indossa per nobilitare un mestiere. È un sapere critico, che interroga le strutture del potere, smaschera la retorica della violenza legittima e mette costantemente in discussione l’obbedienza, la sovranità, le narrazioni ufficiali. È un luogo di esposizione al dubbio, alla contraddizione, alla libertà interiore.
Le forze armate sono, per struttura, l’esatto contrario: un dispositivo che richiede disciplina, gerarchia, compattezza, sospensione del giudizio individuale. Il loro fine istituzionale è l’esercizio della violenza legittima dello Stato. In nessun momento della vita militare, né nella formazione né nell’azione, c’è spazio per la dialettica del pensiero come forma di liberazione. L’obbedienza è un valore, non un problema; la gerarchia è un principio, non un oggetto di discussione. L’ordine non si discute: si esegue.
È evidente che un sapere come la filosofia, se preso sul serio, è incompatibile con la logica dell’apparato armato. O si neutralizza il pensiero critico, o si mette in crisi l’istituzione militare. I corsi ad hoc servono proprio alla prima operazione.
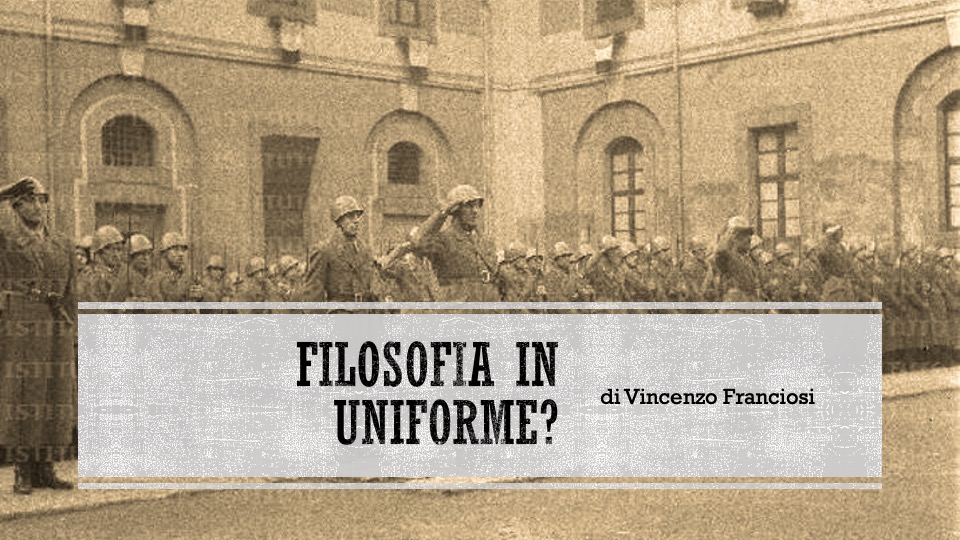
Molte delle giustificazioni circolate in questi mesi parlano di “umanizzare” i militari, di renderli più consapevoli, più attenti ai diritti, più sensibili ai valori democratici. Ma questa retorica, apparentemente nobile, è profondamente ingannevole. La filosofia non nasce per umanizzare la violenza: nasce per smascherarla. Usarla come strumento di legittimazione morale di un apparato fondato sull’obbedienza e sulla forza significa rovesciarne la funzione. Un apparato armato non diventa più umano perché alcuni suoi membri ascoltano lezioni di filosofia, ma rimane ciò che è: un dispositivo che necessita, per funzionare, di ridurre il nemico a figura astratta, di sospendere la piena riconoscibilità dell’altro come persona, di trasformare l’obbedienza in virtù. Le scienze umane non mutano questa natura. Al massimo, la velano sotto un linguaggio colto.
Perché allora gli alti gradi militari insistono tanto su percorsi umanistici dedicati? Le ragioni sono strutturalmente politiche. Da un lato, c’è un bisogno di legittimazione simbolica: un ufficiale che può esibire crediti o titoli ottenuti in una prestigiosa università pubblica appare immediatamente più autorevole, più colto, più “civile”. È un capitale d’immagine che fa comodo. Dall’altro, c’è la volontà di costruire una nuova élite in uniforme, capace di muoversi con disinvoltura nei contesti civili, nei media, nella diplomazia. Una élite culturalmente presentabile, ma pienamente integrata nella logica gerarchica.
E poi, forse l’aspetto più decisivo, l’apparato militare cerca cultura, ma solo in forma controllata. Il contatto reale con il pensiero filosofico è pericoloso; genera dubbi, incrina certezze, apre conflitti interiori. La filosofia autentica non addestra: disobbedisce, insegue domande radicali, mette in crisi. È un rischio troppo grande.
Per questo i vertici militari non chiedono ai loro ufficiali di frequentare i normali corsi universitari insieme agli studenti civili. Chiedono percorsi separati, filtrati, schermati. Un ambiente sotto controllo, in cui i temi più critici possono essere modulati, attenuati, elusi. Dove non ci siano discussioni imprevedibili, né studenti disposti a dire ciò che un apparato armato non vuole sentirsi dire.
Il punto è proprio questo: il vero pericolo, per le forze armate, è il confronto con gli studenti civili.
Perché in un’aula universitaria reale l’ufficiale può trovarsi faccia a faccia con chi è pacifista o antimilitarista, con chi mette in discussione l’autorità statale, con chi non accetta come naturali parole come “nemico” o “missione”, con chi rifiuta la retorica dell’obbedienza come valore assoluto, con chi proviene da zone di guerra (si pensi, ad esempio, agli studenti palestinesi che sono riusciti ad arrivare in Italia con una borsa di studio universitaria).
In quel confronto il pensiero critico non è più astratto, ma diventa vivo, conflittuale. Ed è lì che l’istituzione militare vacilla. La filosofia non è più un ornamento: torna a essere pericolosa. La filosofia genera domande a cui la logica dell’uniforme non può rispondere senza incrinarsi: perché obbedire? che cos’è un dovere? che cosa legittima la violenza? cosa significa uccidere in nome dello Stato? I corsi ad hoc nascono precisamente per evitare tutto questo: non proteggono l’università dai militari, ma proteggono i militari dall’università.
Il comportamento degli atenei che hanno accettato di discuterne è stato spesso giustificato con formule generiche: Terza Missione, innovazione formativa, dialogo con il territorio, allineamento agli standard internazionali, formazione continua della Pubblica Amministrazione. Ma sono argomenti fragili. La Terza Missione riguarda la società civile, non i corpi armati. L’innovazione non consiste nel costruire percorsi chiusi per una categoria privilegiata. L’internazionalizzazione non giustifica la sospensione dei principi fondamentali dell’università. E la formazione dei dipendenti pubblici non può essere un alibi per trasformare la filosofia in un’appendice dell’apparato militare.
In questo contesto, la reazione di Crosetto all’Università di Bologna è stata particolarmente grave. Non perché un ministro non possa esprimere un’opinione, ma perché ha attaccato l’ateneo come se esso dovesse obbedienza alle forze armate. Ha insinuato che il rifiuto del corso fosse un tradimento dello Stato, una mancanza di senso civico. È l’affermazione implicita, ma chiarissima, che l’università debba servire l’apparato militare, non interrogarlo; che la cultura debba collaborare con la forza, non criticarla, che la filosofia debba legittimare, non disturbare. Un ministro della Difesa che rimprovera un’università pubblica perché non vuole piegare la propria offerta formativa a una richiesta delle forze armate compie un gesto che, in una democrazia matura, dovrebbe essere riconosciuto come profondamente inaccettabile. È un segnale sinistro, anzi, “destro”, soprattutto perché attacca proprio ciò che distingue una democrazia da uno Stato autoritario: il primato del sapere critico sul potere esecutivo, la libertà dell’università, la separazione tra cultura e apparato armato. Il nodo non riguarda solo un corso di filosofia, ma riguarda la domanda fondamentale: che cosa deve essere l’università? Un luogo di pensiero libero, aperto, conflittuale, dove civili e militari, se lo desiderano, studiano insieme da pari? Oppure un fornitore di servizi culturali da cui il potere può comprare legittimazione morale? La risposta, se vogliamo difendere la democrazia, dovrebbe essere evidente. L’università non può e non deve proteggere i militari dalla filosofia. E la filosofia non deve e non può essere messa in uniforme.
Vincenzo Franciosi

Vincenzo Franciosi è professore associato di Archeologia Classica. Ha scavato in vari siti dell’Italia meridionale quali Fratte (SA), Buccino (SA), Montescaglioso (MT), Pompei (NA). Ha pubblicato studi sulle importazioni ceramiche corinzie di età geometrica nell’isola d’Ischia e sulle loro imitazioni locali; sulla ceramica figurata attica del V sec. a.C.; sull’urbanistica pompeiana e sugli scavi dell’insula VII, 14 a Pompei; sul culto della Mefite in Valle d’Ansanto; sulla statuaria arcaica in marmo dall’Acropoli di Atene; sulla statuaria in bronzo dalla Villa dei Papiri ad Ercolano; sulla statuaria policletea. È stato insignito, per l’insieme degli studi e delle indagini condotti nel campo dell’Archeologia Classica, del Premio Anassilaos 2020-21 (XXXII-XXXIII) “Arte, Cultura, Economia, Scienze” – Premio Μνήμη per l’Archeologia, Reggio Calabria, 13 Novembre 2021.

